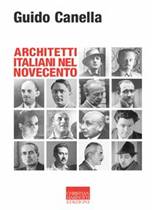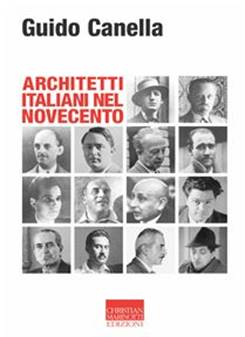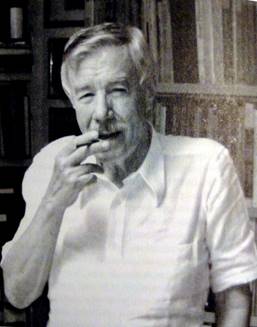|
|
|
|
|
||
|
|
autore |
GUIDO CANELLA |
|
|
titolo |
ARCHITETTI ITALIANI NEL NOVECENTO |
|
|
|
editore |
CHRISTIAN MARINOTTI |
|
|
|
luogo |
MILANO |
|
|
|
anno |
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
lingua |
ITALIANO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Argomento e tematiche affrontate |
|||
|
|
“Architetti
italiani nel Novecento” affronta il tema dello sviluppo dell’architettura
italiana a partire dall’Eclettismo ottocentesco fino al secondo dopoguerra,
attraversando dunque un periodo difficile non solo per la politica e
l’economia internazionali, ma anche per l’architettura, e per l’arte in
generale influenzata dalla realtà di quegli anni. Il libro non è l’opera di
uno storico, ma di un professionista dell’architettura che ha la passionalità
e l’entusiasmo di chi è partecipe e direttamente protagonista di quel
periodo. |
||
|
|
|||
|
Giudizio
Complessivo: 7 (scala 1-10) |
|||
|
Scheda compilata da: Denis Hnatyuk |
|||
|
Corso di Architettura e Composizione Architettonica 3 a.a.2015/2016 |
|||
|
|
|||
|
|
Autore Guido Canella |
||
|
Nato a Bucarest nel 1931, e scomparso a Milano nel
2009, Canella è stato uno dei protagonisti più importanti e originali
dell’architettura italiana del dopoguerra. Alla pratica di architetto, autore
di capi d’opera riconosciuti degli ultimi decenni, ha sempre affiancato la
riflessione teorica, l’attività di organizzazione culturale, la ricerca e
l’insegnamento universitari. Docente presso la Facoltà di Architettura del
Politecnico di Milano, è stato direttore delle riviste “Hinterland” e “Zodiac”. Nominato Professore Emerito al termine della sua
carriera universitaria al Politecnico di Milano nel 2006 e presidente
dell’Accademia Nazionale di San Luca. |
|||
|
Guido Canella |
|||
|
|
|||
|
Contenuto |
|||
|
“Architetti italiani
nel Novecento” è l’ultimo libro dell’arch. Guido Canella “Architetti italiani
del novecento”, a cura di Enrico Bordogna. E’ una raccolta di saggi scritti
da Canella suddivisa in tre parti principali; nella prima parte del libro
l’autore ci presenta un quadro generale dello sviluppo dell’architettura
italiana tra la seconda parte dell’Ottocento e il secondo Dopoguerra; la
seconda e la terza parte invece, presenta una descrizione biografica di quattordici
architetti “simbolo” dell’architettura italiana di quei anni, scelti
dall’autore secondo la sua ottica di architetto progettista e di critico. |
|||
|
|
|||
|
CAPITOLI |
|||
|
Parte Prima – Dal modernismo al razionalismo |
|||
Il concetto della “Città moderna” nasce in Italia soltanto nella metà
dell’Ottocento, in parallelo con L’unità d’Italia e l’industrializzazione del
Nord. In questo periodo, con l’aumento della produzione industriale,
della facilitazione del lavoro e della
formazione di una nuova maestranza, si instaura il pensiero di un
insediamento più razionalizzato, modernamente funzionale e non frammentario.
L’architettura moderna italiana del Novecento può essere considerata
come l’esito dell’incontro tra alcune istanze d’avanguardia futurista e
l’esempio dell’architettura estera, come quella europea. L’arte , dunque,
influenza fortemente l’architettura ma anche e soprattutto quella degli
interni.
L’architettura moderna italiana del periodo fascista è fortemente
influenzata dall’deologia polittica. Infatti gli architetti più celebri come
Giuseppe Terragni e Giuseppe Pagano aderirono al partito fascista con la
speranza, condivisa con gli altri colleghi, di vedere l’architettura moderna
come quella di Stato. Il Razionalismo italiano vive la realtà politica
novecentesca divisa tra le idee fasciste e quelle antifasciste. 4. Figura e funzione
nell’architettura italiana dal dopoguerra agli anni Sessanta (1980) La ricerca dell'innovazione architettonica in Italia fu stimolata
dall'arretratezza rispetto all'Europa, che si trova con un passo in avanti,
nel campo industriale, edilizio, eccetera durante il fascismo, comporta la
richiesta da parte della committenza privata e pubblica di qualsiasi settore
di diversi architetti che fecero crescere Italia dal punto di vista
architettonico. |
|||
|
|
|||
|
Parte Seconda – Tra le due guerre |
|||
E’ difficile o forse improprio associare la poetica di Sant’Elia al
movimento Futurista, ma è altrettanto difficile svalutare la caratura di
morale rivolta al futuro che pervade tutta la sua opera matura. Negli anni
precedenti e quelli dopo la Prima Guerra Mondiale si presumeva l’arrivo di un
nuovo ordine che l’industrialismo avrebbe imposto alle contraddizioni delle
città e che nei paesi più sviluppati d’europa aveva già preso piede: dalla
Cité Industriel di Garnier alla Grossstadt di Wagner, mentre nei paesi più
arrettrati, come Italia, acquisi solo aspetti scenografici. Le opere di Sant’Elia si avvalgono di caratteri soggetti e specifici
dell’architettura, pur con quelle inclinazioni e suggestioni critici simili a
quelli dei primi futuristi, ma che si estende oltre il movimento futurista. Il tma dominante nella poetica di Sant’Elia è un rapporto
trainfrastrutturazione metropolitana e abitabilità fluida, una sorta di
non-tema.
Preside della Facoltà di architettura del Politecnico di Milano e
docente del corso di composizione architettonica negli anni Cinquanta. Un bravo disegnatore quasi come Tomaso Buzzi e dotato nella composizione
tanto quanto Ponti, ha una personalità più incerta, riservata e anche
orgogliosa che lo ha sempre frenato nel seguire i gusti innovativi a
differenza di Ponti , curioso ad interpretare i nuovi gusti. Rimane a stretto
contatto con diversi architetti neorazionalisti come Muzio, Ponti e Rogers
sia come colleghi sia come collaboratori. Insieme a loro, con giudizio e
filtro Art Nouveau, al modernismo rimanendo comunque un po’ diffidente e
cauto rispetto ai giovani brillanti. L’agnosticismo di Portaluppi portò alla formazione, nella scuola di
milano, di diverse generazioni ndi razionalisti come Albini, Asnago e Vender,
Bottoni, Figini, Pollini, Terragni, BBPR, Caccia Dominioni, Cattaneo,
Magnaghi e Terzaghi, Zanuso e quelli dopo.
L’architetto tutt’ora molto criticato ha influito molto sull’autore
Canella come una sorte di “maestro a distanza”. De Finetti risulta mosso da
un’innata inclinazione al realismo che lo induce a impostazioni progettuali
differenti a seconda delle scale di intervento: dagli arredamenti interni
alle parti di città. Egli lavora molto sul tema della ricostruzione di Milano
nel dopoguerra dopo i bombardamenti.
Giovanni Muzio fu impegnato nella progettazione di edifici pubblici con
una brillante capacità nell’uso del cotte e del suo derivato klinker,
concludendo la sua carriera con la realizzazione del Palazzo Isimbardi. Le opere come la piazza della Repubblica e il Palazzo della Triennarle
conferiscono all’autore la cittadinanza nel Razionalismo lombardo. Nel
costruire la città, Muzio riposta l’illusione che la classe dirigente possa
tornare alla magnificienza dell’età neoclassica, la corrente da riscoprire e
valorizzare. Nelle sue opere è evidente l’ispirazione nel motivo ad archi
vuoti impiegati nel cortile dell’università Cattolica di Milano e nel
convento dell’Angelica. Perdute le speranze di rivedere la tessitura
neoclassica, Muzio si immedesima nel mimetismo bramantesco rassegnato a
rimisurare il paesaggio urbano.
Canella parla di Buzzi da ex studente di architettura avendolo avuto
come docente di disegno al Politeclico di Milano. Egli ebbe una personalità
autorevole, prestigiosa e severa. Buzzi concepì e costruì la città teatro a Scarzuola
come personale interpretazione della città ideale. Egli pratica
principalmente la progettazione delle villette, dei giardini e l’arredamento.
Lo sviluppo dell’architettura moderna avviene principalmente in due
città italiane: Milano e Torino. Persico, originario di Napoli, entra a contatto con le teorie
antifasciste. Trascorre a torino il periodo più cupo della suo breve vita. A
partire dagli anni Trenta del Novecento si occupa della redazione di
“casabella”, dove ebbe un approcio figurativo iniziale nell’impaginazione
graficacon l’aiuto di Marcello Ninoli (pittore – grafico). Insieme
allestiscono mostre e realizzano negozi.
La poetica di Terragni non è di facile interpretazione critica, in
quanto la storia dell'architettura moderna italiana in quegli anni è stata
notevole e Terragni stesso prese ispirazione da ideologie diverse e che vede
la sua poetica tesa tra fede e militanza. Scorrendo le opere di Terragni si
percepisce alternato variare, opera per opera, dei motivi di ispirazione dell'architetto
Comasco . Nel periodo fascista, con la Casa del Fascio, la tecnica
compositiva di Terragni e ormai evoluta: dove per la prima volta viene
impiegato il grande telaio che coinvolge il chiaroscuro degli Interni e la
luce naturale dall'alto. In caso di Terragni la composizione non progredisce
dalla pianta, ma da un gioco di incastri sovrapposizione e sottrazione di
volumi che da un integrità propria alla struttura. |
|||
|
|
|||
|
Parte Terza – La revisione del dopoguerra |
|||
Durante le
due guerre del Novecento pratica nel gruppo BBPR. Docente per un breve
periodo al Politecnico di Milano. Importante esponente del movimento moderno.
Giuseppe
Samonà viene presentato come un grande saggista delle diverse generazioni di
architetti che hanno operato prima e dopo la seconda guerra. Egli viene
definito una saggista non soltanto per gli innumerevoli scritti prodotti ma
anche per il suo procedere compositivo, proprio nel suo eclettismo assume una
valenza saggistica.
Il
razionalismo di Ridolfi emerge soprattutto nella realizzazione
dell'abitazione Borghese. Ne è un esempio le due palazzine romane in Villa
Massimo in via San Valentino, realizzate negli anni 30 . Anche
Ridolfi ha un periodo in cui predomina la matrice classica. Cio’ si vede dai
progetti di chiesa al concorso di Messina, ma egli preferisce di gran lunga
il tema pubblico e collettivo come il palazzo postale in Piazza Bologna a
Roma e concorsi come la civiltà italiana, forze armate, e i palazzi del
Littorio in cui si nota il distacco dal classicismo e la volontà del
progredire nel modernismo.
Gardella
compie studi classici e si laurea in ingegneria. L'esordio
pubblico di Gardella avviene con la ristrutturazione del Teatro Sociale di
Busto Arsizio. l'architettura
di Gardella non segue gli standard convenzionali del funzionalismo ma hanno
una propria autonomia figurativa. Nell'architettura di Gardella Persico vede
una particolare via italiana al Razionalismo, poiché il Razionalismo italiano
compie un percorso notevolmente anomalo rispetto a quello centreuropeo.
Albini ha
uno stile lineare nella progettazione di esposizioni, mostre, negozi,
arredamenti. Questo stile lineare passa a quello plastico quando Albini
decidi di usare i tessuti non solo come rivestimenti, ma ormai per modellare
l'ambiente. Riesce a superare la difficoltà della progettazione degli edifici
quando si trova libero del rispetto del contenitore e riesce finalmente fare
una sintesi tra forma luce e colore.
Decarli sì
dedica al design degli interni producendo un grande numero di mobili moderni. La
modernità di Decarli impressa nell'architettura si nota perfettamente nel
teatro Sant’Erasmo: l'ottagono di partenza passa per un allargamento vibrato
che richiama Aalto o certo empirismo nordico, per poi concludersi teso in
spazio aerodinamico. Si distacca dal naturalismo per incorporare
l'artificiale organicità.
|
|||
|
|
|||