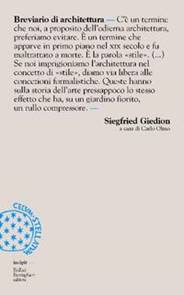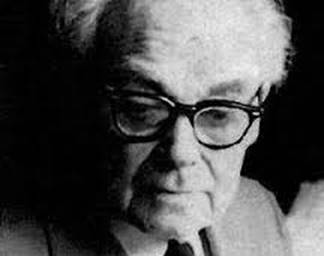|
|
|
|
|
||
|
|
autore |
SIEGFRIED GIEDION |
|
|
titolo |
BREVIARIO DI ARCHITETTURA |
|
|
|
editore |
BOLLATI BORINGHIERI |
|
|
|
luogo |
TORINO |
|
|
|
anno |
2008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
lingua |
ITALIANO |
|
|
|
|
|
|
|
|
Titolo originale:
Siegfried Giedion,Architektur und Gemeinschaft, Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbek, 1956 |
|
||
|
|
|
||
|
Argomento e tematiche affrontate |
|||
|
|
Il libro,
diventato oggi un classico della storia dell’architettura, è una sorta di
diario in cui Giedion analizza, con la passione
dell’osservatore immerso nel suo tempo, le nuove tendenze dell’architettura e
dell’urbanistica in seguito allo sviluppo sociale e tecnologico. Egli
propone, quasi utopisticamente, una città del futuro, una città umanizzata
sia negli spazi abitativi che in quelli della vita associativa e capace di
soddisfare i bisogni estetici e sentimentali dell’individuo e della comunità. |
||
|
|
|||
|
Giudizio
Complessivo: 7 (scala 1-10) |
|||
|
Scheda compilata da: Silvia Oberti |
|||
|
Corso di Architettura e Composizione Architettonica 3
a.a.2014/2015 |
|||
|
|
|||
|
|
Autore Siegfried Giedion |
||
|
Siegfried Giedion ( 1888-1968 ) si laureò in ingegneria a Vienna
nel 1913; studiò poi storia dell’arte a Monaco con Heinrich Wolfflin. Amico intimo di Le Corbusier,
fu tra i fondatori dei CIAM, dei quali fu anche segretario generale. Insegnò
al MIT e alla Harvard University, dove divenne
direttore del Dipartimento di Architettura della Graduate School of Design. I
suoi numerosi libri hanno avuto una grande influenza, in particolare : Spazio, tempo e architettura (Hoepli,
Milano 1954); L’era della
meccanizzazione (Feltrinelli, Milano 1967); Walter Gropius, l’uomo e l’opera
(Comunità, Milano 1954); L’eterno presente (Feltrinelli, Milano 1965); Architettura e il fenomeno del cambiamento
(Flaccovio, Palermo 2002) |
|||
|
Siegfried Giedion |
|||
|
|
|||
|
Contenuto |
|||
|
Il libro inizia
analizzando le possibilità per osservare la realtà (dall’esterno o
dall’interno), concludendo che è necessario pronunciare giudizi radicati nel
proprio tempo. Nei capitoli successivi l’autore affronta svariati temi :
dalla perdita del sentimento e del contatto degli artisti con il grande
pubblico al tema della monumentalità, dai valori estetici e spirituali al
rapporto dell’uomo con la città e il suo “core”, per giungere infine ad una
riflessione sul tema dell’immaginazione, argomentato con una serie di
esemplificazioni pratiche (progetti del suo tempo). Il libro è
organizzato in due sezioni : “Principi Figurativi” e “La formazione di una
nuova coscienza collettiva” e ciascuna di esse è suddivisa in capitoli. |
|||
|
|
|||
|
CAPITOLI |
|||
|
Capitolo 0- Introduzione |
|||
|
L’autore distingue le due possibilità che esistono per ossevare il proprio
tempo : dall’esterno, tramite un atteggiamento inquisitorio che sfrutta un
codice di giudizio appartenente a un’epoca ormai sorpassata oppure
dall’interno, basandosi sulla convinzione che per comprendere qualsiasi
fenomeno bisogna giudicarlo col suo proprio metro. Bisogna dunque saper pronunciare giudizi radicati nel proprio tempo. Si evidenzia inoltre quello che è ritenuto il maggior problema odierno :
l’abisso che si determina tra un pensiero (artistico) molto progredito e una
sensibilità arretrata (del committente). Solo se si riesce a superare questo
dislivello si possono individuare i “creatori” più capaci. |
|||
|
|
|||
|
Capitolo I – Del gusto dominante |
|||
|
Il capitolo inizia con una provocazione : gli artisti sono ancora necessari
? L’arte ha oggi, senza dubbio, perso il suo significato ed è stata assorbita
dalla vita, ne è la prova il fatto che un artista non riesca più a mantenersi
con il suo lavoro. Tutto questo è conseguenza del fatto che l’arte
(ufficiale) ha perso il sentimento, e il sentimento è necessario per l’uomo :
ogni persona pretende un ambiente che sia specchio del suo stato interiore.
L’artista perde dunque il contatto col grande pubblico e tale avvenimento
coincide con l’abbandono del naturalismo e con l’industrializzazione. Da quel
momento l’artista per garantirsi la sopravvivenza si converte (nella maggior
parte dei casi) ad un’arte destinata al pubblico, un’arte “volgare” e
prodotta in gran quantità. Solo pochissimi pittori si dedicano alla ricerca e
alla scoperta, allontanandosi sempre più dal gusto di pubblico, critica,
collezioni. Mentre l’arte ufficiale, quella delle mostre, delle accademie,
giace ora “nascosta nelle cantine delle nostre abitazioni”, le opere degli
artisti-inventori, allora esiliati dal pubblico, vengono oggi richieste dai
musei più prestigiosi. |
|||
|
|
|||
|
Capitolo II- Una nuova monumentalità |
|||
|
L’autore qui illustra e argomenta i “9 punti sulla monumentalità”, redatti in collaborazione con Josè Luis
Sert e Fernand Leger, per l’associazione American Abstract Artists. 1- I monumenti sono pietre miliari con cui gli uomini hanno creato simboli
dei loro ideali, delle loro mete, delle loro azioni. Essi rappresentano
un’ereditàper le generazioni future e costituiscono un nesso tra passato e
futuro. 2- I monumenti sono espressione delle più alte necessità culturali
dell’uomo. Essi devono soddisfare l’eterna aspirazione del popolo a tradurre
in simboli la sua energia collettiva. I monumenti “vivi” sono quelli che
esprimono questa forza collettiva. 3- Ogni epoca passata che abbia fatto maturare questa vera vita culturale
ebbe l’energia e la capacità di creare questi simboli. 4- Gli ultimi cento anni furono testimoni della svalutazione della
monumentalità a “pseudomonumentalità”. I cosiddetti “monumenti” creati non
racchiudono lo spirito e il sentimento collettivo del tempo moderno. 5- Questa decadenza e questo abuso della monumentalità sono la causa
fondamentale della diffidenza degli architetti moderni verso i monumenti. 6- Abbiamo dinnanzi a noi una nuova epoca di architettura che avrà come
conseguenza una nuova organizzazione della vita collettiva nella città, che
finora è stata trascurata. 7- Il popolo esige edifici che si adeguino al suo sentimento sociale e alla
sua vita comunitaria, che siano qualcosa di più che una realizzazione
funzionale. Deve esserci la partecipazione tra pittore, scultore, architetto,
urbanista. Chi governa i popoli, nel campo delle arti rappresenta il “gusto
tradizionale”. 8- I monumenti devono trovare la loro collaborazione nei piani regolatori.
Ciò sarà possibile quando i piani regolatori urbani avranno reso possibile la
creazione di spazi aperti nei centri ora caotici. In questi spazi
l’architettura monumentale troverà il posto che le compete. 9- Oggi disponiamo di materiali moderni e di nuove possibiltà tecniche. A queste condizioni l’architettura monumentale tornerebbe ai suoi fini
originari e ritroverebbe il suo contenuto lirico. |
|||
|
Capitolo III – I valori estetici e l’architettura |
|||
|
In questo capitolo l’autore sostiene la tesi secondo le quale lo scopo
dell’ambiente umano sia di guardare oltre ai valori utilitari e funzionali,
tenendo in conto valori estetici e spirituali. Essi sono inscindibili
dall’oggetto e ci condizionano sempre, consapevolmente o inconsapevolmente.
Oggi tuttavia le esigenze estetiche ed emotive sono ancora prigioniere delle
abitudini del secolo scorso a causa dell’arretrata educazione emotiva
dell’uomo, rimasta indietro rispetto al suo pensiero. Nella nostra epoca
sentire è più difficile che pensare, inventare, costruire. Ciò conduce a riflessioni nel campo dell’educazione, in particolare
quella del giovane architetto: egli deve sviluppare innanzitutto la
coordinazione, deve essere predisposto al teamwork, non deve per forza
conoscere a fondo nozioni di ogni campo del sapere (non avendo, così, la
padronanza di nessuno di essi), deve piuttosto sapere cosa chiedere agli
altri professionisti, deve conoscere la storia dell’architettura e i principi
che l’hanno guidata, deve avere capacità di sintesi. La perdita di questi
valori ha determinato la scissione tra arte, sentimento e realtà. Si affronta poi la grande rivoluzione del XX secolo : l’importanza del
piano in tutte le arti, dalla pittura (il cubismo, l’astrattismo…)
all’architettura ( Theo Van Doesburg, le strutture bidimensionali di
Maillart…). |
|||
|
Capitolo IV- L’uomo e le città |
|||
|
Si affronta qui il tema della struttura che, nelle
odierne condizioni di vita, deve assumere il quartiere residenziale “per evitare
che l’uomo si avvilisca sempre di più”. Dovrà esserci un accordo tra forma e funzione, tra
esigenza emotiva e articolazioni sociologicamente necessarie: anche il più
bel quartiere residenziale resta un’opera parziale se non possiede un cuore,
un luogo di collegamento tra vita privata e pubblica. Ciò significa ritorno
alla misura umana, alla considerazione dei diritti dell’uomo di fronte alla
tirannia della macchina. L’uomo, il cittadino, ognuno di noi ha senza dubbio il
desiderio di uscire dallo stato di pura passività dello spettatore non
partecipe alla vita della città; la spontaneità umana esiste nel popolo. È il bambino ad avere soprattutto bisogno di questo
risveglio della spontaneità assopita nell’uomo. Dovremmo prendere a esempio
le città antiche: l’agorà greca, luogo delle assemblee , luogo di ritrovo dei
cittadini, inserita in una città in cui regnava un preciso ordinamento sulla
base delle diverse funzioni; il foro romano, dove invece venivano unite
indiscriminatamente le istituzioni più diverse, dove regnava la confusione,
ma dove, nonostante tutto, il diritto dei pedoni, dei cittadini era
sacrosanto; le città medioevali che, dopo secoli di dacadenza, si sono
organizzate in un continuo intrecciarsi di vita pubblica e privata, in cui la
vita della città si svolgeva sulla strada. Come deve essere oggi il “core”, il cuore della città? È
un complesso creato artificialmente dalla mano dell’uomo, deve tener conto
delle mutevoli esigenze sociali, deve possedere elementi costanti nel tempo,
deve avere una planimetria flessibile e una chiara concezione spaziale.
L’architetto/urbanista deve riconoscere le esigenze dei suoi contemporanei
prima ancora che questi ne siano consapevoli, deve avere una immaginazione
sociale; egli deve sempre, prima di passare al progetto, studiare con grande
attenzione le abitudini di vita locali, il clima, con un atteggiamento di
nuovo regionalismo, per acquisire una consapevolezza della vita che si
nasconde nei contemporanei. |
|||
|
Capitolo V– Il desiderio di immaginazione |
|||
|
Il capitolo è incentrato sul tema dell’immaginazione. L’immaginazione è la radice di ogni pensiero creativo e di ogni
manifestazione creativa di un sentimento. Tuttavia all’architetto a volte è
impossibile utilizzare questo strumento per l’eccessiva standardizzazione
dell’industria. Un’altra ragione per cui l’immaginazione oggi è così rara è
la letargia sociale, l’abbandono della vita associata, il cuui desiderio
ricomincia a farsi sentire, insieme al bisogno di costruire ambienti adeguati
ad essa. L’immaginazione si esplicita in 2 modi: immaginazione sociale e
spaziale. Si giunge quindi a una domanda: quale dev’essere la struttura di
un’odierna città per superare l’isolamento dell’individuo e riaprire la
strada a un contatto con la comunità? Si analizzano quindi alcuni esempi: -
il centro
comunitario di Saint-Dié, città distrutta dalla guerra per cui Le Corbusier
progetta spazi di straordinario interesse: volumi indipendenti e tuttavia in
stretto rapporto tra loro ( non realizzato ). -
Unité d’habitation: l’immaginazione sociale prende forma
con un edificio che coniuga attrezzature individuali e collettive, abitazioni
e vita sociale. -
Alexander – polder – Rotterdam: coniuga diversi tipi di
abitazione raggruppate in unità di quartiere con spazi verdi e centri
comunitari. -
Centro commerciale/comunitario Back Bay Center, Boston:
un gruppo di architetti tra cui Walter Gropius progetta un centro in cui sono
ammessi solo i pedoni, con la conseguenza di annullare la necessità di
facciate sulla strada. -
Il Campidoglio di
Chandigarh: in esso Le Corbusier coniuga Oriente e cemento armato, con la
modellazione di superfici su livelli diversi, specchi d’acqua, colline
artificiali. Si affronta in seguito il tema della copertura, analizzato nella sua evoluzione
tramite una serie di esempi che partono dalla cupola come rappresentazione
dell’universo, fino alla sperimentazione dell’inizio del ‘900 , con strutture
sempre più sottili e leggere e alle cupole a guscio d’uovo per giungere alle
cupole concave verso l’interno, di cui un esempio può essere la Cappella di
Ronchamp di Le Corbusier. Essa viene analizzata nelle sue soluzioni formali e
strutturali, ma soprattutto in quanto simbolo e speranza di una svolta, di
una decadenza del “gusto dominante”, di una scomparsa della scissione tra
pensiero e sentimento. |
|||
|
Epilogo |
|||
|
Il quartiere residenziale con cellule d’abitazione non basta più, è
necessaria la casa di abitazione allargata, devono essere previsti dei centri
comunitari. -
Devono essere restaurati i
diritti del pedone -
Deve essere ripristinato il
contatto tra uomo e natura -
Le 4 funzioni
dell’urbanistica: lavoro, abitazione, traffico e riposo hanno perduto il loro
equilibrio -
È necessario disperdere i
compatti agglomerati urbani e devono sorgere piccole unità, commisurate in
base al metro umano -
È necessario differenziare le
abitazioni secondo i bisogni delle diverse età -
Architetti e urbanisti devono
avere la padronanza dei mezzi espressivi dell’artre moderna. |
|||
|
|
|||
|
GLOSSARIO |
|||
|
Monumentalità
– La monumentalità nasce dall’eterno bisogno degli uomini di
creare simboli per le loro gesta e il loro destino, per le loro convinzioni
religiose e sociali. Questa esgenze non può essere repressa; in tutte le
circostanze essa cerca sempre di manifestarsi. |
|||
|
Pseudomonumentalità – La pseudomonumentalità è presente anche nel nostro secolo e a nessun
sistema politico si deve fare questa imputazione in modo particolare. Non ha
nulla in comune con i suoi modelli e si affermò nella sfera della società
napoleonica. L’origine delle costruzioni pseudomonumentali può ritrovarsi in
schemi senza vita, in un’architettura cartacea. |
|||
|
Core – L’interesse
per il core fa parte del processo di umanizzazione: significa ritorno alla misura
umana, alla considerazione dei diritti dell’uomo di fronte alla tirannia
della macchina. Ci si domanda se sia possibile costruire reali cuori
cittadini nell’ambito della noastra cultura occidentale, finchè manca di una
ben delineata struttura sociale. |
|||
|
Nuovo
regionalismo – È lo studio rispettoso delle abitudini da parte
dell’architetto delle abitudini di vita, del clima, prima di passare al
progetto. Questo nuovo regionalismo mira quindi in primo luogo a soddisfare
le condizioni cosmiche e terrestri. |
|||