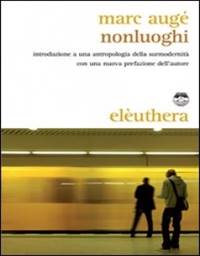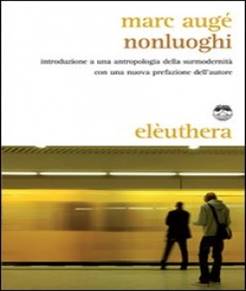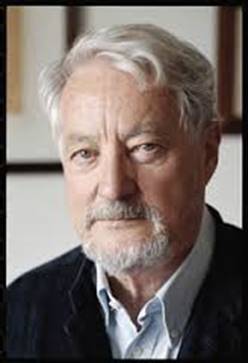|
|
|
|
|
||
|
|
autore |
Marc Augé |
|
|
titolo |
NONLUOGHI |
|
|
|
editore |
Eléuthera |
|
|
|
luogo |
MILANO |
|
|
|
anno |
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
lingua |
ITALIANO |
|
|
|
|
|
|
|
|
Titolo originale: Marc Augé, Non-lieux, 1992 Editions du Seuil |
|
||
|
|
|
||
|
Argomento e tematiche affrontate |
|||
|
|
Il libro
definisce, il concetto di nonluogo, termine coniato
proprio da Augè in questo suo saggio del 1992. I nonluoghi sono quegli spazi contrapposti ai luoghi antropologici,
quindi tutti quegli spazi che hanno la prerogativa di non essere identitari,
relazionali e storici. Sono tutti quegli ambiti adibiti alla circolazione, al consumo e alla
comunicazione. Agli occhi dell’autore,
questi nonluoghi sono spazi della provvisorietà e
del passaggio, spazi attraverso cui non si possono decifrare né relazioni
sociali, né storie condivise, né segni di appartenenza collettiva. I nonluoghi sono prodotti
della società della surmodernità, incapace di
integrare in sé i luoghi storici confinandoli e banalizzandoli in posizioni
limitate e circoscritte alla stregua di "curiosità" o di
"oggetti interessanti". I nonluoghi sono
incentrati solamente sul presente e sono altamente rappresentativi della
nostra epoca, che è caratterizzata dalla precarietà
assoluta, dalla provvisorietà, dal transito e dal passaggio e da un individualismo
solitario. Le persone transitano nei nonluoghi ma
nessuno vi abita. In altre parole, sono tutto il contrario della città storica nella
quale le regole di residenza, la divisione in quartieri, delimitava lo spazio
e permettevano di cogliere nelle loro linee essenziali le relazioni tra gli
abitanti. |
||
|
|
|||
|
Giudizio
Complessivo: 7(scala 1-10) |
|||
|
Scheda compilata da: Paolo Bottani |
|||
|
Corso di Architettura e Composizione Architettonica 3
a.a.2013/2014 |
|||
|
|
|||
|
|
Autore Marc Augè |
||
|
Marc Augè (Poitiers, 1935), antropologo, è directeur
d’ètudes (Logica simbolica e ideologia) all’Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales di Parigi, di cui è stato a lungo presidente.
Africanista di formazione, da anni si occupa di antropologia delle città
complesse. Le sue numerose ricerche
etnografiche in Africa,
soprattutto in Costa d'Avorio e Togo hanno prodotto
la pubblicazione dei suoi primi tre saggi (Le Rivage alladian, 1969; Théorie des pouvoirs et idéologie,
1975; Pouvoirs de vie, pouvoirs
de mort, 1977. In questi primi lavori, per descrivere l'oggetto della sua ricerca,
Augé ha coniato il termine idéo-logique. Ma è dalla
seconda metà degli anni 80, quando comincia a dedicare i suoi studi alla
teorizzazione di un’antropologia della Surmodernità, che lo porta a pubblicare i suoi saggi
più conosciuti, tra i quali: Un etnologo nel metrò, Non Luoghi, Che fine ha
fatto il futuro? Dai nonluoghi al nontempo, L’antropologia del mondo contemporaneo. |
|||
|
Marc Augé |
|||
|
|
|||
|
Contenuto |
|||
|
Il libro, il cui titolo completo è in realtà “Nonluoghi,
introduzione a una antropologia della surmodernità”
affronta l'analisi delle società attuali
attraverso i paradigmi della surmodernità, intesa
come evoluzione ulteriore rispetto al postmodernismo. Si tratta di un
testo strutturato in tre capitoli (Il vicino e l’altrove, Il luogo
antropologico, e Dai luoghi ai nonluoghi) -
prologo, epilogo. |
|||
|
|
|||
|
CAPITOLI |
|||
|
Capitolo I – Il vicino e l’altrove |
|||
|
Il primo capitolo segue a un breve prologo a carattere
narrativo in cui l’autore si serve di tal Pierre Dupont, che in italiano
corrisponderebbe a dire il signor Qualunque, il quale viene “seguito” per
poche ore dall’autore di cui se ne serve per introdurre la propria
antropologia della surmodernità. ll saggio vero e proprio inizia definendo la surmodernità,
l’epoca che stiamo vivendo, intesa come ulteriore evoluzione del
postmodernismo, fa riferimento ai fenomeni sociali, culturali, intellettuali
ed economici connessi allo sviluppo delle società complesse alla fine del XX
secolo, con particolare riferimento al superamento della fase postindustriale
e alla diffusione della globalizzazione. La condizione di surmodernità,
a causa delle sue stesse contraddizioni, offre un ottimo terreno di
osservazione e un ottimo oggetto alla ricerca antropologica. La surmodernità
è caratterizzata da tre figure dell’eccesso (o sovrabbondanza): -Sovrabbondanza di avvenimenti (eccesso di tempo) -Sovrabbondanza di spazio (eccesso di spazio) -Individualizzazione dei riferimenti (eccesso di ego) La difficoltà di pensare il tempo
deriva dalla sovrabbondanza di avvenimenti del mondo contemporaneo.
L’accelerazione della storia corrisponde a una moltiplicazione di avvenimenti
il più delle volte non previsti da economisti, storici o sociologi. La sovrabbondanza spaziale è
strettamente correlata al restringimento del pianeta nel senso che oggi,
grazie ai mezzi di trasporto, siamo in grado di raggiungere in poche ore
qualsiasi parte del mondo; inoltre nelle nostre case siamo continuamente
bombardati da immagini che ci danno una visione istantanea di avvenimenti in
atto all’altro capo del pianeta. La sovrabbondanza spaziale del presente si
esprime in mutamenti di scala, nella moltiplicazione dei riferimenti
immaginifici e immaginari e nelle accelerazioni dei mezzi di trasporto. Tutto
ciò comporta modificazioni fisiche considerevoli: concentrazioni urbane,
trasferimenti di popolazione e moltiplicazione dei “nonluoghi”
(in opposizione alla nozione sociologica di luogo, associata da Marcell Mauss e da tutta una
tradizione etnologica a quella della cultura localizzata nel tempo e nello
spazio). La terza figura dell’eccesso è la
figura dell’ego, dell’individuo. Quanto meno nelle società
occidentali l’individuo si considera un mondo in sé, egli si propone di
interpretare da se stesso per se stesso le informazioni che gli vengono date
o che percepisce dall’esterno. Mai come oggi le storie individuali sono state
così esplicitamente implicate nella storia collettiva ma allo stesso tempo
mai i riferimenti dell’identificazione collettiva sono stati così fluttuanti;
la produzione individuale di senso è dunque oggi più che mai necessaria. Agli antropologi si pone dunque
dinnanzi una nuova questione: comprendere come integrare nella loro analisi
la soggettività di coloro che osservano e come ridefinire le condizioni della
rappresentatività. Si definiscono “nonluoghi”
tutte le strutture necessarie alla circolazione accelerata delle persone e
dei beni (autostrade, svincoli, aeroporti), i mezzi di trasporto, i grandi
centri commerciali, i campi profughi… tutti gli spazi in cui milioni di
individualità si incrociano senza entrare mai in relazione, spinti dal
desiderio frenetico di consumare, di accelerare le operazioni quotidiane o
considerati come porta di accesso ad un cambiamento (reale o simbolico). |
|||
|
|
|||
|
Capitolo II- Il luogo antropologico |
|||
|
Marc Augé
definisce i “nonluoghi” in contrapposizione ai
luoghi antropologici. Il luogo antropologico è una costruzione
simbolica e concreta dello spazio che da sola non può rendere conto delle
problematiche e delle contraddizioni della vita sociale alla quale però si
riferiscono tutti coloro ai quali essa assegna un posto; il luogo
antropologico è allo stesso tempo un
principio di senso per coloro che lo abitano e un principio di
intelligibilità per colui che lo osserva. I luoghi antropologici possiedono
tre principali caratteristiche: -l’identitarietà -la
relazionalità -la
storicità La mappa della casa, le regole di
residenza, i quartieri di un villaggio, gli altari, i posti pubblici, la
divisione del territorio corrispondono per ciascun uomo ad un insieme di
possibilità, prescrizioni e interdetti il cui contenuto è allo stesso tempo
spaziale e sociale. Nascere significa nascere in un luogo, essere assegnato a
una residenza. In tal senso il luogo di nascita è costitutivo dell’identità
individuale. In generale il dispositivo spaziale è ciò che esprime l’identità
del gruppo (le origini del gruppo sono spesso diverse ma è l’identità del
luogo che lo fonda, lo raccoglie e lo unifica) ma è allo stesso tempo ciò che
il gruppo deve difendere contro le minacce esterne e interne perché il
linguaggio dell’identità conservi un senso (identità). In uno stesso luogo possono coesistere
elementi distinti e singoli ma di cui è impossibile negare le relazioni
reciproche e l’identità condivisa che conferisce loro l’occupazione di uno
stesso luogo comune. Così, per esempio, le regole di residenza che in molti
villaggi assegnano un posto al bambino lo situano in una configurazione di
insieme in cui egli condivide con altri “l’iscrizione” al suolo (relazione).
Storico il luogo lo è necessariamente dal momento in cui, coniugando identità
e relazione, esso si definisce da una stabilità minima; lo è nella misura in
cui coloro che vi vivono possono riconoscervi dei riferimenti che non devono
essere oggetti di conoscenza. Il luogo antropologico è storico per coloro che
lo vivono in quanto sfugge alla storia come scienza (storicità). Il luogo antropologico è anche
geometrico. Possiamo stabilire ciò partendo da tre forme spaziali semplici
che possono essere applicate a dispositivi istituzionali differenti e che
costituiscono le forme elementari dello spazio sociale: linea, intersezione
delle linee e punto d’intersezione. Concretamente possiamo parlare di
itinerari, di assi o sentieri che conducono da un luogo a un altro e che sono
stati tracciati da uomini, di crocevia in cui essi si incontrano e si
riuniscono, di centri più o meno monumentali, religiosi o politici, che
definiscono spazi e frontiere al di là dei quali altri uomini si definiscono
in rapporto ad altri centri e ad altri spazi. |
|||
|
Capitolo III – Dai luoghi ai nonluoghi |
|||
|
I non luoghi sono
incentrati solamente sul presente e sono rappresentativi della nostra epoca,
caratterizzata dalla precarietà (non soltanto lavorativa), dalla
provvisorietà, dal transito e dal passaggio, da un individualismo solitario.
Le persone transitano dai non luoghi ma nessuno vi abita. I luoghi e i “nonluoghi”
sono strettamente interrelati tanto che spesso è difficile distinguerli.
Raramente esistono in forma pura, in genere sono gli spazi dello standard, in
cui nulla è lasciato al caso e tutto al suo interno è calcolato con
precisione (il numero di decibel, la lunghezza dei percorsi, la frequenza dei
luoghi di sosta, il tipo e la quantità di informazione). I “nonluoghi” hanno assunto una valenza positiva e
rassicuratrice (si pensi al franchising, ossia alla ripetizione continua di
strutture commerciali simili tra loro in tutto il mondo): gli utenti non si
preoccupano del fatto che i centri commerciali siano tutti uguali tra loro ma
godono della sicurezza di poter trovare in qualsiasi angolo del mondo
qualunque cosa di cui abbiano bisogno. Da questa situazione discende uno
dei paradossi del “nonluogo”: il viaggiatore di
passaggio, smarrito in un paese sconosciuto, ritrova se stesso nell’anonimato
delle autostrade, delle stazioni di servizio e di altri “nonluoghi”. Il rapporto tra non luoghi e i suoi
fruitori avviene di solito tramite simboli, parole o voci preregistrate.
Esempio evidente sono i cartelli affissi negli aeroporti “vietato fumare”,
“non superare la linea bianca davanti agli sportelli”. L’individuo nel “nonluogo” perde tutte le sue caratteristiche e i ruoli
personali per continuare ad esistere solo come cliente o fruitore, ruolo
definito da un contratto più o meno tacito che si firma con l’ingresso in un
“nonluogo”. L’uso di questi spazi è destinato
all’utente medio, all’uomo generico senza distinzioni, non persone ma entità
anonime. Il cliente acquista il suo anonimato solo dopo aver fornito la prova
della sua identità, solo dopo aver controfirmato il contratto. Non c’è
conoscenza individuale, spontanea e umana, non c’è riconoscimento di un gruppo
sociale, come siamo abituati a pensare nel luogo antropologico. “Una volta
l’uomo aveva un’anima e un corpo, oggi ha bisogno anche di un passaporto,
altrimenti non viene trattato da essere umano” (Stefan Zweig,
1946). Si è socializzati, identificati e localizzati solo in occasione
dell’entrata o dell’uscita (o altra interazione diretta) nel/dal “nonluogo”, per il resto del tempo si è soli e simili a
tutti gli altri utenti/passeggeri/clienti. La società non pone limiti
d’ingresso ai “nonluoghi” a patto però che si
rispettino una serie di regole: farsi identificare come cliente solvibile e
quindi accettabile, attendere il proprio turno, seguire le istruzioni, fruire
del prodotto e pagare. |
|||