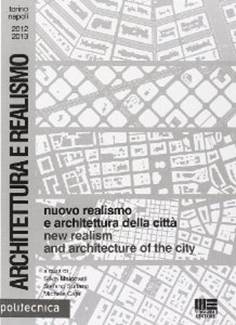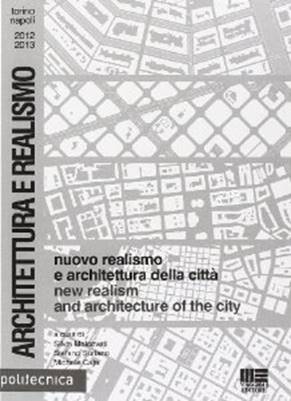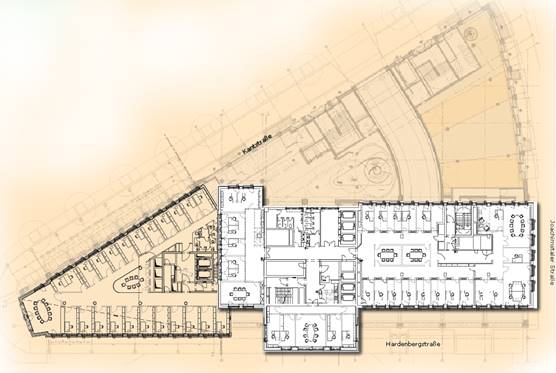|
|
|
|
|
||
|
|
autore |
SILVIA
MALCOVATI, STEFANO SURIANO, MICHELE CAJA |
|
|
titolo |
NUOVO REALISMO E ARCHITETTURA DELLA CITTA’ |
|
|
|
editore |
MAGGIOLI |
|
|
|
luogo |
TORINO NAPOLI |
|
|
|
anno |
2012 2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
lingua |
ITALIANO (alcune schede tradotte in INGLESE, TEDESCO, SPAGNOLO) |
|
|
|
autore |
SILVIA
MALCOVATI, STEFANO SURIANO, MICHELE CAJA |
|
|
|
Titolo originale: Nuovo realismo e
architettura della città |
|
||
|
|
|
||
|
Argomento e tematiche affrontate |
|||
|
|
L'argomento
trattato dal libro è la discussione filosofica sul Nuovo Realismo la quale ha
alimentato negli ultimi anni in Italia un ampio dibattito e suscitato anche tra
gli architetti alcuni interrogativi che riguardano, da un lato, il rapporto
della realtà con la città e più concretamente tra teoria e pratica
dell'architettura e, dall'altro, il ruolo degli architetti nel rapporto tra
la storia e la tradizione dell'architettura. A questi interrogativi si è
cercato di dare risposta in due convegni internazionali, uno svolto a Torino
e l'altro a Napoli, nel 2012 e nel 2013, e, per non perdere di vista il
contatto con la realtà costruita dell'architettura, si è deciso di affiancare
alla discussione teorica anche una mostra, con l'obiettivo di affrontare la
questione del rapporto tra architettura e realismo anche sul piano concreto
delle opere costruite. |
||
|
|
|||
|
Giudizio
Complessivo: 7 (scala 1-10) |
|||
|
Scheda compilata da: Vittorio Andrea Sellaro (Febbraio 2015) |
|||
|
Corso di Architettura e Composizione Architettonica 3 a.a.2014/2015 |
|||
|
|
|||
|
|
Autore Silvia Malcovati |
||
|
È nata a
Milano (1969), ha studiato architettura tra Milano (1997-90) e Barcellona
(1991-93) e si è laureata a Milano con Giorgio Grassi. È membro del comitato
editoriale e scientifico delle collane Maestri di Architettura e Schola
dell’Editore Libraccio di Milano. Professore Associato
(L.240) presso il Politecnico di Torino. |
|||
|
Silvia Malcovati |
|||
|
|
|||
|
Michele Caja |
Autore Michele Caja |
||
|
Ha
studiato Architettura al Politecnico di Milano e alla TU di Dortmund. E'
attualmente Ricercatore in Composizione Architettonica al Politecnico di
Milano, Dipartimento ABC. Ha collaborato con diversi studi di architettura in
Italia e all'estero, tra cui quello di Giorgio Grassi a Milano, città in cui
attualmente svolge attività di architetto. Insieme
a Silvia Malcovati è stato membro scientifico della
mostra "nuovo realismo e architettura della città" (2012-2013). |
|||
|
|
|||
|
|
Autore Stefano Suriano |
||
|
Architetto milanese
contemporaneo. Ha effettuato studi classici ed è "Cultore della
materia". Ha curato l'impaginazione
del testo. |
|||
|
|
|||
|
Contenuto |
|||
|
Il testo è strutturato in due parti: la
prima, molto densa di contenuti, raccoglie i contributi critici ed il
manifesto del tema oggetto della discussione filosofica; la seconda dedicata alla
mostra attraverso un percorso che tocca le città di Amsterdam, Barcellona e
Berlino oltre alle città ospiti della mostra, Torino e Napoli. In questa seconda parte gli autori hanno
deciso di stringere il campo di indagine a tre generazioni di architetti, che
corrispondono a tre fasi di costruzione delle città: - gli architetti degli anni Trenta e i
progetti degli anni Ottanta - gli architetti degli anni Quaranta e i
progetti degli anni Novanta - gli architetti degli anni Cinquanta e i
progetti degli anni Duemila |
|||
|
|
|||
|
CAPITOLI |
|||
|
Manifesto del nuovo
realismo – Maurizio Ferraris |
|||
|
Nel
mondo postmoderno la nozione di "realismo" ha subito un
declassamento, considerata una ingenuità filosofica: la realtà essendo mediata
dai nostri sensi e dai nostri pensieri non è mai accessibile in quanto tale. Il
"New Realism" vuole restituire alla
nozione di "realismo" lo spazio che si merita. La
sfiducia nella realtà è stata incrementata dalla politica , quella in cui
"la ragione del più forte è sempre la migliore", e dal pensiero di
Nietzsche secondo cui "non ci sono fatti, solo interpretazioni". Alla
fine degli anni '90 Umberto Eco parla di realtà come "zoccolo duro"
con cui necessariamente fare i conti a compimento di un discorso iniziato
dieci anni prima con "I limiti dell'interpretazione". Sono tre le parole chiave del New-Realism: ONTOLOGIA:
il mondo ha le sue leggi e le fa rispettare; è chiaro poi che per sapere che H2O
è l'acqua ho bisogno di un linguaggio , di schemi, di categorie. Ma l'acqua
bagna e il fuoco scotta sia che io lo sappia sia che io non lo sappia,
indipendentemente da linguaggio e categorie. Ad un certo punto c'è qualcosa che ci resiste. CRITICA:
è intrinseca nel realismo, la realtà è un accertamento, che non vuol dire
accettazione. ILLUMINISMO: come fiducia nell'umanità con il fine della salvezza |
|||
|
Realismo come metodo - Silvia Malcovati |
|||
|
Nei primi anni Novanta alcuni filosofi hanno
suggerito di riflettere sull'opportunità di un ritorno alla realtà,
considerata dal "pensiero debole" inaccessibile poichè
sempre mediata dai sensi; con il New Realism si
vuole riportare la discussione dal piano dell'apparenza al piano della
concretezza. L'architettura contribuendo in maniera
determinante alla definizione dell'ambiente fisico in cui viviamo si pone
come protagonista della realtà, la quale, parafrasando Aldo Rossi,
rappresenta uno "zoccolo duro" con il quale è necessario confrontarsi. Anche in architettura già dai primi
anni Novanta ( gli stessi anni in cui Eco parla di "zoccolo duro")
la realtà dell'architettura e il suo essere nella città risulta l'obiettivo
principale di ogni progetto. Per Aldo Rossi il realismo è lo
strumento critico necessario al superamento del funzionalismo in favore della
figura, come dice "Jorge Silvetti". Il realismo deve quindi essere un
metodo, una attitudine, facendo tesoro della storia per quanto riguarda il
carattere ma non le immagini. |
|||
|
Ricostruzione - Michele Caja |
|||
|
L'arte
del costruire declinata, dal punto di vista urbano, come arte del ricostruire
i caratteri propri della città storica europea. -
Bernard Huet (teorico francese) ---> ricostruire
nel significato di ritrovare le tracce urbane -
Leon Krier ---> ricostruire come riscoperta di
tipologie e spazi urbani -
Aldo Rossi ---> ricostruire come ricerca di un patrimonio collettivo Il
concetto urbano di ricostruzione viaggia su due binari paralleli
corrispondenti a due differenti linee teoriche di ricerca: quella dei
fratelli Krier che riscoprono la qualità degli
spazi urbani della città storica trasformandoli in schemi astorici da
applicare alla città contemporanea e quella di Colin Rowe
il quale vede la nuova città come insieme di oggetti decontestualizzati. |
|||
|
Architettura, Ragione, Realtà - Renato Capozzi |
|||
|
Architettura , Ragione e realtà sono
aspetti di un medesimo problema: la conoscenza e la trasformazione di ciò che
ci circonda, ossia il "mondo della vita". L'architettura determina lo spazio
fisico, la scena fissa, e sia nella sua ideazione (progetto) sia nella sua
costruzione effettiva (opera) non può essere nè una
negazione nè una fuga dalla realtà e nemmeno una passiva accettazione. Per Lukacs la
vera arte aspira allo scavo in profondità ed alla massima comprensione e
questo "scavo" non si accontenta di una presa d'atto bensì vuole
svelare le strutture profonde del reale il quale è analizzato dalla ragione. Monestiroli parla di realtà come una inesauribile fonte di
conoscenza e come unica scelta possibile in architettura. Per Rossi il rapporto con la realtà
è sempre da ritrovare poichè è la realtà stessa ad
essere dinamica nel tempo. |
|||
|
Città come principio di realtà - Gaetano Fusco |
|||
|
L'architettura
è relazione sensibile tra forma e materia, la cui autenticità risiede
nell'atto costruttivo che ne salda il legame al luogo, al tempo e alla
funzione che le è propria. La
città se "nuovo" in rapporto con il passato è fonte di realtà. La vera modernità è capire che non si può inventare il
"nuovo" senza rapportarlo al passato. |
|||
|
Il paesaggio
invisibile del realismo – Stefano Suriano |
|||
|
L'architettura è parte della realtà fisica,
sta nel reale e lo costituisce: è una "seconda natura artificiale". Gli studi ed il manifesto di Maurizio
Ferraris sono stati il pretesto per approfondire la questione del "Nuovo
Realismo" in architettura partendo dal concetto di continuità della città
storica come spunto per una riflessione sul tema del paesaggio urbano e della
città compatta in relazione alle modalità del progetto contemporaneo. Il progetto di architettura istituisce
un rapporto con la realtà solamente attraverso la conoscenza. Vi è la necessità di un atteggiamento
progettuale per cui, parafrasando Calvino, "un paesaggio
invisibile" (quello del realismo) "condiziona quello
visibile", ossia il paesaggio dell'architettura. L'immaginazione, come suggerisce Monestiroli, è il trait d'union tra realismo e
architettura: l'immaginazione è una pratica necessaria al realismo, senza di
essa il realismo sarebbe semplicemente un atto di adesione alla banalità del
reale e non un processo conoscitivo. L'obiettivo deve essere la
costruzione di un paesaggio materiale in cui l'architettura possa nuovamente
definire uno spazio "evocativo" e "adeguato": il
paesaggio invisibile del realismo. |
|||
|
Architettura, Città, Realtà - Federica Visconti |
|||
|
La
mostra "Nuovo realismo e architettura della città" nasce da una
esigenza: riaffermare che esiste in architettura un inscindibile nesso tra
teoria e sua applicazione concreta. Riprendendo
Maurizio Ferraris: << quello che ora è necessario non è tanto una nuova
teoria della realtà quanto piuttosto un lavoro che sappia distinguere che
cosa è costruito e cosa no>>. L'architettura è equidistante tanto dall'arte pura quanto dalla mera
pratica: esiste per rispondere ad esigenze collettive più che individuali. |
|||
|
|
|||
|
Nuovo Realismo e architettura della
città: la mostra |
|||
|
Temi:
-
Realtà e rapporto con la città -
Realtà e rapporto con la storia e la tradizione dell'architettura Campo
di indagine: - gli architetti degli anni Trenta e i
progetti degli anni Ottanta - gli architetti degli anni Quaranta e i
progetti degli anni Novanta - gli architetti degli anni Cinquanta e
i progetti degli anni Duemila Città: -
Amsterdam, Barcellona, Berlino - Torino, Napoli |
|||
|
Amsterdam - Andrea Marlia |
|||
|
La capitale olandese ha da sempre
rappresentato in architettura una peculiarità all'interno dei piani
urbanistici. - 1901: "Woningwet" prima legge sulla casa per sopperire alla richiesta
di rinnovate condizioni abitative (PRIMA LEGGE URBANISTICA EUROPEA nel senso
moderno del termine, anche se incentrata sull'edilizia). Vuole frenare la
speculazione fondiaria e garantire standard minimi di qualità dell'abitare - 1918: "Woning
Congress" (Amsterdam) necessità di realizzare abitazioni economiche
popolari ricorrendo ad elementi standardizzati, ma di buona qualità
strutturale; architetti come Berlage, Oud, de Bazel appoggiano il
congresso mentre i tradizionalisti rivendicano il diritto dell'architetto ad
una autonoma espressione artistica In questi anni si afferma la scuola
olandese nel campo dell'edilizia sovvenzionata. La struttura della città viene così via
via a mutare. All'architetto Hendrik Petrus Berlage viene affidato
il piano di espansione a Sud di Amsterdam (Plan Zuid).
Dopo gli interventi di Berlage si può agevolmente
tracciare un lungo percorso progettuale che porta all'ampliamento costante
della città fino almeno agli anni Cinquanta del Novecento. - 1928: "Algemeen
Uitbreidngsplan" nuovo Piano Generale di ampliamento di Amsterdam,
l'obiettivo era la policentricità della città in
seguito ad un principio ispiratore di espansione a ventaglio. - 1968: "Quartiere Bijlmermeer" completamento del primo edificio di edilizia
intensiva; il quartiere Bijlmermeer (17000 alloggi
sul terreno di proprietà pubblica) è nato per dare alloggio alle famiglie
olandesi con reddito medio ma nel 1975 con l'indipendenza del Suriname (ex
colonia olandese) divenne il ghetto che ospitò una imponente ondata
migratoria. - 1983: "Piano quinquennale per il
Bijlmermeer" viene varato un piano quinquennale di
ristrutturazione gestionale e di rinnovo edilizio del quartiere; l'incarico
viene affidato allo studio OMA di Rem Koolhass il
quale propone un progetto che però non trova consensi dall'amministrazione
comunale e viene accantonato. Nella seconda metà degli anni Ottanta ,
sull'Omval, località lungo il fiume Amstel, vicino
Amsterdam, sono eretti i primi grattacieli della città con l'idea di
realizzare un "Business District" esterno
al centro storico. ACQUA: Da sempre l'architettura di Amsterdam
ha instaurato uno stretto dialogo con l'acqua, come elemento essenziale
paesaggistico-urbano della città. La centralità economica della
città-commercio-porto ha fattò sì che l'acqua
costituisse un fattore chiave dello sviluppo urbano 1995-2000:
KNSM Eiland / Java Eiland / Borneo-Sporenburg emblematici esempi delle rinnovate esigenze di
progettazione di aree ad alta densità abitativa. Borneo-Sporenburg: le
residenze hanno l'affaccio sull'acqua con prospetti vetrati, privilegiando
gli spazi privati a quelli pubblici, ridotti al minimo essenziale. Numero
alto di residenze pur mantenendo le altezze relativamente basse, tipiche
delle costruzioni olandesi, fondando una nuova tipologia edilizia
residenziale: case a schiera che si differenziano da quelle tradizionali per
la presenza di patii e tetti giardino. Borneo e Sporenburg
sono collegate da due ponti (Brother e Sister). 2013-
: "Zuid As" è in corso il progetto Zuid As sul modello progettuale
del "Dokmodel": si tratta della scelta di
localizzare le infrastrutture, quali metropolitana ferrovia e autostrada, nel
sottosuolo al fine di una ottimale integrazione urbanistica in favore di una
migliore viabilità. Mostra - Hertzberger
: tema dell'edificio per educazione concentrando l'attenzione all'impianto
volumetrico della situazione urbana in cui si colloca. La scuola Montessori Apolloschool
è costituita da due volumi distinti che, concepiti come ville urbane, si
fondono con le unità residenziali che la circondano. - Kollhoff e Rapp: progettazione del recupero delle aree portuali
dismesse. Tema dei grandi volumi dei magazzini per lo stoccaggio delle
derrate alimentari, l'edificio Piraeus è un imponente volume urbano che
riprende il tema dell'isolato urbano. - Arets:
intervento residenziale il cui progetto presenta quattro edifici adagiati a
cavallo tra terra ed acqua; gli edifici sono edificati su parcheggi
sotterranei il cui tetto è coperto con del manto erboso in modo da costituire
quella continuità progettuale sia con lo spazio pubblico che con l'intero
principio del piano urbanistico originario. |
|||
|
Barcellona - Celia Marin Vega |
|||
|
La città con l'arrivo della democrazia, dal 1975 (anno di caduta del
regime di Franco), ha subito molte trasformazioni le quali definiscono la attuale
fisionomia della città. Il campo di indagine, come detto precedentemente, riguarda progetti dagli anni Ottanta fino ai giorni nostri in coerenza con il tema della mostra: "Nuovo Realismo e architettura della città". Il precursore dell'architettura realista a Barcellona è lo studio MBM di Oriol
Bohigas. Il progetto presentato alla mostra è il
complesso residenziale sull'area dismessa della fabbrica de La Maquinista a Barceloneta,
progettato nel 1979 e realizzato nel 1988. Questo progetto si integra nel
tessuto urbano in continuità con la struttura del quartiere e valorizzando le
peculiarità del suo intorno. Le case non si limitano alla semplice
risoluzione delle unità abitative bensì generano una serie di spazi pubblici
intermedi attraverso grandi gallerie-corridoio che gli abitanti occupano allo
stesso modo con cui continuano oggi ad occupare le strade del quartiere della
Barceloneta: con piante, sedie e vita sociale,
intendendo la vita in comunità in una forma complessa e rilassata. Un altro progetto significativo è dell'architetto Emili
Donato poichè nella progettazione di una casa per
anziani nel quartiere della Teixonera (1992) usa
l'architettura come riferimento a se stessa in mancanza di riferimenti
urbani. La residenza sorge con la sua chiarezza geometrica sul crinale della
montagna, affacciandosi su un ripido pendio e funzionando come un grande
balcone. Il progetto degli anni Duemila, oggetto della mostra, è uno spazio
pubblico: piazza di Sant Agusti
Vell di Josep Llinas
(2005). Questo progetto è integrato nel tessuto denso del centro storico
medievale, dando continuità alla struttura di isolati e strade strette, ma
anche contemporaneamente aprendosi e arretrando per portare più luce al
complesso. Una particolarità è data dalle facciate degli edifici le quali si
piagano e curvano verso l'interno per formare i cortili privati. |
|||
|
Berlino - Alexander Pellnitz |
|||
|
Berlino è una città che presenta
alcune opere architettoniche diverse tra loro che forniscono dei suggerimenti
utili al dibattito attuale sul Nuovo Realismo in architettura. Questa città
con il crollo del Muro ha subito dei cambiamenti sensibili e l'architettura
ha avuto un ruolo di rilievo, è quindi utile vedere e capire qual è stato
tipo di approccio. Due casi studio significativi: - Giorgio Grassi, Potsdamerplatz
(1999-2001) : Per gli uffici della ABB, Grassi
decide di lavorare sul concetto di "margine", di confine rispetto
alla città antica. Come elemento base ripetuto viene scelto un unico tipo edilizio
a forma di "H", in grado di offrire sui lati opposti due soluzioni
differenti di affaccio sullo spazio pubblico, corrispondenti alle condizioni
planimetriche dell'area di progetto.
- Christoph
Mackler Architecten, Hardenbergstrasse (2009-2012) : Hotelalto 118 metri, lo Zoofenster,
si propone come nuovo simbolodello skyline di
Berlino. Lo
Zoofenster riprende con la sua edificazione
in cortina la tipica forma degli isolati berlinesi. Il progetto dell'edificio si fonda
sul concetto di destinazione mista in verticale. L'area si trova nei pressi
della Breitscheidplatz, un punto d'incontro
caratterizzato dalle forme storiche di edificazione e dove vengono a contatto
differenti concezioni spaziali. La nuova figura urbana corrisponde
alla complessità del luogo e sottolinea le qualità rinvenute. La facciata è plastica grazie
all'impiego di pietra e abbinata ad un
numero limitato di piastre, lapidee, con scalanature
orizzontali.
|
|||
|
Napoli - Claudio Finaldi Russo |
|||
|
Napoli si trasforma pochissimo, in modo
particolare all'interno del suo centro storico. La sezione napoletana della mostra fa emergere
che la realtà differisce da ciò che per lungo tempo è stato interpretato e
considerato un "fatto". Lo
studio su Napoli mette in evidenza una grande ricchezza nel patrimonio
napoletano in materia: la sapienza dell'impianto planimetrico nei confronti
del contesto è un tratto distintivo dell'esperienza napoletana. |
|||
|
Torino - Giulia Perona |
|||
|
La storia
dell'architettura recente di Torino sottolinea la tendenza degli architetti, qui
più che altrove, ad operare singolarmente. Forse questa caratteristica ha
portato la critica a considerare la città come periferica rispetto al
dibattito nazionale ed internazionale. Nell'ambito
della mostra è d'obbligo rievocare Edoardo Persico, nato a Napoli, giunto a
Torino per questioni di militanza politica ed infine approdato nella Milano
di "Casabella" e "Domus": una
vita che tocca le sedi del convegno "Architettura e Realismo" e che
porta con sè, come legandole da un filo rosso,
questioni e dubbi sul ruolo e sul significato di una architettura veramente
"moderna". Egli disse: << il contenuto "pratico" della nuova architettura è soltanto una forza ideale, è prima di tutto esplosione morale, non già preoccupazione realistica di bisogni >>. Lo Studio De
Ferrari dice inoltre che il presunto razionalismo/realismo di scuola milanese
non è concepibile nella realtà torinese, non le appartiene così come non le
appartiene, sempre secondo Studio De Ferrari, l'autoreferenzialità
intellettuale o commerciale delle archistars di
ogni tendenza e di ogni periodo. Vi
è un tratto comune nell'architettura torinese: la cura e la precisione nel
ricucire gli angoli urbani e di lavorare in continuità con la struttura
dell'isolato riconfigurandolo ma sempre all'interno della maglia urbana;
tratto comune da Gabetti e Isola fino ad arrivare a Robiglio passando per Baietto-Battiato-Bianco. |
|||