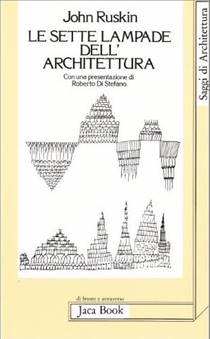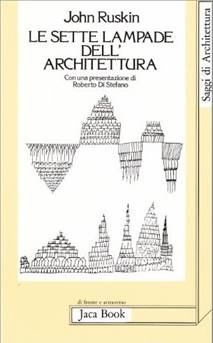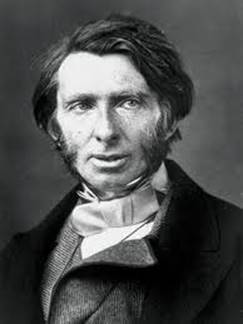|
|
|
|
|
||
|
|
titolo |
LE SETTE LAMPADE DELL’ARCHITETTURA |
|
|
editore |
JACA BOOK |
|
|
|
luogo |
MILANO |
|
|
|
anno |
1982 |
|
|
|
|
|
|
|
|
lingua |
ITALIANO |
|
|
|
|
|
|
|
|
Titolo originale:
John Ruskin, The Seven Lamp of Architecture, 1849 |
|
||
|
|
|
||
|
Argomento e tematiche affrontate |
|||
|
|
L’opera ha lo scopo di richiamare l’attenzione sul
significato di architettura e sui doveri che l’uomo ha sia nei confronti
della nuova che occorre costruire, sia dell’antica che deve essere
conservata. Mira pertanto a definire le sette lampade dell’architettura,
ovvero quei principi generali applicabili a ogni suo periodo e stile. Vi si ritrova la posizione particolare dell’autore nei confronti del
restauro architettonico, maturata anche attraverso i numerosi viaggi in
Italia: la sua concezione di restauro, definito
"restauro romantico", ritiene immorale l'intervento di restauro,
comunemente praticato nella sua epoca, inteso come sostituzione della copia
all'originale. Egli sostiene la necessità di conservare l'esistente,
ammettendo quegli interventi di comune manutenzione utili a prolungare il più
possibile la vita dell'architettura antica, alla quale va riconosciuto anche
il diritto, quando sarà giunto il momento, di morire. |
||
|
|
|||
|
Giudizio
Complessivo: 7 (scala 1-10) |
|||
|
Scheda compilata da: Federica Martini |
|||
|
|
|||
|
|
Autore John Ruskin |
||
|
John Ruskin (Londra, 8 febbraio 1819 – Brantwood, 20 gennaio 1900) è stato uno scrittore, pittore, poeta e critico d’arte britannico. Fu uno dei fondatori dell’Arts and Crafts Movement, uno dei precursori dell’Art Nouveau e fermo oppositore del capitalismo e dell’industrialesimo. L’autore
nel complesso della sua opera affronta un percorso che parte dall’osservazione
della natura attraverso la poesia, le arti figurative e l’architettura in
particolare e che conduce a meditare sull’ambiente determinato da tali
architetture e sulla condizione della vita degli uomini che vi vivono e alla
coscienza del rapporto esistenziale tra essi e l’ambiente di natura, d’arte e
di storia che li circonda. “Le sette lampade dell’architettura” segna il
momento in cui Ruskin prende coscienza
dell’esistenziale relazione tra arte e società, ovvero tra l’uomo e ciò che
lo circonda (che sia prodotto da lui o dalla natura). |
|||
|
John Ruskin |
|||
|
|
|||
|
Contenuto |
|||
|
L’opera ha lo scopo di richiamare l’attenzione di
tutti sul significato di architettura e sui doveri che l’uomo ha sia nei confronti
della nuova che occorre costruire, sia dell’antica che deve essere
conservata. Ruskin afferma che “i capitoli di
quest’opera hanno la sola pretesa di essere l’illustrazione dei principi
dell’architettura, non un saggio sull’architettura europea”. Ogni capitolo è
perciò dedicato a uno dei 7 principi dell’architettura, che egli chiama
“lampade”: sacrificio, verità, potenza, bellezza, vita, memoria, obbedienza. Principalmente, è il sesto capitolo (“La lampada
della memoria”) che contiene le pagine dove Ruskin
ha segnato la dottrina della conservazione che la moderna cultura sostiene e
porta avanti. È da rilevarsi qui l’affermazione dell’esigenza non tanto di
proteggere i monumenti antichi, quanto di asservire ai medesimi principi sia
la costruzione della nuova architettura che la tutela dell’antica, affinché
esse costituiscano, unitariamente, elementi integranti dell’ambiente di vita
della società umana. Lo stesso capitolo viene quindi diviso in due parti: la
prima dedicata alla costruzione del nuovo, agli effetti del tempo sugli
edifici e al concetto di “pittoresco”; la seconda in cui tratta dei problemi
della tutela e del restauro dell’architettura antica. Ruskin parte dunque
dall’affermazione dell’importanza fondamentale del rapporto esistente tra la
natura e l’opera dell’uomo e tra le cose e il ricordo e individua l
‘architettura come l’elemento senza la quale non si può ricordare. Noi uomini
abbiamo il duplice compito di dover conferire una dimensione storica
all’architettura di oggi e di conservare quella delle epoche passate come la
più preziosa delle eredità. |
|||
|
|
|||
|
CAPITOLI |
|||
|
Prefazione e
Introduzione |
|||
|
La prefazione all’edizione 1880 de
“Le sette lampade dell’architettura” rappresenta uno degli ultimi scritti dell’autore
e permette di rilevare il giudizio che egli stesso attribuisce all’opera: la
definisce la più inutile che abbia mai scritto in quanto “gli edifici che vi
sono descritti sono ormai andati distrutti, oppure sono diroccati e
rappezzati con gusto mediocre e impersonale”. Afferma che “i capitoli di
quest’opera hanno la sola pretesa di essere l’illustrazione dei principi
dell’architettura, non un saggio sull’architettura europea” per mettere
l’accento sul ridotto numero di edifici a cui si fa riferimento, e spiegando
inoltre che gli esempi da lui riportati fanno riferimento agli edifici o alle
scuole architettoniche che predilige. L’autore introduce il lettore ai
sette principi dell’architettura, definendoli come quelle leggi fondate sulla
natura dell’uomo e non sul suo sapere; queste leggi sono costanti, generali e
inconfutabili e non vengono invalidate dallo sviluppo del sapere dell’uomo. |
|||
|
|
|||
|
Capitolo I – La Lampada del Sacrificio |
|||
|
“Tutta l’architettura si propone di
influire sullo spirito dell’uomo, non solo di offrire un servizio per il suo
corpo. L’architettura è l’arte che acconcia e adorna gli edifici eretti
dall’uomo per qualsiasi impiego, in modo tale che il vederli possa
contribuire alla sua salute, al suo vigore e al suo piacere di ordine
intellettuale”. È indispensabile distinguere
nettamente tra architettura e costruzione. Costruire significa mettere
insieme le parti di un edificio; il costruito però non sempre è architettura.
L’architettura è invece l’arte che ammette come condizioni del suo operare la
necessità e gli usi comuni del costruire e imprime alle forme del costruito
determinati caratteri di venerabilità o bellezza, per il resto non necessari;
essa si interessa solo di quelle caratteristiche di un edificio che sono al
di là del suo uso comune. Per esempio: “nessuno chiamerebbe architettoniche
le leggi che determinano l’altezza di un parapetto o la posizione di un
bastione. Ma se alla pietra che fa da rivestimento a quel bastione si
aggiunge un tratto non indispensabile, come una modanatura, quella è
architettura”. Non è sempre facile tracciare in modo netto la linea di
demarcazione perché vi sono pochi edifici che non abbiamo qualche pretesa o
parvenza di architettura, né vi può essere alcuna architettura che non sia
fondata sulla costruzione. L’architettura si distingue in 5
categorie:
Tra i principi che Ruskin vuole
sviluppare, per quanto tutti applicabili a ogni periodo e stile artistico, ce
ne sono alcuni che fanno riferimento più a un genere di costruzione piuttosto
che a un altro; tra questi c’è lo spirito, che fa particolare riferimento
all’architettura devozionale e celebrativa. Si intende lo spirito che offre
per opere di tal genere oggetti preziosi, non in quanto necessari alla
costruzione, ma in quanto offerta, rinuncia, sacrificio di ciò che è per noi
desiderabile. “Il lusso privato dev’essere sacrificato in favore della
prosperità nazionale”: e Ruskin non intende solo doni materiali, ma anche
azioni. L’autore afferma che il sacrificio
è per la maggior parte assente ai nostri giorni: oggi si ambisce a produrre i
risultati maggiori al costo più basso. |
|||
|
|
|||
|
Capitolo II – La Lampada della Verità |
|||
|
“La verità (…) quel pilastro della
terra”: Ruskin invita a ripudiare la menzogna, individuando le forme di falsità
che si sono insinuate nelle abitudini della nostra vita quotidiana. L’autore sottolinea la differenza
tra immaginazione e inganno: l’immaginazione è un volontario fare appello a
cose che sono assenti o impossibili; se l’immaginazione inganna, diventa
follia. Si potrebbe per esempio pensare che l’arte della pittura non sia
altro che un tentativo di inganno; essa invece è l’esposizione di determinati
fatti nel modo più chiaro possibile. Per esempio, quando si vuole descrivere
una montagna, si parte dalla descrizione della forma e del colore; le parole
non bastano, e quindi la si disegna e colora. Si prosegue poi aumetando i
dettagli, finchè la scena non sembrerà realmente esistente. Essa è la
comunicazione di un atto dell’immaginazione, non una menzogna. La menzogna
può invece per esempio esistere nella falsa rappresentazione di forme e
colori. Le violazioni della verità che disonorano poesia e pittura sono
quindi limitate al modo di trattare i soggetti. In architettura è possibile
un’altra violazione della verità, più sottile e deprecabile. Le frodi in architettura si possono
dividere in 3 tipi:
Ruskin afferma che il primo passo
da compiere è il “farla finita con queste cose”. E aggiunge: “Può darsi che
non siamo capaci di far nascere a comando un’architettura buona, o bella, o
inventiva; ma possiamo imporre un’architettura onesta: si può perdonare la
secchezza di ciò che è povero, si può rispettare l’austerità di ciò che è
utile, ma cosa vi può essere se non disprezzo per la meschinità di ciò che è
falso?”. L’architettura sarà nobile in proporzione alla sua capacità di fare
a meno di tutti questi falsi espedienti. Vi sono alcune eccezioni: nella
volta della Cappella Sistina, per esempio, Michelangelo dipinge anche delle
architetture; in questo caso la pittura ha lo scopo di impreziosire il
materiale e non viene scambiata dall’osservatore per qualcosa di reale (“la
grande pittura non inganna mai”). Altra eccezione è per esempio rappresentata
dal rivestimento marmoreo dei mattoni, a patto che si capisca chiaramente che
il marmo sia un rivestimento applicato;è da considerarsi come arte musiva su
grande scala. |
|||
|
|
|||
|
Capitolo III – La Lampada della Potenza |
|||
|
Ruskin afferma che le opere di architettura si dividono in due categorie
in base al ricordo che abbiamo di loro: l’una caratterizzata da preziosità e
raffinatezza, a cui ritorniamo con un senso di affettuosa ammirazione;
l’altra da una misteriosa e severa maestà che ricordiamo con reverenza, come
quella che proviamo in presenza di una grande forza di spiritualità. Dal novero di queste due categorie, caratterizzate da bellezza e
potenza, finiranno per essere esclusi i ricordi di edifici che avevano
destato interesse alla prima impressione, ma che dovevano la loro suggestione
a caratteristiche di nobiltà meno durevole (come al valore del materiale,
alla dovizia di decorazioni). Aggiunge inoltre che tutto ciò che in architettura è piacevole e bello è
un’imitazione delle forme naturali, mentre ciò che non è derivato in questo
modo, ma dipende dall’accomodamento e dal governo che gli vengono dalla mente
umana, diventa l’espressione della potenza di quella mente. L’arte di
edificare perciò mette in luce la capacità dell’uomo di raccogliere e
governare. Queste sono le due grandi lampade dell’architettura intellettuale:
l’una consiste in una giusta e umile venerazione per le opere di Dio sulla
Terra (la venerazione) e l’altra nella consapevolezza che l’uomo è stato
investito della signoria su queste opere (il dominio, la potenza). L’autore fa riflettere sul fatto che solitamente è l’uomo a distruggere
la sublimità della natura, piuttosto che la natura che insidia la potenza
dell’uomo. Per esempio l’uomo può rovinare un intero paesaggio attraverso la
costruzione di una villa. Per Ruskin è bene inoltre stabilire dall’inizio se il progetto di un
edificio debba puntare prevalentemente sulla bellezza o sulla sublimità: se
si sceglie la grandiosità è bene per esempio lasciar perdere le decorazioni,
per evitare spreco di risorse e finanze. “La sventura della maggioranza dei
nostri edifici moderni è che noi vorremmo che essi raggiungessero
l’eccellenza sotto tutti gli aspetti”. Tra le forme geometriche, quelle che conferiscono maggior potenza alla
dimensione e forma dell’edificio sono il quadrato e il cerchio, e i relativi
solidi cubo e sfera; la colonna quadrata e quella cilindrica sono quindi gli
elementi di più alta potenza in tutte le soluzioni architettoniche. La
sublimità di colonnati e navate sta nella ripetizione in serie di questi
elementi, tale che l’occhio non sia in grado di enumerarli. Esempi: la
cattedrale di Pisa e il Palazzo Ducale di Venezia (che per Ruskin è il
modello di tutte le perfezioni). Oltre che dalle dimensioni e dalla pesantezza, la potenza
dell’architettura dipende dall’intensità del suo chiaroscuro, generato dagli
effetti di luce e ombra. Le opere architettoniche sono usate e influenzano la
vita quotidiana dell’uomo; si richiede allora a esse di esprimere un’affinità
con la vita umana, attraverso una misura di oscurità equivalente a quella
presente nella vita degli uomini. Sono necessarie quelle espressioni
corrispondenti alle tribolazioni e ai tormenti della vita, ai suoi dolori e
al suo mistero. E l’architettura può dare ciò solo con la profondità e la
diffusione dei punti oscuri. “E io non credo che mai un edificio sia stato
veramente grande senza avere delle masse d’ombra possenti, vigorose e
profonde, combinate con le sue superfici”. |
|||
|
|
|||
|
Capitolo IV – La Lampada della Bellezza |
|||
|
L’autore afferma che “l’uomo non può avanzare nell’invenzione della
bellezza senza imitare direttamente le forme della natura”, ovvero che “tutte
le forme e le concezioni più attraenti sono prese direttamente dagli oggetti
naturali; vorrei anzi che mi fosse concesso di sostenere anche l’inverso: e
cioè che e forme che non sono derivate dagli oggetti naturali sono
necessariamente brutte”. La bellezza deve essere osservata con calma; è quindi bene non decorare
oggetti che sono destinati alla vita lavorativa (per esempio le facciate
delle botteghe o le stazioni ferroviarie), ma solo quelli destinati al
riposo: “mettetela nel salotto, non nell’officina; mettetela sui mobili di
casa, non sugli utensili per il lavoro manuale”. Per Ruskin il concetto di bellezza è legato a quello di frequenza: più
una cosa in natura è visibilmente frequente, più è bella; e aggiunge
visibilmente poiché “le forme delle cose che giacciono nascoste nelle viscere
della terra (…) non era evidentemente intenzione del loro Creatore che fossero
esposte abitualmente agli sguardi dell’uomo”. Con il termine frequenza non si
indica la mera quantità: per esempio la rosa: “sulla pianta non vi sono tante
rose quante sono le foglie. Sotto quest’aspetto, la natura è avara delle sue
bellezze più eminenti, e prodiga di quelle che lo sono meno. Io definisco
però il fiore frequente quanto la foglia, perché dove si trova l’uno, là vi
sarà di norma l’altro”. Ruskin riporta un lungo elenco di decorazioni che egli critica poiché
non sono realmente ispirate alla natura: tra queste le ghirlande e i festoni
di fiori (“ le disposizioni innaturali sono brutte esattamente quanto le
forme innaturali”), i nastri e le scritte (“fra tutte le cose che non hanno
somiglianza con la natura, le lettere sono, forse, quelle che ne hanno
meno”). La buona decorazione consiste invece nella disposizione accurata di
forme, tale da imitare o suggerire le cose più comuni esistenti in natura,
considerando più nobili le decorazioni che rappresentano gli ordini più alti
(l’imitazione dei fiori è più nobile di quella delle pietre, quella degli
animali lo è ancora di più, e quella della forma umana è la più nobile).
Ruskin annovera quindi tra gli esempi di buone decorazioni il capitello
corinzio, bello perché “si dispiega sotto l’abaco come l’avrebbe dispiegato
la natura, e perché comunica l’impressione che le foglie abbiano una radice
in comune”. È quindi decorativo ciò che è frutto dell’imitazione. L’imitazione però non può essere totale: la completezza assoluta della
forma imitativa implica l’assenza di astrazione. Ruskin invita a essere
prudenti nell’inserire la scultura nell’architettura perché una scultura
perfetta potrebbe far passare l’architettura come “una pura impalcatura fatta
per sistemarvi raffinate sculture”. L’architetto non può rappresentare tutte le qualità, per esempio il
colore o il profumo, degli oggetti naturali; l’immagine che egli riporta
rappresenta ciò che è percepito attraverso uno sforzo intellettuale, la
forma. Ruskin procede con considerazioni sul colore dell’architettura: “credo
che i colori dell’architettura dovrebbero eseere quelli della pietra
naturale, in parte perché più durevoli, ma anche perché più perfetti ed
eleganti”. Il colore deve essere indipendente dalla forma. In architettura è
bene applicare sia la monocromia (sculture, bassorilievi, …) che la
policromia (mosaici, affreschi, …). Il capitolo si conclude con la descrizione del Campanile di Giotto,
emblema di potenza e bellezza. |
|||
|
|
|||
|
Capitolo V – La Lampada della Vita |
|||
|
Come si può rendere viva e vitale
l’imitazione? Due caratteri dell’imitazione vitale sono la sincerità e
l’audacia. - La sincerità: consiste nel non
tentare mai di dissimulare la fonte del prestito (gli architetti del
romanico, per esempio, copiavano ove potevano capitelli e colonne); quando ci
imbattiamo in un’ammissione così sincera veniamo a sapere che nell’animo
dell’architetto c’è un senso di forza capace di trasformare e rinnovare
qualcunque cosa esso faccia sua; è un omaggio a ciò che egli ammira, nel modo
più aperto e indubitabile. - L’audacia: è la capacità di
sacrificare la tradizione quando diventa importuna. La trascuratezza della rifinitura e
della simmetria è un altro segno di vitalità: Ruskin afferma che “una
perfetta rifinitura appartiene a un’arte perfetta, una rifinitura in
evoluzione corrisponde a un’arte in evoluzione”. Introduce poi vari esempi,
tra cui la Cattedrale di Pisa e la rispettiva torre (“Ora, questa io chiamo
Architettura Viva. Vi è vitalità in ogni pollice di essa”), San marco a
Venezia e il Palazzo Ducale. Ruskin conclude con delle
considerazioni riguardanti il fatto che quando si lavora su un edificio,
bisogna farlo con affettuosità, con piacere. Propone l’esempio di una
qualsiasi chiesa ricca di decorazioni, ma in cui gli operai hanno lavorato
senza sentimento: il risultato è un edificio privo di vitalità. Da qui
l’affermazione: “Il denaro non serve a comprare la vita”. Per lo stesso
motivo, si deve fare a meno delle decorazioni eseguite a macchina,
privilegiando il lavoro manuale dell’uomo, poichè in esso vi sono la fatica e
il cuore. |
|||
|
|
|||
|
Capitolo VI – La Lampada della Memoria |
|||
|
Ruskin incentra il capitolo sul
fatto che senza l’architettura “si può vivere e si può pregare, ma non si può
ricordare”. Bisogna pertanto conferire una dimensione storica
all’architettura di oggi e conservare quella delle epoche passate come la più
importante delle eredità. Prosegue poi affermando che “gli
edifici pubblici e privati che noi costruiamo raggiungono la vera perfezione
proprio quando diventano commemorativi o monumentali”, caricandosi di un
significato storico e metaforico. Edilizia privata: Ruskin è contro
il fatto che gli edifici siano costruiti per durare solo una generazione: la
casa è custode dei ricordi della vita e contiene tutti i materiali che gli
abitanti hanno amato e usato. Distruggendola non si dimostra alcun rispetto
per quel luogo, né affetto. “Io vorrei che le nostre case d’abitazione
fossero costruite per durare e per essere belle; ricche e piene
d’attrattive”. La casa dovrebbe esprimere carattere e storia di ogni
abitante; così Ruskin suggerisce di lasciare incisa su qualche pietra
dell’edificio una breve sintesi della vita dell’occupante, elevando così
l’abitazione a una sorta di monumento. Egli è conscio che al giorno d’oggi
l’uomo ha la sola aspirazione di entrare a far parte di un ceto superiore a
quello che è il suo ceto naturale; da qui la speranza di abbandonare le
costruzioni che ha edificato e di dimenticare gli anni di vita passati. E
“quando gli uomini non amano i loro sentimenti, non provano reverenza verso
la loro casa”. L’autore aggiunge: “Io dico che se gli uomini vivessero
veramente da uomini, le loro case sarebbero come dei templi, - templi che noi
non oseremmo tanto facilmente violare e nei quali diventerebbe per noi
salutare privilegio poter vivere”. L’architettura domestica è il principio di
tutte le altre. Edilizia pubblica: “non vi dovrebbe
essere un solo ornamento applicato a un edificio di grande importanza civica
che non fosse mosso da qualche intenzione di carattere intellettuale”;
“meglio il più grezzo dei lavori che racconti una storia o commemori un
fatto, del più raffinato che sia privo di significato”. Ruskin afferma che quando noi
costruiamo dobbiamo pensare al fatto che stiamo costruendo per sempre; con
ciò intende che dobbiamo guardare al futuro, non soddisfando solamente i
nostri bisogni quindi, né la sola utilità del momento. La nostra opere deve
indurre i nostri discendenti a ringraziarci. La gloria di un edificio non
risiede quindi nelle pietre o nell’oro di cui è fatto, ma nell’età, nella
testimonianza che ci è trasmessa dagli uomini del passato. Ruskin procede analizzando il termine
“pittoresco”: è sublimità parassitaria, ossia una sublimità che dipende da
fattori accidentali (la bellezza non è pittoresca; lo diventa se vi è un
elemento sublime). Il pittoresco si ricerca sempre nelle rovine perché si
pensa consista nella decadenza; invece esso consiste nella sublimità delle
crepe o nella vegetazione che assimilano l’architettura all’opera della
natura. Si rischia però la soppressione dei caratteri autentici
dell’architettura. L’autore affronta poi il tema del
restauro, definendolo come la peggiore delle distruzioni che un edificio
possa subire: “È impossibile in architettura restaurare, come è impossibile
resuscitare i morti”. Questo perché non si può rendere lo spirito
dell’esecutore originario. Senza contare che restaurare per Ruskin implica
l’utilizzo di volgari imitazioni: fredde copie di quelle parti che possono
essere sostituite. Inoltre per lui il
restauro è una necessità distruttiva perché si fa prima a demolire
l’edificio. Allora, invece che trascurare
l’edificio e poi restaurarlo, suggerisce: “Prendetevi cura solerte dei vostri
monumenti, e non avrete alcun bisogno di restaurarli”. Solo così più
generazioni potranno nascere e morire all’ombra di quell’edificio. Non è infine nostro compito
stabilire se conservare o no determinati edifici: essi appartengono a noi, ma
in parte a coloro che li costruirono, in parte alle generazioni future, e
saranno loro ad occuparsene. L’Architettura non deve finire come sempre
distrutta senza una ragione. |
|||
|
|
|||
|
Capitolo VII - La Lampada dell’Obbedienza |
|||
|
Ruskin sostiene che la libertà non
esista. A dominare nell’universo è la Legge, ovvero l’obbedienza. Egli
sostiene: “L’obbedienza è, invero, fondata su una sorta di libertà, altrimenti
diventerebbe pura sottomissione; ma questa libertà è concessa solo perché
l’obbedienza possa essere più perfetta”. La stessa architettura non potrebbe
mai fiorire, eccetto che soggetta a legge nazionale rigida e prescrittiva:
“L’architettura di una nazione è grande solo quando è universale e
consolidata come lo è la sua lingua”. Le opere architettoniche devono appartenere a una scuola. Per
Ruskin dapprima gli architetti devono imparare a operare secondo uno stile
consacrato: devono catalogare, classificare e studiare le diverse forme e le
diverse decorazioni dello stile e con esse lavorare, come se fossero
un’autorità assoluta e inviolabile, senza ammettere la minima trasgressione.
Poi, una volta aver conosciuto e aver preso dimestichezza con queste forme,
possono permettersi qualche licenza, apportando cambiamenti o aggiunte alle
forme che hanno assimilato, sempre entro certi limiti. E così, col procedere
del tempo e in virtù di un grande movimento su scala nazionale, potrebbe
nascere un nuovo stile. L’architettura è l’arte
fondamentale; la scultura e la pittura derivano da essa. |
|||
|
|
|||
|
GLOSSARIO |
|||
|
Lampade – L’autore con questa parola intende
definire i principi generali dell’architettura: quelle leggi fondate sulla natura
dell’uomo e non sul suo sapere; esse sono costanti, generali e inconfutabili
e non vengono invalidate dallo sviluppo del sapere dell’uomo. |
|||
|
Architettura – L’autore definisce l’architettura
come l’arte che ammette come condizioni del suo operare la necessità e gli
usi comuni del costruire e imprime alle forme del costruito determinati
caratteri di venerabilità o bellezza, per il resto non necessari. Essa si
interessa solo di quelle caratteristiche di un edificio che sono al di là del
suo uso comune. |
|||