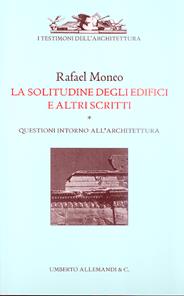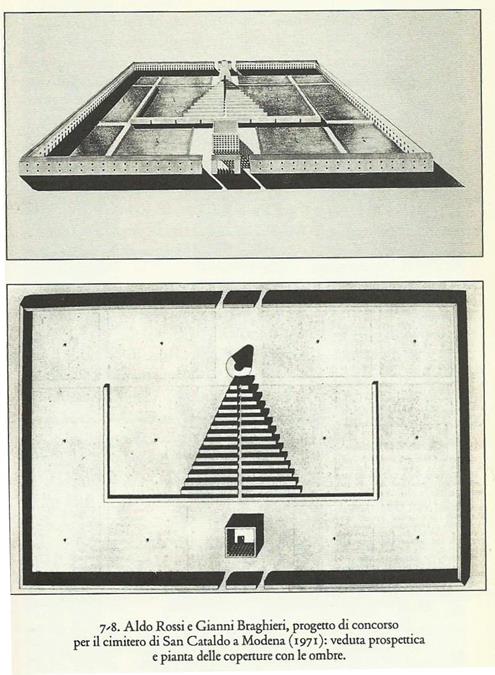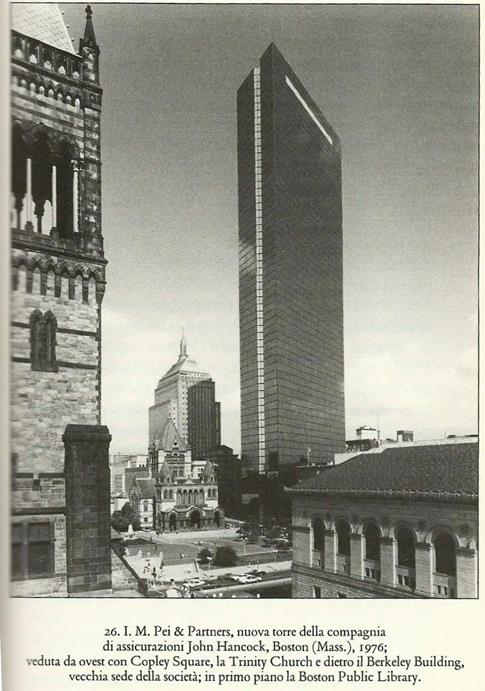|
|
|
|
|
||
|
|
titolo |
LA SOLITUDINE DEGLI EDIFICI E ALTRI SCRITTI (Vol. I e II) |
|
|
editore |
UMBERTO ALLEMANDI & C. |
|
|
|
luogo |
TORINO |
|
|
|
anno |
Vol. I 1999; Vol II 2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
lingua |
ITALIANO |
|
|
|
|
|
|
|
|
Titolo originale:
Rafael Moneo, The solitude of buildings, 1999 |
|
||
|
|
|
||
|
Argomento e tematiche affrontate |
|||
|
|
“La solitudine degli edifici” è una raccolta di scritti
pubblicati in un arco di tempo di oltre vent’anni, dal 1965 al 1985. Nel primo volume (Questioni intorno all’architettura) vengono
trattati la tipologia, il rapporto delle opere con il tempo, il ruolo della
tecnica nella progettazione architettonica; il secondo volume (Sugli
architetti e il loro lavoro) è invece dedicato ad architetti (in particolare
Rossi, Eisenman, Pei, Gehry,
Venturi) e ad alcune delle loro opere. |
||
|
|
|||
|
Giudizio
Complessivo: 7 (scala 1-10) |
|||
|
Scheda compilata da: Federica Martini |
|||
|
|
|||
|
|
Autore Rafael Moneo |
||
|
Rafael Moneo (Tudela, 9 maggio 1937) è un architetto spagnolo. Dopo essersi laureato nel 1961 presso la Escuela Técnica Superior de Arquitectura di Madrid, lavora con Francisco Javier Sáenz de Oiza e poi presso lo studio di Jørn Utzon in Danimarca, per due anni. Dal 1963 al 1965 studia a Roma, dove ha vinto una borsa presso l'Accademia di Spagna.Ha insegnato
architettura a Barcellona, Losanna, New York, Princeton, Harvard e Madrid. È l’unico
spagnolo ad oggi ad aver ricevuto il Premio
Pritzker, nel 1996. |
|||
|
Rafael Moneo |
|||
|
|
|||
|
Contenuto |
|||
|
Può essere visto come una riflessione tra ciò che
costruiamo e il trascorrere del tempo. Per ragioni editoriali è stato diviso in due volumi. Il
primo tratta i temi della tipologia, dell’insegnamento, delle opere nel loro
rapporto con il tempo e del ruolo della tecnica nella progettazione
architettonica; il secondo è dedicato agli architetti e al loro mestiere. Nelle parole di Moneo risuona l’eco
della “lampada della memoria” di John Ruskin. |
|||
|
|
|||
|
CAPITOLI |
|||
|
Introduzione |
|||
|
Le città e i paesaggi si sono
lentamenti formati nel tempo; ma essi rappresentano anche un modo per fermare
il tempo, rinchiuderlo nel contorno di una forma. Nell’architettura vi è una
misteriosa risonanza delle epoche e delle generazioni. Ogni edificio è oggetto
di trasformazioni, adattamenti e ricostruzioni; ma se esso si basa su
principi formali chiari e se è permeato da una struttura ideale, allora sarà
in grado di onservare comunque la sua identità e di rimanere riconoscibile.
Ogni città e ogni edificio vive in una tensione tra uno schema sottostante
(un impianto ordinatore) e i mutamenti intervenuti. Il titolo recita: “La solitudine degli edifici”: gli
edifici una volta compiuti si separano dai sentimenti, dalle passioni, dalle
contingenze e dai modelli che li hanno fin lì accompagnati. Nascono dapprima
sulla base di una richiesta e di un bisogno, in rapporto a un luogo e a una
società; alla fine però rimane solo il manufatto. |
|||
|
|
|||
|
Parte I (libro I) – Sul concetto di tipo |
|||
|
Moneo definisce il tipo come quel
concetto che descrive un gruppo di oggetti caratterizzati da una stessa
struttura formale. Il concetto di tipo si basa fondamentalmente sulla
possibilità di raggruppare gli oggetti servendosi di similitudini strutturali
a essi intrinsiche. Il lavoro dell’architetto inizia
dal riconoscimento del tipo; può poi distruggerlo, trasformarlo o
rispettarlo. Infatti la tipologia non è un meccanismo rigido che induce
ripetizioni: l’architetto può deformarlo modificandone la scala, sovrapponendo
tipi differenti fino a crearne uno nuovo, ecc; l’elenco di questi meccanismi
d’intervento sul tipo è illimitato ed è legato alla capacità d’invenzione
dell’architetto. Il tipo implica quindi cambiamenti e trasformazioni. -1700: la prima formulazione
dell’idea di tipo col teorico Quatremère De Quincy. Per lui il tipo permette
di istituire legami col passato; non deve essere confuso con il modello,
ovvero la ripetizione meccanica dell’oggetto. -1800: con Durand si passa dal
concetto di tipo visto come il “ragion d’essere della forma” al tipo visto
separatamente dalla forma. La parola “tipo” è sostituita dalla parola
“genere”, passando così a descrivere il programma degli edifici (prigioni,
ospedali, teatri, ecc); egli riduce il tipo all’uso a cui l’edificio è
destinato. -1900: col Movimento Moderno
l’edificio non è più caratterizzato dall’uso cui è destinato, ma dallo spazio
in cui l’attività si configura. Gli architetti diventano costruttori della
forma dello spazio, e non devono più preoccuparsi né di forma, né di
materiali (Moneo evidenzia questo mutamento del punto di vista nell’opera di
Mies van der Rohe). Con la nascita dell’industria e della produzione in
serie, il tipo si converte in prototipo, in quanto il modello può essere
esattamente riprodotto (riferimento a Le Corbusier e ai modelli di
abitazione, che permettono all’industria una riproduzione illimitata). -1960: nasce una nuova teoria con
l’obiettivo di studiare la continuità formale e strutturale della città
antica, vista come un naturale risultato dell’azione del tempo. “La storia
dell’architettura non è altro se non la storia dei tipi che popolano e
costruiscono la città”, come sostiene Rossi. Oggi la tipologia è assunta come
strumento di composizione esterna; la struttura formale interna è scomparsa
(vedi Venturi e Rossi). Vi è difficoltà nell’applicare la nozione di tipo
all’architettura attuale, pur riconoscendo l’importanza che ha nello spiegare
l’architettura del passato. |
|||
|
|
|||
|
Parte II (libro I) – Sull’insegnamento |
|||
|
I critici hanno cercato relazioni
dell’architettura moderna col passato e credono di vedere nell’architettura
del tardo 1700 un paradigma dell’architettura razionale. Moneo commenta
l’opera di alcuni architetti. -Durand: la composizione è lo
strumento con cui viene elaborato il progetto architettonico; essa permette
di rispondere alla varietà dei nuovi bisogni della società. È quindi per lui
essenziale insegnare nelle scuole i principi dell'arte e i meccanismi della
composizione, rifiutando una conoscenza basata sulla concezione tipologica
dell’architettura. Parlare di composizione implica parlare di elementi, che
sono per l’architettura ciò che le parole sono per il discorso: comporre
significa combinare i diversi elementi, e la bellezza origina dalla loro
disposizione, non dalla decorazione. Per Durand il fine dell’architettura è
l’utilità, ovvero essa deve soddisfare le esigenze di un certo programma; la
forma deve essere definita dalla semplicità. - Hejduk: Moneo descrive i metodi
di insegnamento usati nella Cooper Union School of Architecture di New York;
3 sono gli esercizi proposti allo studente: “the nine square grid problem”,
“the cube problem”, “the Juan Gris problem” (basato sulla pittura cubista).
La stessa architettura di Hejduk è volta all’insegnamento, perché in essa vi
si ritrovano i 3 esercizi proposti. |
|||
|
|
|||
|
Parte III (libro I) – Sul trascorrere del tempo |
|||
|
Moneo tratta dell’architettura greca, analizzando il tempio, ovvero
l’omaggio che la città tributa agli dei. Nell’architettura greca si ricerca
la bellezza e la perfezione, attraverso l’ordine e l’armonia. In un secolo il
tempio è riuscito a evolvere: costruiti inizialmente in pietra arenaria
stuccata (materiale innovativo rispetto al mattone), viene poi usato il
marmo, che instaura un rapporto particolare con la luce e con cui il tempio
greco conclude la sua storia. L’architettura greca è inoltre fortemente
legata al paesaggio e Moneo pone l’attenzione sullo stato attuale dei luoghi,
diventati turistici e profanati da alberghi e ristoranti, senza rispetto per
il paesaggio. L’architettura invecchia, e oltre alla patine del tempo spesso gli
edifici subiscono ampliamenti e cambiamenti che possono trasformarne
l’immagine originaria. Gli edifici devono essere aperti, ovvero adattarsi
alla mutevole realtà e al trascorrere del tempo; ciò ha introdotto i termini
di flessibilità e multifunzionalità. Se l’architetto, progettando, è conscio
di questa questione, i principi formali che ha stabilito nel costruire
l’opera permangono, sebbene l’edificio subisca modifiche. Moneo spiega questo
concetto riferendosi alla Moschea di Cordova e agli ampliamenti che l’hanno
interessata in 8 secoli. |
|||
|
|
|||
|
Parte IV (libro I) – Sul ruolo della tecnica |
|||
|
L’avvento di nuove tecniche porta non solo alla definizione di nuovi
procedimenti di calcolo per la stabilità, ma anche a trasformazioni
tipologiche e formali. Moneo si occupa qui del processo che l’architettura ha
seguito per impadronirsi di una tecnologia, con i problemi formali che
presuppone, riportando esempi di strutture a telaio in accaio e in cemento
armato (Perret, Le Corbusier, Terragni e molti altri). Entrambi questi
materiali sono plasmabili e hanno grande capacità di resistenza. Anche la prefabbricazione introduce un’innovazione tecnica nel campo
dell’architettura. Moneo passa poi a un altro argomento: gli edifici del passato comunicano
una consistenza che quelli di oggi non possiedono; Moneo desidera dare agli
edifici una consistenza che derivi dalla loro materialità. Si riferisce
pertanto all’uso dei mattoni al giorno d’oggi, riportando esempi
contemporanei. |
|||
|
|
|||
|
Parte V (libro II) – Sugli architetti
e il loro lavoro |
|||
|
- Aldo Rossi: Moneo vuole dimostrare
la continuità che sussiste tra teoria e progetto nell'opera di Rossi,
architetto determinante nella cultura architettonica degli anni 70/80. Rossi
ha lavorato con Rogers, Gregotti, ecc alla "Casabella" degli anni
60, che segnava una rottura col movimento moderno, e portava a
un'architettura meno elementare, capace di accettare la complessità del
reale. Si fa riferimento al libro
"l'architettura della città": la città viene intesa come una
architettura, considerando la sua costruzione e il suo sviluppo nel tempo,
sottoposto a leggi e norme. Rossi affronta l'argomento del come si costruisce
la città, partendo dall'individuazione degli elementi da cui è composta;
indaga sulla tipologia degli edifici e del loro rapporto con la città ,
sostenendo che a partire dal tipo si può spiegare la formazione della città e
la sua architettura. Bisogna tornare a pensare l'edificio partendo dalla
forma della città o da come esso forma la città. Vi è nella città per Rossi
una categoria architettonica associata alla memoria: i monumenti; essi sono
permanenze e vedono il passaggio di più generazioni; essi costituiscono la
città e danni senso alla vita della città, permettendo di ricordare il
passato. La città cresce dunque per punti (i monumenti) e per aree (quartieri).
Moneo dedica grande spazio a
descizione e commenti del cimitero di Modena e al teatro scientifico.
- Ieoh Ming Pei & Partners: lavora
nelle città americane di fine anni 50, quando le città sono in un periodo di
rinnovo urbano per rivitalizzare i centri decaduti: la vecchia trama della
città americana viene sacrificata a favore di una concentrazione volumetrica
capace di liberare il suolo (costruzione di grattacieli). Moneo descrive e
commenta la costruzione della nuova torre della compagnia di assicurazioni
John Hancock; con esso il grattacielo diventa un solido astratto,
smaterializzato e fragile, iscritto nella trama della città anche se sembra
ignorarla (il serramento è il grande protagonista dell'edificio). Grande è
stata la sua influenza sui grattacieli degli anni 70.
- Peter Eisenman: le sue prime opere
non prestavano attenzione al luogo e al programma; dagli anni 80 uno degli
aspetti principali della sua architettura è proprio l'interesse a istituire
una parentela tra edifici e luoghi, o meglio il loro passato. Moneo descrive
e commenta l'Ohio State University Wexner Arts Center for the Visual Arts.
Per Eisenman contesto significa accettare la presenza del quadro fisico
esistente, assumendolo come punto di partenza del processo che porta alla
creazione dell'opera di architettura; non è dunque lo scenario statico e
fisso in cui si interviene. Il contesto inoltre sta all'origine ma nessuno ne
assicura la permanenza; ecco perché Eisenman non considera l'aspetto visuale
o ambientale. Così come non fa una differenza tra l’esterno e l’interno: lo
spazio è unico. - Gehry versus Venturi: Moneo pone a
confronto due sale da concerto: la Philadelphia Orchestra Hall di Venturi,
Rauch e Scott Brown, e la Disney Concert Hall a Los Angeles Di Gehry. Per
Moneo i due architetti rappresentano i veri elementi motori dell’architettura
americana degli ultimi 25 anni. Venturi ha aperto a fine anni 70
un’era, chiedendo all’architettura maggiore complessità e più capacità di
comunicazione; Gehry ha fatto uscire l’architettura americana dal
post-modernismo. Venturi voleva un auditorio come quelli dell’Ottocento;
Gehry voleva invece offrire un’esperienza singolare e sorprendente; da qui la
diversità delle due opere. Venturi è sensibile al contesto; Gehry non ha
bisogno di preoccuparsi troppo del contesto (Los Angeles è in continua
evoluzione). Moneo conclude affermando che entrambe le opere hanno
appropriatezza: quella di Ghery è contingente, mentre quella di Venturi risponde
a delle necessità; necessità e contingenza sono concetti che Moneo sente
legati all’architettura ancora oggi. |
|||
|
|
|||
|
Parte VI (libro II) – Epilogo: la
solitudine degli edifici |
|||
|
Per Moneo c'è continuità
tra il progetto e l'edificio: solo i materiali possono dare realtà
all'architettura. L'architettura oggi non è più necessaria; gli architetti se
ne rendono conto, ma non affrontano il problema e cercano rifugio nella
fantasia, nei disegni: non potendo infatti servire la realtà, lavorano per un
mondo futuro utopico. Oggi gli architetti ignorano come sarà costruita
un'opera; per Moneo un disegno di architettura dovrebbe implicare il sapere
della costruzione. L'architettura ha oggi
perduto contatto con la società ed è diventata un mondo privato; per Moneo
invece dovrebbe significare coinvolgimento pubblico. Inoltre pone la
questione della durata dellarchitettura: nel passato, per un principio
economico, l’architettura doveva essere duratura (ipoteticamente doveva
durare per sempre); oggi invece è effimera, e noi siamo consci del fatto che
non è progettata per durare come nel passato. |
|||
|
|
|||
|
GLOSSARIO |
|||
|
Tipo – concetto che descrive un gruppo di oggetti caratterizzati
da una stessa struttura formale. Il concetto di tipo si basa fondamentalmente
sulla possibilità di raggruppare gli oggetti servendosi di similitudini
strutturali a essi intrinsiche. |
|||
|
Architettura – L’autore definisce l’architettura
come l’arte che ammette come condizioni del suo operare la necessità e gli
usi comuni del costruire e imprime alle forme del costruito determinati
caratteri di venerabilità o bellezza, per il resto non necessari. Essa si
interessa solo di quelle caratteristiche di un edificio che sono al di là del
suo uso comune. |
|||