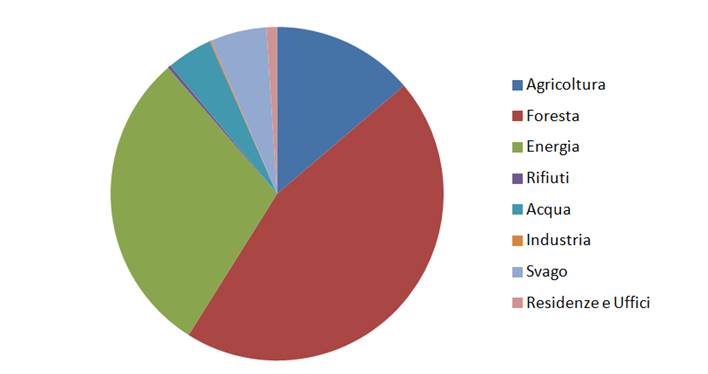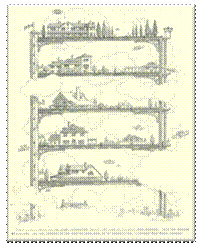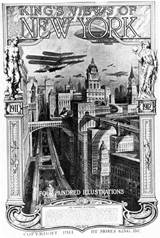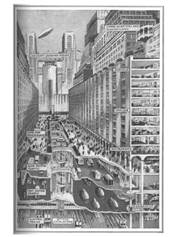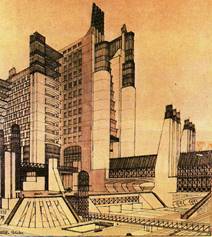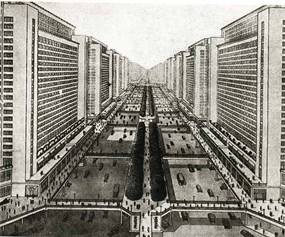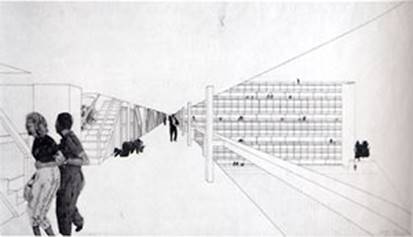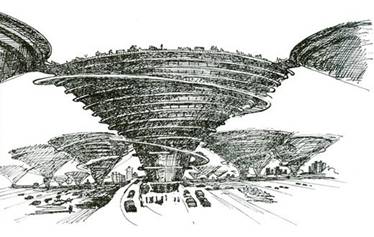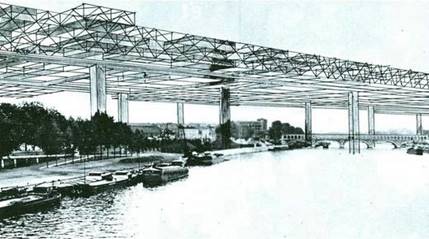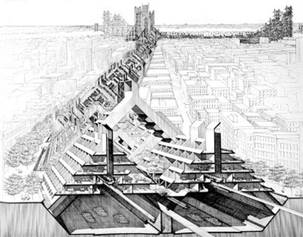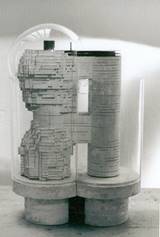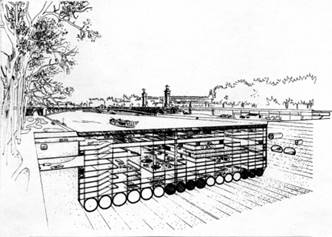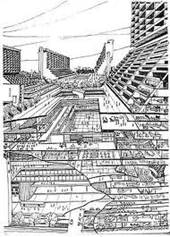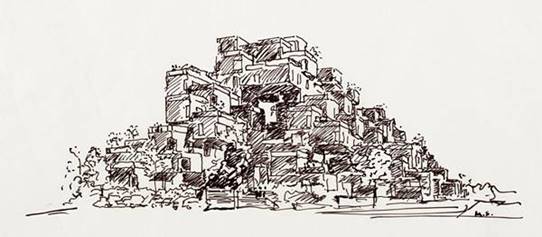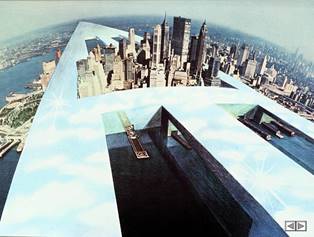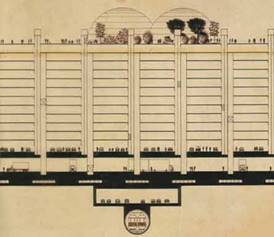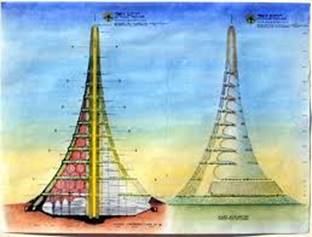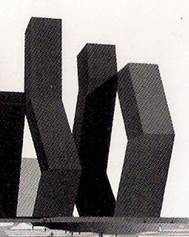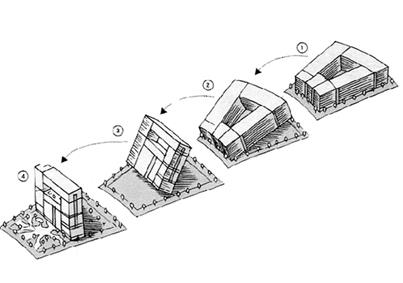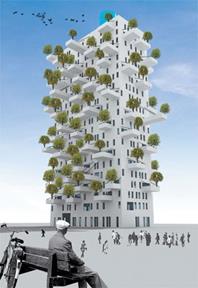|
|
|
|
||
|
|
autore |
MVRDV |
|
titolo |
KM3 Excursion on Capacities |
|
|
editore |
ACTAR |
|
|
luogo |
BARCELLONA |
|
|
anno |
2005 |
|
|
|
|
|
|
lingua |
INGLESE |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Argomento e tematiche affrontate |
|||||||||||||
|
KM3 è la storia di
un mondo che ha bisogno di spazio e di idee innovative per riuscire a
soddisfare tutte le esigenze di una popolazione in continuo aumento. KM3 è una città pensata a grande scala, larga (e alta)
alcuni chilometri, in grado di ospitare milioni di persone; è una città che,
ripetuta più volte, cambia la superficie terrestre andando al di là dello
sviluppo orizzontale e slanciandosi in verticale; è una città in tre
dimensioni che racchiude tutti gli spazi e i servizi necessari alla vita
dell’uomo. Per ora è solo un’idea, un progetto, una possibile teoria urbana:
alcuni problemi rimangono irrisolti, e la società non sarebbe ancora in grado
di vivere in tre dimensioni. Essa apre però la strada verso un nuovo modo di
pensare la città e lo spazio, non più diffuso e basato sullo “zoning” ma denso, compatto e sinergico: oltre al consumo
di suolo, si ridurrebbero anche i consumi di energia, acqua, tempo. Research is less sexy than photo spreads of architecture KM3 nasce da una ricerca condotta dagli MVRDV in
collaborazione con il Berlage Institute
sull’andamento della popolazione in rapporto alle risorse rimanenti. Da qui
emerge la necessità di “inventarsi” nuovo spazio, non prima di aver sfruttato
al meglio quello esistente, in base alle specializzazioni e attitudini di
ciascun territorio. Gli MVRDV descrivono quindi gran parte dei loro progetti,
realizzati nell’ottica di una città densa ed in tre dimensioni, dimostrando
che anche a piccola scala è possibile portare avanti un progetto globale. |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
Giudizio
Complessivo: 9 |
||||||||||||||
|
Scheda compilata da: Ilaria Bonfanti |
||||||||||||||
|
Corso di Architettura e Composizione Architettonica 2
a.a.2012/2013 |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
Autore: MVRDV |
|||||||||||||
|
Il gruppo MVRDV nasce a Rotterdam (Paesi Bassi) nel 1993
dalla collaborazione tra Winy Maas,
Jacob Van Rijs e Nathalie
De Vries. I tre architetti lavorano in stretta collaborazione ed i loro studi
coinvolgono architettura, urbanistica e paesaggio. I primi progetti, come la
villa VPRO e i WoZoCo apartments,
residenze per anziani ad Amsterdam, portano gli MVRDV alla fama internazionale. I progetti realizzati comprendono il padiglione olandese
per il World Expo 2000 di Hannover, il Flight Forum a Eindhoven, il Complesso
residenziale Silodam ad Amsterdam, il Centro
Culturale Matsudai in Giappone, il campus Unterföhring nei pressi di Monaco, l'Hotel Lloyd di
Amsterdam, la biblioteca a Spijkenisse, una piazza
della cultura a Nanjing, il Didden Village sui tetti di Rotterdam, il quartiere residenziale
Mirador a Madrid, solo per citarne alcuni. Il lavoro di MVRDV è esposto in tutto il mondo e ha
ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali. Le pubblicazioni
monografiche FARMAX (1998) e KM3 (2005) illustrano il lavoro dello studio di
Rotterdam. |
||||||||||||||
|
MVRDV: WIny Maas, Jacob Van Rijs
e Nathalie De Vries |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
CAPITOLI |
||||||||||||||
|
Capitolo 1 – CAPACITY Observation |
||||||||||||||
|
Should we change our behavior, our technology, and our territory, or
should we extend? Gli
MVRDV, con l’aiuto del Berlage Institute,
conducono una serie di ricerche sull’andamento della popolazione e sullo
sfruttamento delle risorse: gli studi rivelano un costante aumento della
popolazione che si deve confrontare con una lenta diminuzione di specie,
risorse e terreni coltivabili. Agli
inizi del terzo millennio, abitiamo quindi in un mondo che è più denso e
popolato di quanto non sia mai stato e necessita di maggiore spazio per
vivere, per produrre le materie prime per la sopravvivenza (energia, acqua,
cibo) e per assicurare la compensazione ecologica e la fornitura di ossigeno. Questa
processo messo in atto dall’uomo ha trasformato il pianeta in un unico grande
spazio colonizzato ed urbanizzato dall’uomo, la “Città Universale”. Procedendo
in questo modo, con la popolazione in continuo aumento, sarà impossibile
continuare a soddisfare tutti questi bisogni, se non apportando
un’innovazione nel modo di gestire lo spazio. Questa
innovazione può risiedere nell’idea di Capacity,
una nuova città che aumenta le sue possibilità e che riesce a soddisfare le
necessità dell’uomo utilizzando tutti gli spazi esistenti al meglio, anche
quelli attualmente poco sfruttati (mari, sottosuolo, cielo…). |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
Capitolo 3- (IM)POSSIBLE WORLDS Speculations |
||||||||||||||
|
When and where can new spatial capacities be expected? Per
capire meglio quali sono gli attuali meccanismi e come procedere nella
gestione dello spazio, gli MVRDV hanno ipotizzato una serie di possibili
scenari futuri. Questo metodo di studio porta ad avere infiniti scenari
possibili, ma riducendo il numero di variabili e considerandone una alla
volta, è possibile immaginare alcune situazioni interessanti. -
Studio dei cambiamenti climatici
e dei loro effetti sulla gestione dello spazio Problemi
emersi: surriscaldamento globale, scomparsa dei ghiacciai,
siccità Soluzioni
possibili: ridurre l’emissione di CO2
diminuendo l’uso di mezzi privati ed utilizzando energia alternativa, oppure
intervenire artificialmente sul clima. -
Studio dei fenomeni migratori Problemi
emersi: l’impossibilità di spostarsi liberamente da un territorio
all’altro provoca un disastro ecologico. L’esistenza di confini (politici,
storici, religiosi, ecc) limita fortemente le possibilità di crescita del
pianeta. Soluzioni
possibili: eliminazione dei confini e
possibilità di muoversi (e di fermarsi) liberamente. L’assenza di confini
porta anche ad uno scambio libero di beni, capitali e lavoro, che comporta un
migliore uso delle risorse globali. -
Studio sull’ottimizzazione del
territorio Problemi
emersi: risorse insufficienti per mantenere e nutrire la
popolazione in un immediato futuro (risorse energetiche limitate, foreste
insufficienti per assorbire la CO2 prodotta, aumento della desertificazione a
discapito di foreste e terreni agricoli). Soluzioni
possibili: pensare ad un mondo “aperto”,
appartenente a tutti, con un mercato libero e senza confini di alcun genere. In
questo modo, ogni cosa può essere prodotta nel territorio migliore e più
efficiente. Questo processo porta ad un mondo equilibrato, interdipendente ed
ottimizzato. |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
Capitolo 4- WORLD OF REGIONS Specializations |
||||||||||||||
|
In questo periodo di trasformazione globale si oscilla tra un processo
di globalizzazione tecnico-economica ed una ricerca di identità
socio-culturale. In questa opposizione sparisce il concetto di centralità
(comunicazioni e trasporti rendono ogni luogo ugualmente accessibile) ed
emerge l’importanza delle regioni. Ognuna di esse è in competizione
con le altre: mette in luce le proprie peculiarità per attrarre l’attenzione
su di sé e per sopravvivere come identità. Ogni regione aspira ad avere al
suo interno una centralità, che la rende unica ed importante per l’intero
pianeta; l’unicità e l’identità di ogni regione è legata alla sua
specializzazione (in ambito industriale, agricolo, energetico, economico,…),
che a sua volta dipende dal territorio. È ancora valido il concetto di
specializzazione in un mondo ormai globalizzato? Gli MVRDV rispondono a queste domande studiando casi problematici di
alcune regioni; osservando criticità e potenzialità di ciascuna regione
emergono i punti di forza che possono portare la regione stessa a diventare
una centralità nazionale o addirittura mondiale. |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
Capitolo 5 – THE 3D CITY Intensification |
||||||||||||||
|
What is the solution to the overwhelming process of global space
consumption? È necessario inventare una “Capacity” che permetta di risolvere il
problema (bidimensionale) del consumo di suolo, che elimini il bisogno di
prevedere grandi spazi vuoti attorno al centro urbano per una futura
espansione, che sia più compatta e densa per essere più produttiva. Per
creare questa nuova città bisogna abbandonare l’approccio bidimensionale e
pensare in tre dimensioni. Gli MVRDV hanno studiato un modello di città compatta, basata sugli
standard olandesi, in grado di ospitare al suo interno tre milioni di persone
e tutti i servizi (residenze, terreni agricoli, foreste,…) necessari alla
loro sopravvivenza. Per capire quanto spazio fosse necessario, sono state studiate le sue
funzioni: per inserirle tutte in modo compatto sarebbero necessari 1800 km²,
che corrispondono a 38km3 in un cubo di lato 3.7 km; a questo
volume va aggiunto però lo spazio necessario per la circolazione di aria,
luce e vento, fondamentali per la vita: il volume del cubo quindi aumenta
fino a raggiungere i 125 km3 (5x5x5km). Le 8 funzioni sono così organizzate: -
Agricoltura: per far ricevere
il giusto apporto di luce naturale, i terreni agricoli sono organizzati in
valli. Ogni coltivazione è disposta secondo una particolare geometria,
studiata in base all’intensità di luce e alla temperatura necessaria per la
fotosintesi. -
Foresta: necessita di maggior
volume rispetto alle altre funzioni. Sono necessari 39 km2 per
assorbire la CO2 prodotta da uomini e fabbriche, 228 km2 per
ricavarne materiali da costruzione e carta, 158 km2 per la nuova
generazione di foreste. Anche il territorio boschivo è disposto su valli e
differenziato in base alla necessità di luce, acqua e temperatura. -
Energia: la città necessita di
minor energia rispetto ad una città 2D perché è compatta e sinergica. Le
fonti di energia sono la biomassa (30%), il vento (35%) ed il sole (35%);
essa viene raccolta rispettivamente attraverso centraline che smaltiscono i
rifiiuti organici, mulini e pannelli fotovoltaici. -
Rifiuti: i rifiuti organici
(34%) vengono bruciati ed il calore raccolto è riutilizzato; quelli
inorganici vengono riutilizzati, riciclati o inceneriti. -
Acqua: potabile, per
l’irrigazione, per l’umidificazione, per la vita dei pesci, per le emergenze
di siccità. Tutta l’acqua utilizzata viene purificata e riutilizzata; quella
evaporata viene sostituita con l’acqua piovana, raccolta in bacini sopra la
città e in 3 laghi all’interno della città stessa. -
Industria: sono previste 16
produzioni diverse, divise in 496 processi produttivi. Posizionate vicino
alla loro fonte di approvvigionamento, si dividono in grandi industrie (XL),
vicine tra loro per sviluppare la massima sinergia, e industrie minori (S, M,
L), sparse nella città ed eventualmente spostabili. -
Svago: servizi per il tempo
libero distribuiti equamente nella città (circa una struttura per il tempo
libero ogni 300m) -
Residenze e uffici: spazio
relativamente piccolo rispetto alle altre funzioni del Cubo. Vengono
progettate 25 torri di 104x104m di base, interrotte nel momento in cui
incontrano una valle agricola o forestale. Sono posizionate una vicino
all’altra, ma ad una distanza che permette ad ognuna di ricevere il giusto
apporto di luce naturale. Alcuni aspetti della città sono sicuramente migliorabili (maggior volume
d’aria per evitare spazi claustrofobici, idea di città molto lontana da
quella odierna, studio più accurato della sinergia di settori differenti,
studio della sua fattibilità costruttiva, costi), ma essa introduce
importanti innovazioni (assenza di strade, sostituite da nuove
infrastrutture; possibile sviluppo della città in ogni direzione).
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
Capitolo 6- GENEALOGY Comparisons |
||||||||||||||
|
L’idea di ambiente urbano denso e sviluppato verticalmente è
già stato studiato e proposto, tra gli anni ’30 e ’60. In particolare nel ’68
si è sviluppata una linea di pensiero basata sull’architettura a grande scala
(città mobili, infinite, pensate in 3D), diretta da gruppi di architetti
quali Constant, Superstudio,
the Metabolists e da progetti “manifesto” come Spangen, LelyStadt, Bijlmermeer, Toulouse-Le Mirail,
Bofill’s Walden. I progetti a grande scala della generazione successiva sono
stati invece fortemente criticati per la loro uniformità e ripetitività (negazione
di un’individualità), pur essendo basati sul desiderio di progettare insieme
città e paesaggio. In questo tempo,
fenomeni come la globalizzazione, il mercato libero, gli spostamenti
quasi illimitati obbligano a pensare a larga scala; allo stesso tempo il
protocollo di Kyoto ha accentuato la necessità di compattezza. Questo
processo in atto porta quindi a lavorare sul concetto di densità. È possibile combinare
pensiero a larga scala con ecologia ed individualità? Per rispondere a queste domande gli MVRDV ripercorrono la
storia dell’architettura dall’inizio del Novecento ad oggi, studiando gli
esempi di architettura e città dense su più livelli. Inizio ‘900: interesse ed ossessione per i grattacieli americani e per
la loro potenzialità di aumentare la capacità delle città più congestionate. Walker, Skyscraper - Moses King, The Cosmopolis
of the Future - Harvey W. Corbett, New York Future Dal 1910: i mezzi di trasporto diventano accessibili a tutti:
necessità di valorizzarli con l’architettura. I veicoli vengono rialzati
rispetto al terreno.
Antonio Sant’Elia, La Città Nuova -
Giacomo Matte-Trucco, FIAT Lingotto 1920: viabilità diverse su livelli diversi; divisione verticale
delle funzioni. Le Corbusier,
Ville Contemporaine, - Ludwig Hilberseimer,
Vertical City 1930: Infrastrutture stradali come veri e propri edifici
lineari Le Corbusier, Unité d’Habitation de
Marseille, - Alison&Peter Smithson,
Golden Lane Anni ‘60 · città visionarie che si alzano
rispetto al suolo; Città nello spazio Walter Jonas, Intrapolis
- Yona Friedman, La Ville Spatiale · città come “frame” nello spazio.
Ricerca di alloggi flessibili.
Kenzo Tange, Boston Harbor · città compatta Walter Pichler, Compact City – Paul Maymont, City Under the Seine · Città 3D, città verticali con
diverse funzioni Spur, Asian City of Tomorrow – Bertrand Goldberg, Marina City · Moduli ammassati
Moshe Safdie,
Habitat ’67 Fine anni ’60: Radicalismo e cinismo Superstudio, Continuous Monument – Archizoom, NonStopCity 1990: Scarsità di suolo: le torri.
Norman Foster, Millenium
Tower – Tsui, Ultima Tower 2000: il disastro dell’11 settembre 2001 stimola nuovo interesse
per l’urbanistica in tre dimensioni. I nuovi obiettivi sono sicurezza,
economicità, stabilità. MVRDV, Kissing
Towers – SOM&SANAA, WTC In cosa consiste
quindi la città 3D? La città 3D consiste in un assemblaggio di densità, pubblico
accesso, differenziazione di spazi e funzioni, mix di funzioni. Gli MVRDV individuano inoltre una serie di parametri per
poter valutare una città 3D. Attraverso i seguenti parametri vengono prese in
esame le architetture 3D del ‘900 e viene dato loro un voto. Parametri: -
Floor Area Ratio (FAR): rapporto la superficie totale costruita
e la superficie del lotto -
% di livelli accessibili dal pubblico -
Numero di diverse funzioni -
Mix di funzioni |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
Capitolo 8- EXPERIMENTS Applications |
||||||||||||||
|
Un mondo più “denso” può essere costruito piano piano, pezzo dopo pezzo.
Questo è però un processo lungo e pesante, che necessita di una solida
copertura economica; È possibile
perseguire l’obiettivo della 3D City attraverso tanti piccoli interventi,
anziché pochi e grandi? Per esempio, in un progetto a piccola scala come un
quartiere residenziale, come si possono
conciliare desideri del cliente e piani urbani? Come si possono gestire
contemporaneamente il generale e lo specifico, il globale e il locale, la
grande e la piccola scala? Gran parte dei progetti degli MVRDV partono da questo
approccio: come esperimenti, testano il potenziale di “piccoli” programmi
rimanendo nell’ottica di una prospettiva più ampia. La loro architettura si basa su “gesti” apparentemente
semplici:
Come si può
contrastare questo fenomeno? Gli MVRDV pensano ad un’architettura visibile da lontano
che esprima esplicitamente la propria appartenenza alla città o regione. àHoek van Holland, NL, 2005
BEND Spazio definito da curve che creano diversi livelli,
segnano spazio aperto/chiuso, separano funzioni diverse, cambiano il rapporto
con il suolo. àCinema complex, Busan, KR, 2005
CLIMATIZE Spazi chiusi da un involucro trasparente, che aumenta
l'importanza del rapporto tra interno ed esterno. L'involucro trasparente
permette di far entrare la luce naturale durante il giorno -come se si fosse
in uno spazio esterno- e di essere visto nel buio durante la notte,
attraverso l'illuminazione artificiale interna. àPublic library, Spijkeniss,
NL, 2003-2007
CONNECT Connessioni all'esterno degli edifici, in cui insediare
servizi o infrastrutture: questo permette di rendere utilizzabile l'intera
superficie dell'edificio. Connessioni verticali/orizzontali. Spazi diversi per
distinguere le funzioni (lavoro/svago/servizi) àTarra Tower, office building, Buskavel Almere, NL, 1999-2002 (le connessioni esterne
previste nel progetto originario non sono state realizzate. Al loro posto
sono state lasciate le loro tracce)
COVER Copertura per diversificare, separare, unire, nascondere, circoscrivere
l’edificio o renderlo un tutt’uno con ciò che sta intorno. àSummer Pavilion for the Serpentine
Gallery, Kensington Gardens London, UK, 2004
DIG Progettare uno
spazio scavato nel terreno permette di lasciare inalterato
l'esistente (che sia esso costruito o naturale),
risolvendo il rilevante problema di rapporto tra vecchio e nuovo. Lo
spazio sottostante e quello sovrastante possono lavorare
insieme ed essere comunicanti oppure essere completamente
differenziati e non parlarsi. Spazio scavato nel terreno
per necessità o per il vincolo di avere un numero fissato di
piani fuori terra. Sviluppo dell'edificio al di sotto del suolo.
Ambienti totalmente diversi: illuminato ed areato naturalmente
il piano terra, buio quello interrato (spazi diversi per
funzioni diverse). àUrban plan Forum Les Halles,
Paris, FR, 2004
Rinnovare un edificio esistente, con costi non elevati.
Aumentare lo spazio interno mantenendo la struttura esistente. àBusiness Center all’interno del Rinderhalle
esistente, St. Marx, Vienna, AT, 2002
FLIP Ribaltare l’edificio portandolo verticale. Azione utile per
costruire con un basso consumo di suolo (elevato costo del terreno). Vista
panoramica. àMirador, Madrid, ES,
2001-2005
GROUND Appoggiare l’edificio su un suolo diverso dal terreno. àDidden Village,
Rotterdam, NL, 2002-2006
HANG “Appendere” elementi al volume principale dell’edificio.
Quest’azione permette di aumentare la volumetria dell’edificio senza
ulteriore consumo di suolo. àTorre Huerta, Valencia, ES, 2005
LAND Far atterrare gli edifici su un terreno che mantiene le sue
forme naturali. Gli edifici si appoggiano ad esso. Gli edifici si differenziano
naturalmente l’uno dall’altro, perché hanno inevitabilmente rapporti diversi
col suolo. Varietà di spazi. àHousing in Milan, IT, 2005
LIFT Sopraelevare gli edifici per lasciare libero il passaggio
ai loro piedi, per la presenza di acqua, o semplicemente per avere una vista
migliore dalla sommità dell’edificio. àWatervillas Ypenburg,
The Hague, NL, 1999-2005
MIX HORIZONTAL Differenziare gli edifici disposti uno di fianco all’altro per
differenziarne le funzioni o per ripetere lo stesso tipo con piccole
variazioni, in modo da creare un complesso (edificio o quartiere) unico, in
cui ogni singolo elemento mantiene una propria identità e riconoscibilità. àHagen Island, Ypenburg,
The Hague, NL, 2000-2003
MIX VERTICAL Differenziare gli edifici in senso verticale, per creare un
unico complesso (edificio o edificio-quartiere) con diverse funzioni e
trattamento degli spazi interni. àSilodam, Westerdoksdijk,
Amsterdam, NL, 1995-2003
OPEN Bucare l’edificio per creare una terrazza coperta che
permette di godere di una vista rialzata rispetto al suolo. L’apertura
all’interno dell’edificio, soprattutto se questo è alto ed imponente,
permette di favorire la ventilazione e creare uno scorcio visivo attraverso
l’edificio. àCelosia, Sanchinarro, Madrid, ES, 2001-2006
SPIRAL Percorso distributivo a spirale, che permette di avere un
camminamento continuo senza interruzioni ed inoltre non ostacola mai la vista
su uno spazio centrale. Distribuzione adatta per percorsi
espositivi/librerie. àBrabant Library,
Hertogenbosch, NL, 2001
STACK Tipo di edificio ancora in fase di sperimentazione.
Permette di risparmiare spazio (maggiore densità), energia, acqua, tempo ed
infrastrutture. Allo stesso tempo però crea problemi nella distribuzione
uniforme di luce e aria. àDutch Pavillion
World EXPO, 2000, Hannover, DE, 1997-2000 |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
Capitolo 10- OUT OF SPACE Escapes |
||||||||||||||
|
In questo capitolo conclusivo si prende in considerazione
la possibilità di espandersi nello spazio, creando satelliti terrestri
interessati da specifiche funzioni. Per fare questo è necessario sviluppare tecnologie
innovative e risolvere i problemi principali che l’uomo incontra nel momento
in cui si allontana dal suolo terrestre: mancanza di gravità, attraversamento
dei diversi strati dell’atmosfera, radiazioni, ecc. |
||||||||||||||