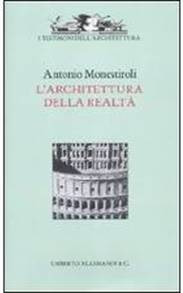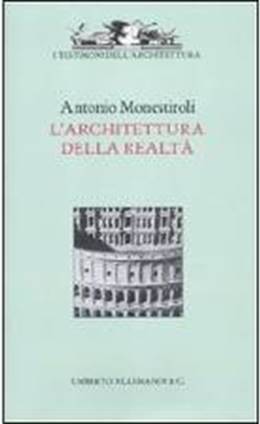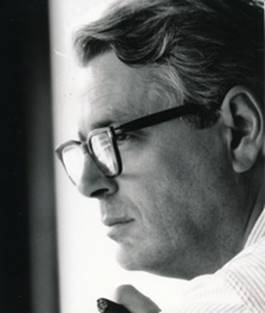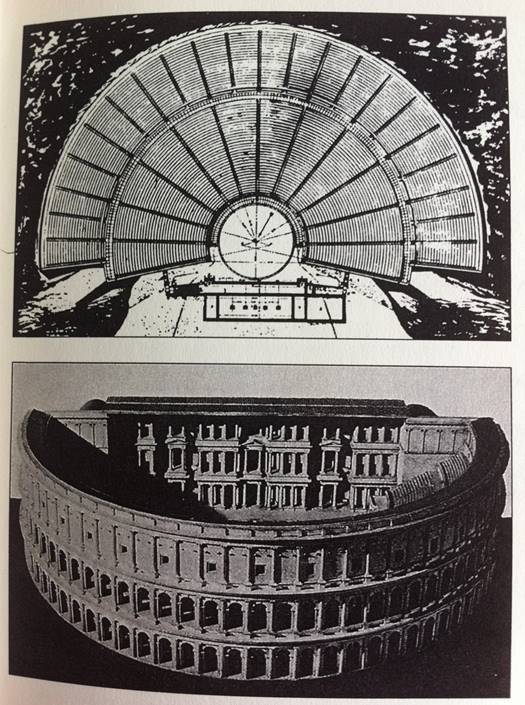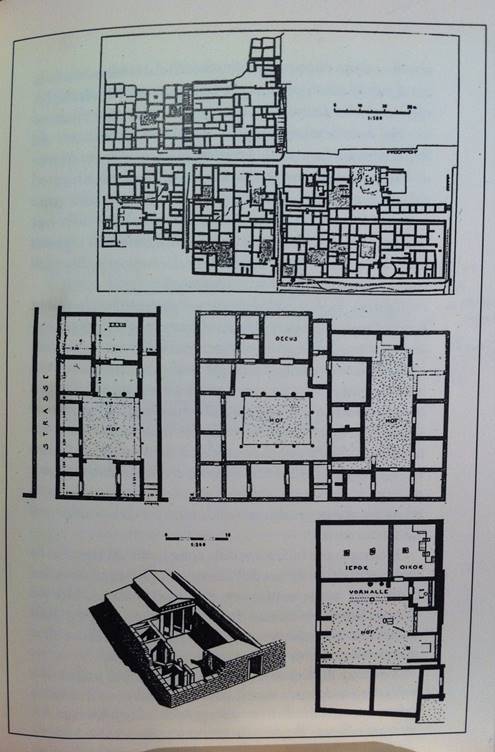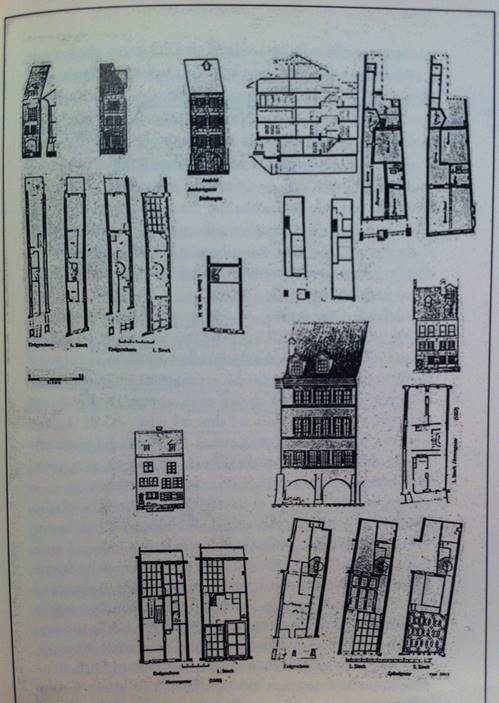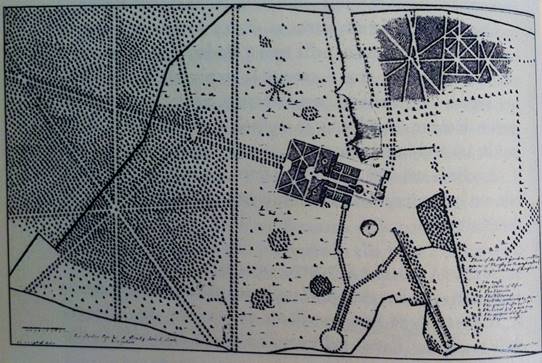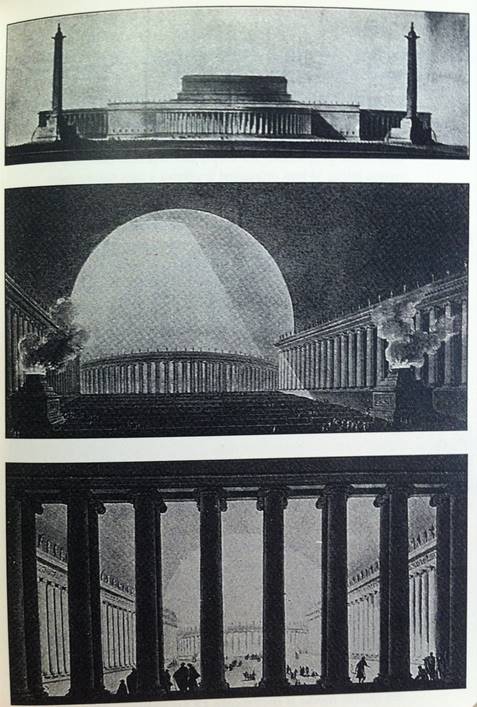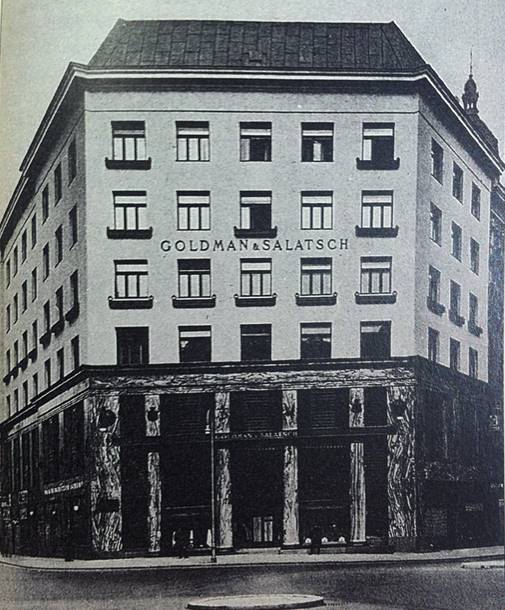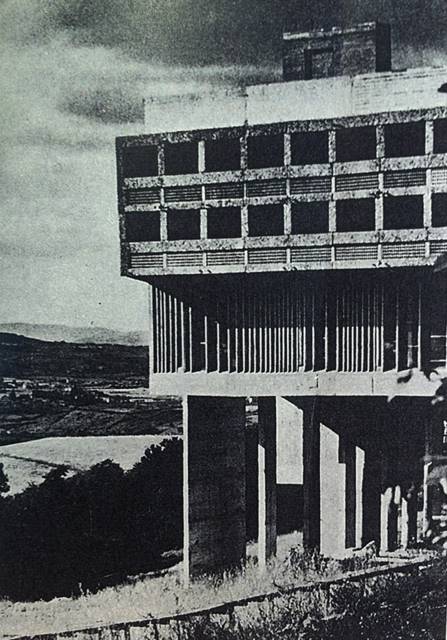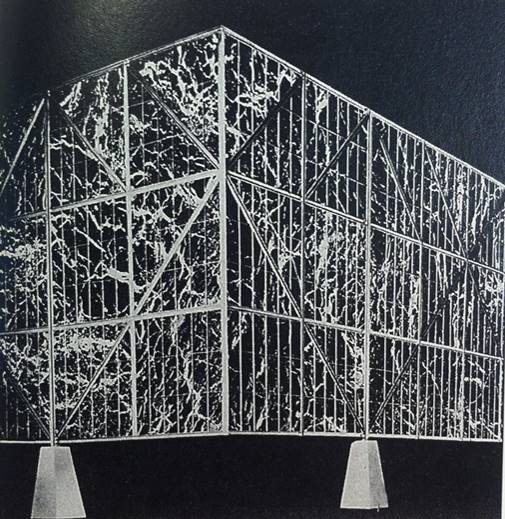|
|
|
|
||
|
|
autore |
ANTONIO MONESTIROLI |
|
titolo |
L’ARCHITETTURA DELLA REALTA’ |
|
|
editore |
UMBERTO ALLEMANNI & C. |
|
|
luogo |
TORINO |
|
|
anno |
2004 |
|
|
|
|
|
|
lingua |
ITALIANO |
|
|
|
|
|
|
Prima edizione: 1979 CLUP, MILANO |
||
|
|
||
|
|
Argomento e tematiche affrontate |
|
|
Questo libro comprende quattro testi elaborati da
Antonio Monestiroli nel corso degli anni ’70. Il primo, “REALTA’ E STORIA DELL’ARCHITETTURA”, è
apparso come piccolo libro autonomo nel 1977. Ad esso si sono aggiunti
successivamente “LE FORME DELL’ABITAZIONE” E “LA CITTA’ COME CONOSCENZA” per
formare nel 1979 la prima edizione dell’ARCHITETTURA DELLA REALTA’. Nel 1983 è stata pubblicata una seconda edizione che
comprendeva un quarto testo “ARCHITETTURA, NATURA, STORIA” e si è stabilita
la forma definitiva che il libro presenta oggi. L’obiettivo di Monestiroli è quello di identificare le
principali categorie che solcano il territorio dell’architettura e applicarle
allo studio dei grandi esempi di quelle opere e quei progetti ai quali si può
sempre tornare perché la sorgente del loro insegnamento è inesauribile. Il compito che il libro si impone serve a definire non
solo, con nitidezza, il programma delle successive ricerche teoriche, ma
anche ad affinare e mettere a punto i suoi nuovi strumenti di progetto. Uno dei temi più importanti affrontati, nonché uno dei
principi fondamentali dell’architettura moderna è il riconoscimento che non
vi è avanzamento artistico senza avanzamento conoscitivo e che l’obiettivo
dell’architettura è di costruire le forme della realtà con un livello sempre
più alto di autocoscienza. Infine Monestirole suggerisce che il vero compito dell’architetto
consiste proprio nell’interporre la realtà strutturandola con l’intervento
del pensiero e cercandola di renderla intelligibile, cioè dotandola di
un’architettura. |
||
|
|
||
|
Giudizio
Complessivo: 7 (scala 1-10) |
||
|
Scheda compilata da: Valentina Bellotti |
||
|
Corso di Architettura e Composizione Architettonica 2
a.a.2012/2013 |
||
|
|
||
|
|
Autore |
|
|
Antonio
Monestiroli è nato a Milano nel 1940, dove si è
laureato presso il politecnico nel 1965 con Franco Albini. Dal
1968 al 1972 è stato assistente e collaboratore di Aldo Rossi. Dal
1970 ha insegnato Composizione architettonica alla facoltà di
Architettura del Politecnico di Milano e dal 1997 alla facoltà di
Architettura Civile. E’
considerato, grazie ai suoi progetti, solo in parte realizzati, una delle
figure dell’architettura italiana del nostro tempo. Ha
curato l’edizione italiana del libro di L.Hilberseimer
su Mies Van Der Rohe(Milano 1984) e ha pubblicato, tra gli altri, i
volumi “L’architettura secondo Gardella” (Roma
1997) e la “Metopa e il triglifo” (Roma-Bari 2002) |
||
|
Antonio Monestiroli |
||
|
|
||
|
Contenuto |
||
|
Nel primo
capitolo si definisce l’architettura come attività conoscitiva che scaturisce
sia dalla realtà sociale che dalla realtà storica; si mette in evidenza
l’importanza della ragione collettiva degli edifici e della loro
riconoscibilità. Il secondo capitolo affronta lo studio della relazione
tra forme della residenza e costruzione della città e mostra come
l’architettura parta sempre dalla riflessione delle forme del passato viste
alla luce della realtà presente. Il terzo capitolo si concentra sulla cultura urbana del
settecento in particolare dell’illuminismo. Si analizza la città com’era e le varie proposte
avanzate dai teorici illuministi per risolvere i maggiori problemi presenti
nella realtà urbana dell’epoca.Si sottolinea in particolar modo il punto di
vista di Ledoux e il suo pensiero sulla costruzione della città. Infine nel quarto capitolo si studia il tema
dell’analogia e delle sue funzioni in architettura. Molto importanti sono l’analogia con la storia, con la
natura e con la tecnica; si osserva infine come tre grandi architetti del
movimento moderno le applicano al fine di costruire e creare tre diversi
linguaggi. |
||
|
|
||
|
CAPITOLI |
||
|
Capitolo 1 – REALTA’ E STORIA
DELL’ARCHITETTURA |
||
|
Si parte
dall' ipotesi che la progettazione sia un' ATTIVITA' CONOSCITIVA con determinate
regole e ci si chiede quale sia l' oggetto da conoscere nel progetto:
l'architettura stessa, l'universo logico delle sue FORME oppure la vita reale
degli uomini? La
risposta non è immediata: per fare il primo passo nell'elaborazione di un
progetto si deve definire l'IDEA fondamentale, nella quale si deve celare il
FINE ULTIMO dell'architettura. Tale IDEA
ARTISTICA è il risultato di un' intensa, precedente, attività conoscitiva
che ha come oggetti concreti sia la REALTA' ESTERNA(nei suoi nessi con
l'architettura) sia la REALTA' STORICA; tale attività è volta a definire il
fine di ogni architettura. Inoltre l'
IDEA ARTISTICA deve essere definita da una forte aspirazione alla
razionalità, la quale permette di evidenziare il rapporto che
l'architettura ha con la FORMA. Quindi
l'IDEA che si sta cercando si concretizzerà in una FORMA REALE che dovrà
rappresentare il superamento delle forme del passato. Tutto ciò
significa che l'ARCHITETTURA, concretizzandosi tramite una forma, è sempre
legata alla REALTA' e la realtà, essendo costituita da uomini, è
COLLETTIVITA'; ne consegue che l'ARCHITETTURA è COLLETTIVITA'. Il legame
che tiene salda l'architettura alla realtà è il “TEMA DI ARCHITETTURA”
determinato dalla stato di necessità e dalla riflessione sulla storia
della città. Naturalmente
questo tema, essendo il legame tra architettura e realtà, è prima di tutto elemento di costruzione
della città in cui vivono gli uomini, ma
ha anche, dentro di sé, una VOLONTA' COLLETTIVA che ha il compito di svelare
la sua stessa RAGIONE. L'architetto
deve perciò rendere evidente ciò che deve trasformare stando attento a non
cadere nel simbolismo e nel funzionalismo: l'obbiettivo è quello di far
riconoscere l'architettura, altrimenti il proprio scopo non è raggiunto! Per
riuscire in questo intento, come già detto, il TEMA DI ARCHITETTURA deve
avere una RAGIONE che deriva dagli aspetti più profondi della funzione;
quello su cui bisogna riflettere è la destinazione del proprio oggetto
architettonico, intesa come rapporto con la collettività e come
rappresentazione della vita che vi si svolge. Inoltre la
RAGIONE si definisce attraverso l'esperienza della sua costruzione storica;
ciò significa che non è mai fissa ed immutabile. Un buon
progettista quindi deve saper guardare l'architettura del passato, capire che
è prevalentemente costituita da forme che indicano le varie attività umane
che vi si svolgono ed infine deve essere in grado di trasformare tali forme
del passato adeguandole al presente, cercando di porre il proprio punto di
vista in un' “ottica collettiva”. “L'ARCHITETTURA
è CONOSCENZA e per farla avanzare essa si deve COSTRUIRE CONCRETAMENTE nella
STORIA liberandosi da tutto ciò che scinde la sua RAGIONE. Non è una
rappresentazione di un' ideologia ma VOLONTA' DI COSTRUZIONE REALE di un
Mondo diverso.” |
||
|
|
||
|
Teatro di Epidauro, pianta, IV
secolo a.C. Teatro di Marcello, modello, 13
a.C. |
||
|
|
||
|
Capitolo 2 – LE FORME DELL’ABITAZIONE |
||
|
“Voglio avere una casa che mi assomigli,
una casa che assomigli alla mia umanità, in bello.” E.N. Rogers In questo capitolo si studia la
relazione tra le forme della residenza e la costruzione della città. In particolare si cerca di studiare
le forme del passato per poi cercare di riadattarle in chiave moderna. Gli strumenti necessari ad
un’analisi di questo tipo sono: -conoscere la necessità storica in
cui la casa è stata costruita -l’ipotesi di liberarsi da questo
stato di necessità tramite forme più libere -essere coscienti del fatto che non
basta una sterile analisi funzionale -bisogna analizzare e criticare
guardando il rapporto tra le forme e l’idea generale di abitazione di una società,
dopo di che si può passare all’elaborazione teorica per riuscire ad
attribuire un’IDENTITA’ all’abitazione. Partendo dall’analisi della casa
antica dei Greci e dei Romani si capisce come il principio costruttivo
fondamentale della casa antica è definire un LUOGO; l’importante è il
rapporto della casa con quest’ultimo. Per definire come l’abitazione sia
stata gradualmente lo strumento che ha costituito le città si definiscono
successivamente tre periodi dell’organizzazione delle residenze in città: 1-
Periodo in cui prevale l’abitazione unifamiliare che forma la città per
isolati 2-
Periodo in cui si aggiunge, vicino agli isolati, la casa di affitto e
si definiscono le unità residenziali complesse. 3-
Dalle unità residenziali si cercano forme tipiche per costruire aree
residenziali. Partendo dal PUNTO 1- si analizzano i tipi della città preindustriale, come la
casa a blocco e a corte di cui si analizzano il carattere e la corrispondenza
del tipo con l’idea di casa. Per la CORTE si parte dalla “domus”
come prima forma di abitazione urbana, in seguito si vede la sua
trasformazione nel medioevo, nel quale si dà importanza non solo alla corte
interna, ma anche all’affaccio su strada , passando poi al suo ruolo nel
rinascimento fino ai tempi moderni. Nel rinascimento si capisce come la
corte si trasformi. Palladio non considera più la “ domus Romana”, ma la
trasforma dando importanza solo al cortile centrale tramite l’uso dell’ordine
gigante: la corte viene a coincidere con la casa stessa. Nella città moderna verrà ripreso
il tipo a corte con nuove forme e dimensioni per trovare le forme più adatte
all’abitazione di massa. Tramite questa analisi si vede come
“la corte” abbia avuto una continuità nella storia e abbia sempre contenuto
in sé il concetto di delimitazione di un LUOGO. Per il BLOCCO si fa capire come la
sua organizzazione si basi su un principio opposto a quello della corte: il
rapporto con la strada è predominante rispetto al rapporto con il suolo,
Anche in questo caso non ci si interessa delle origine del tipo, bensì si cercano i suoi caratteri propri nella
storia. Si cerca
di capire come i fattori esterni, come la forma del lotto o l’organizzazione
urbana abbiano condizionato la forma della casa. Successivamente
si osserva come l’aggregazione dei tipi appena citati formino gli ISOLATI,
ossia la più piccola parte di città delimitata da un tracciato viario.
Conseguentemente si analizzano i vari tipi di isolati della città
preindustriale che si possono definire “chiusi”: l’isolato a schiera,
l’isolato a blocco, l’isolato a corte. Passando
al PUNTO 2- e 3- si denota come,
dopo l’ XVIII secolo, si sviluppino diverse tendenze per la costruzione delle
varie aree residenziali e vengono riassunte in 4 punti: a) La tendenza a dare continuità all’esperienza di costruzione
delle aree residenziali per isolati. b) La tendenza a definire un rapporto
tra tipologia edilizia e morfologia urbana, ossia i vari tipi edilizi sono
elementi di costruzione della città. c) La tendenza a definire delle unità
residenziali complesse, ossia dentro a queste si riscontra la gerarchia degli
spazi liberi propri della città d) La tendenza ad avanzare delle
ipotesi alternative basate su un nuovo rapporto tra città e campagna. Sono
tendenze che vengono formulate in un arco di un secolo per rispondere alla
crescita improvvisa e caotica delle città europee e la sempre più presente
contraddizione tra campagna e città. Si passa
così ad analizzare le nuove tipologie delle case di affitto che sempre più si
affiancano alle case unifamiliari, sottolineando come le prime debbano andare
bene a tutti e non abbiano nessun carattere individuale. Per quanto
riguarda il problema dell’espansione indiscriminata del tessuto ottocentesco
e della continua differenziazione tra città e campagna viene presentata la
ricerca di Paul Wolf ; egli cerca le regole per la
costruzione dei luoghi dell’abitazione nella grande città secondo il
principio di rapporto con il suolo e con la natura. Wolf
è alla ricerca di principi ordinatori di una Grande città e pone la questione
“città-campagna” come prioritaria. Definisce inoltre un nuovo contesto
urbano, i “sobborghi”: luoghi in cui città e campagna si intersecano. Inoltre
critica le città ad alta densità per il loro rapporto con il suolo e la loro
mancata identità con le residenze; non risparmia neanche la città giardino
descrivendo come essa rinunci a definire i vari elementi urbani. Alla fine
del capitolo, si capisce che il
processo che scaturisce da tutte le analisi fatte(anche da alcune città europee),
è proprio dell’abitazione e della sua storia, ma anche dell’architettura e
della storia della città. La
costruzione della città deriva da un processo di continua ricerca delle forme
dell’abitazione le quali corrispondono a degli ideali costruiti per essa,
attraverso la liberazione dalle forme del passato. Le forme
devono diventare sempre più libere e consapevoli, anche se il movente
principale per il quale il progettista porterà avanti una ricerca
sull’abitazione sarà certamente la necessità di rispondere ai bisogni
materiali della società; bisogna però essere in grado di andare oltre anche
con l’immaginazione per cercare di definire sempre dei caratteri umani della
città. |
||
|
|
||
|
Priene, isolati a blocco e tipi edilizi del IV secolo a.C. |
||
|
|
||
|
Berna, tipi edilizi a blocco in profondità |
||
|
|
||
|
Capitolo 3 – CITTA’ COME AVVENTURA DELLA CONOSCENZA Architettura e teoria
dell’architettura nella città dell’Illuminismo. |
||
|
“Tutto il resto del giorno, immergendomi nella foresta, vi cercavo e vi
scoprivo l’immagine dei primi tempi di cui tracciavo fieramente la storia, e
svelando le menzogne degli uomini, osavo denudare la natura” J.J.Rousseau. In questo capitolo si analizza la
città dell’illuminismo, in particolare il rapporto tra l’architettura della
città e le teorie della progettazione di questa. Si parte definendo la città come
“luogo della conoscenza”, ossia un
luogo dove, nella propria costruzione storica, si possono riconoscere le
rappresentazioni del destino degli
uomini, le forme assunte per quest’ultime e i loro rapporti nella città
stessa. Di conseguenza gli uomini,
percorrendo la città, possono e devono riconoscere i propri destini. Si passa ad esaminare prima di
tutto la realtà storica urbana alla fine del settecento, in particolare si fa
capire come sia difficile comprendere le analisi che gli illuministi potevano
aver condotto per arrivare ai propri progetti di trasformazione della città. Si passa così a ricostruire
storicamente la realtà urbana sottolineando le TRASFORMAZIONI DELLA CITTÀ;
prima di tutto l’importante passaggio tra economia mercantile ed economia
industriale e le derivate conseguenze, successivamente la separazione tra
lavoro e proprietà che porterà ancora di più ad una netta divisione tra città
e campagna. Successivamente si considerano I MODI INI CUI SI È FORMATA LA CITTÀ: la presenza di un’economia mercantile porta
alla formazione di una città europea
di piccole dimensioni, l’incombere del mercato coloniale
porta alla formazione di una grande città. Di conseguenza nascono le grandi
capitali europee, luoghi di amministrazione dello stato. In
seguito si riporta come la CITTA’ SIA
COSTITUITA da tre parti: 1- Il vecchio centro storico 2- Aree residenziali della borghesia 3- Larghe zone periferiche Supponendo
che gli illuministi avessero avuto di fronte la suddetta REALTA’ URBANA, si
studia il dibattito sulle problematiche di essa: 1- Una parte di essi presenta una volontà di controllo della città con
gli strumenti dell’urbanistica classica. 2- Una seconda parte vuole portare
avanti una politica di negazione del fenomeno urbano e arriva a proporre una
dispersione delle attività nel territorio. Lo
sviluppo della realtà urbana seguirà naturalmente una terza via poiché ne la
prima ne la seconda proposta erano attuabili, per due questioni: la città
cresceva troppo in fretta e non c’era abbastanza tecnologia per permettere un
decentramento della città. Nel cuore
del capitolo si espongono finalmente le varie proposte di costruzione della
città dell’illuminismo: LA CITTA’ COME FORESTA LA CITTA’ COME RAPPORTO DI ELEMENTI
DISTINTI LA CITTA’ DISPERSA NELLA NATURA LA CITTA’ COME FORESTA Si presenta la visione di Laugier. Egli propone di considerare la
città come foresta, nella quale le strade della prima sono i viali di
quest’ultima e devono essere tracciati
nello stesso modo. Bisognerebbe avere la stessa
bizzarria e lo stesso ordine che vengono usati per creare i parchi; più in
questi ci sono disegni incrociati, figure differenti, possibilità di scelta
di contrasti più essi sono di una bellezza stimolante e deliziosa. Perciò Laugier
esorta ad applicare le stesse idee e auspica che i disegni dei parchi servano
da piani delle città dell’illuminismo. LA CITTA’ COME RAPPORTO DI ELEMENTI DISTINTI Nella città dell’illuminismo, come
nella città antica, l’abitazione e gli edifici pubblici assumono un ruolo
distinto riferito al loro diverso carattere. A tal proposito si analizza il
progetto di Gwynn per la parte Ovest di Londra e si
nota come l’area della residenza non
coincide con la città, ma ne è solo una parte. Gli edifici pubblici, invece, hanno
un’altra logica di localizzazione, derivante dal fatto che la città impone
loro di assumere dimensioni considerevoli per fare emergere i loro caratteri
monumentali; sono talmente grandi che devono essere visibili dalla campagna,
considerata come parte della città attraversata dai tracciati che collegano
funzioni propriamente urbane. Ogni elemento della città è
costruito secondo la propria ragione. LA CITTA’ DISPERSA NELLA NATURA E’ una città che stabilisce con la
natura un rapporto molto forte , si conforma con essa. La volontà è quella di costruire
una città immersa in una foresta, costruita con case unifamiliari tutte identiche
tra loro, simili a capanne dinanzi al recinto del proprio giardino. Esponente di spicco di questa
teoria è Ledoux, la cui sfida è definire i
caratteri della casa al di fuori del contesto urbano. Egli vuole trovare una logica
attraverso cui ricostruire l’architettura, la sua idea è quella di percorrere
la città dando la possibilità di scoprire i luoghi dell’architettura come
luoghi significativi della conoscenza. Dalle varie ipotesi di città
illuminista se ne deduce che l’obiettivo principale degli architetti
illuministi è la definizione del carattere degli edifici e la ricerca del
modo più semplice per rappresentarlo. Molta importanza viene data inoltre
agli edifici pubblici che hanno la funzione di rappresentare il carattere
della città; essi sono occasione di trasformazione della città e ogni singolo
edificio pubblico deve avere in sé un tema ed una storia. L’ architettura serve quindi a
rappresentare il destino degli uomini, deve
portare qualsiasi costruzione alla perfezione, e per arrivare a questo,
bisogna riflettere sulla destinazione degli edifici e la definizione del loro
carattere. Per manifestare quest’ultimo
bisogna tener conto dei principi della natura e delle sue leggi: così facendo
gli uomini abiteranno un’architettura della natura. Si costruisce così, da questi
principi della natura, una seconda natura che ha origini da principi più
alti: quelli della ragione. Infine si passa a constatare il
rapporto che gli illuministi avevano con l’antichità, per far capire come
fosse importante la ricerca della propria identità nelle origini. |
||
|
|
||
|
Colin Campbell, pianta di un parco
di Nottingham, 1715 (dal Vitruvius Brittannicus) |
||
|
|
||
|
Etienne-Louis Boullèe, progetto del Museo, 1783 |
||
|
|
||
|
Capitolo 4 – NATURA, TECNICA,STORIA Le forme dell’analogia nel linguaggio architettonico |
||
|
“Per noi ciò che decide è la vita” Mies Van Der Rohe Argomento di questo capitolo è il
LINGUAGGIO ARCHITETTONICO definito come l’uso di elementi semplici
dell’architettura e il loro uso nella
costruzione. Ci si chiede se sia possibile
definire delle regole proprie di questo linguaggio per poi creare una teoria
della progettazione architettonica. Per rispondere, si distinguono il
significato di LINGUAGGIO e di TIPO: il primo è un sistema di
rappresentazione del senso degli edifici, il secondo è l’adeguamento di un
genere di edifici ad una destinazione. Se di tipi ne possono esistere tanti e
diversi , il LINGUAGGIO è unico. La costruzione di un LINGUAGGIO
corrisponde alla costruzione di uno stile, che può essere assimilato ad un
linguaggio condiviso. Inoltre il LINGUAGGIO viene
definito come un sistema formale che definisce il senso degli edifici e contiene un
generale punto di vista sull’architettura. Si passa successivamente a definire
l’analogia, ossia il principio di definizione dell’arte come imitazione dell’arte
stessa. I termini di riferimento che sempre
si sono utilizzati sono la natura e la storia: la prima, nei tempi moderni,
non è più perfezione, ma conoscenza di un ideale, la seconda è ricerca dentro
la tradizione. Di conseguenza si capisce come ogni
architettura si fondi su una doppia analogia: quella con la natura che evita
che le forme diventino delle pure convenzioni e quella con la storia che
fornisce i materiali base del progetto. L’analogia con la natura non sussiste
se non c’è anche quella con la storia, poiché la prima fornisce i motivi di
rinnovamento di un contesto formale che si fonda sulla tradizione presente
nella seconda. Successivamente si descrivono le
tre funzioni dell’analogia: sintetica, fondata sull’unità de sapere, evocativa , che stabilisce un rapporto
visivo con le forme classiche ed ipotetica, dedicata alla costruzione per la
collettività. Infine si passano ad analizzare le
FORME DELL’ANALOGIA NELL’ARCHITETTURA MODERNA. Si riportano gli esempi di tre
grandi architetti del movimento moderno: Loos, Le Corbusier e Mies Van Der Rohe, ognuno dei quali dà
molta importanza sia all’analogia con la natura, sia all’analogia con la
storia, ma anche a quella con la tecnica. Le Corbusier
spiega come l’analogia con la tecnica abbia un ruolo fondamentale nella
costruzione del linguaggio architettonico: “analogia con le forme tecniche”
significa “adesione al rapporto con la natura e con le sue leggi”. La sua aspirazione è quella di
diventare un architetto come un “costruttore di areoplani”, ossia costruire
l’architettura come queste grandi macchine che definiscono la loro forma sul
rapporto fra il loro scopo e le leggi della natura. Mies Van Der Rhoe adotta la medesima analogia , ma non si ferma alle
forme tecniche, cerca la traduzione di esse in forme architettoniche. Loos invece è più legato all’analogia
con la storia; infatti egli afferma che” stabilire un rapporto con essa
significa voler essere all’altezza dell’architettura dell’antichità”. Ecco
perché nei suoi edifici si trovano sempre citazioni delle forme storiche. Ciò
non significa che Loos è un architetto storicista,
anzi, la sua grandezza sta proprio nella sua modernità e nella capacità di
andare oltre le forme storiche dell’architettura. La conclusione del capitolo fa
capire che Le Corbusier, Mies
e Loos non hanno costruito uno stile, bensì hanno
dato forma a tre linguaggi diversi tra loro, poiché ognuno di loro ha scelto
un diverso rapporto con la storia, con la natura e con la tecnica. Le Corbusier
nonostante si sia accorto dell’importanza della tecnica ha fatto prevalere
l’analogia con la natura, Mies ha dato più
importanza all’analogia con la tecnica, mentre Loos
ha ritenuto fondamentale il rapporto con la storia. Quello che però gli accomuna è che
tutti e tre pongono il problema dello stile come esigenza unica
dell’architettura, anche dell’architettura moderna. Ogni progettista, oggi, è chiamato a
riprendere la propria ricerca da dove questi grandi architetti l’hanno
terminata. |
||
|
|
||
|
Adolf Loos, casa nella
Michealerplatz, 1909-1911 |
||
|
|
||
|
Le Corbusier,
La Tourette, 1959 |
||
|
|
||
|
Loudwing
Mies Van Der Rohe, Convention Hall, foto del modello, 1953-1954. |
||
|
|
||
|
GLOSSARIO |
||
|
FORMA: ciò che costituisce la realtà, in particolare ciò di cui
è fatta l'architettura. |
||
|
TIPI
ARCHITETTONICI: ciò di cui è costituita
l'architettura, sono in particolare famiglie di forme che corrispondono a
determinate attività umane. |
||
|
COLLETTIVITA': ciò a cui deve mirare l'architettura. |
||
|
TEMA DI
ARCHITETTURA: legame diretto e concreto che
l'architettura ha con la realtà e con la collettività. |
||
|
LUOGO
DELL'ABITAZIONE: dove si abita, dove si “sta”, luogo in cui si vive la
propria vita quotidiana |
||
|
LINGUAGGIO: sistema di rappresentazione |
||
|
ANALOGIA:principio di definizione dell'arte come imitazione dell'arte stessa:
deve esistere una forma di riferimento intesa come forma esemplare. |
||
|
MIMESI: imitazione, primo livello del processo analogico. |
||