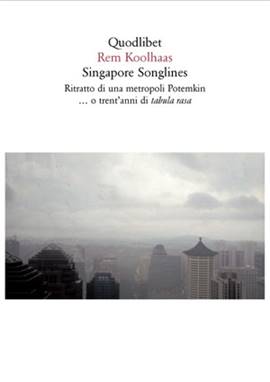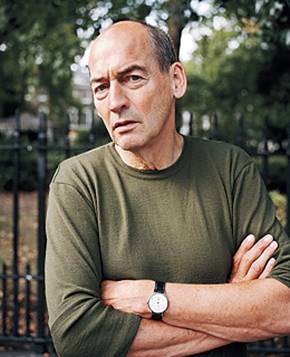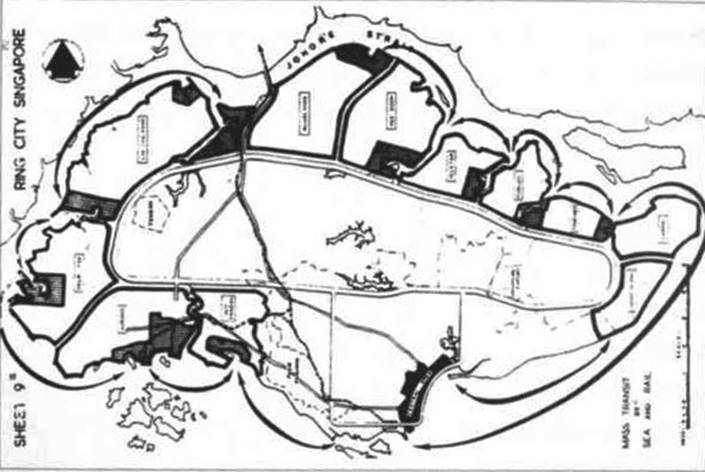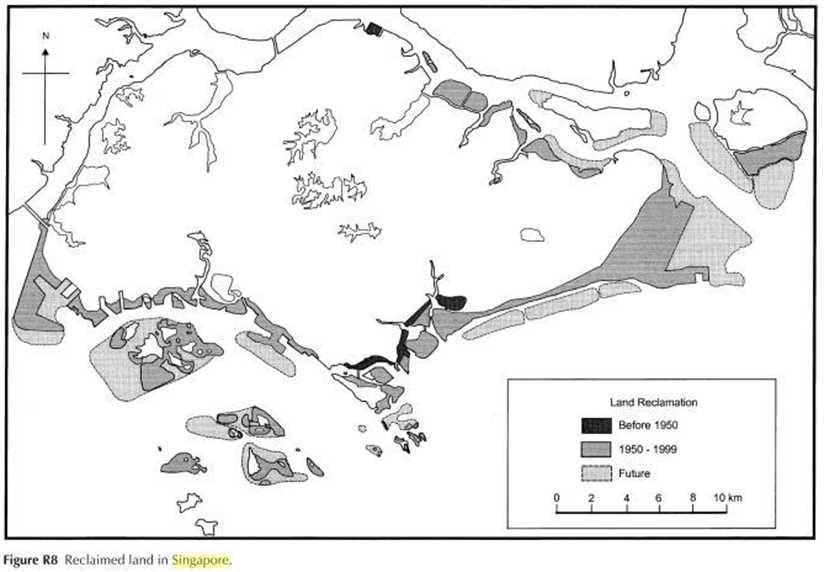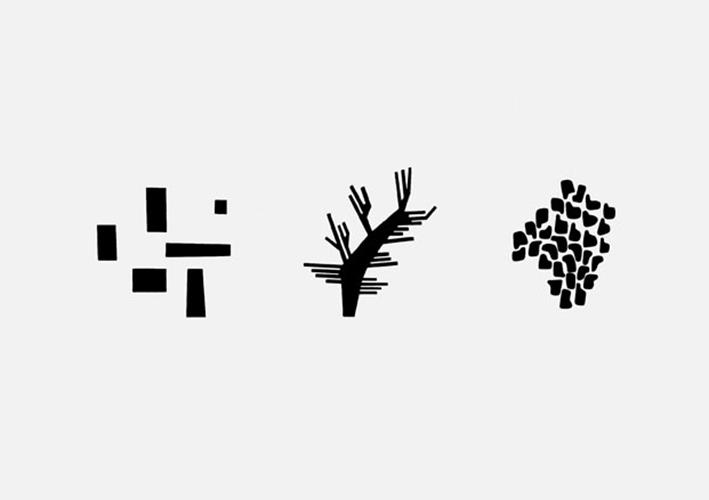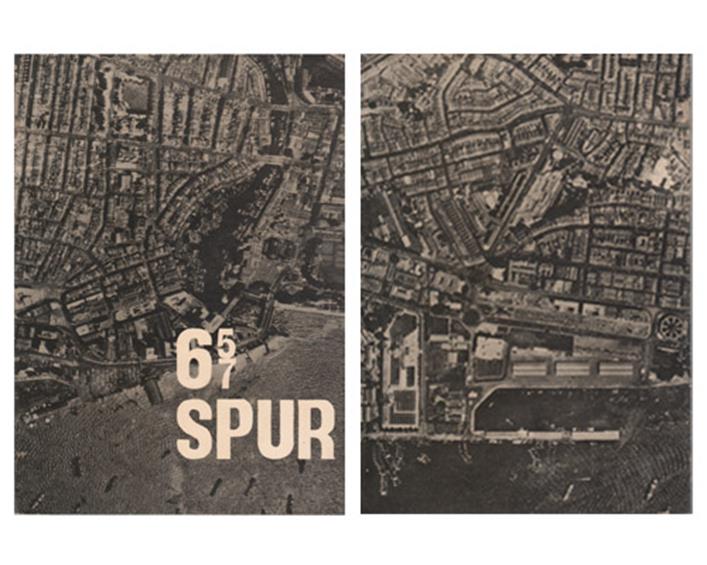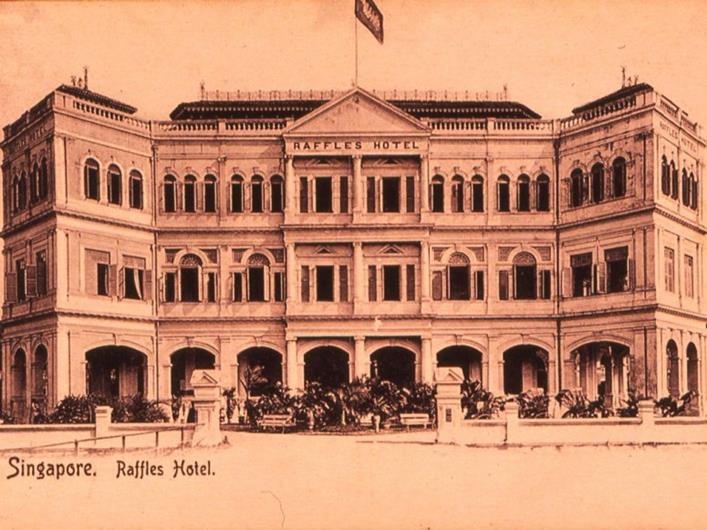|
|
|
|
||
|
|
autore |
REM
KOOLHAAS |
|
titolo |
SINGAPORE
SONGLINES. Ritratto di una metropoli Potemkin … o
trent’anni di tabula rasa |
|
|
editore |
QUODLIBET |
|
|
luogo |
MACERATA |
|
|
anno |
2010 |
|
|
|
|
|
|
lingua |
ITALIANO |
|
|
|
|
|
|
Prima
edizione: Tratto da “S,M,L,XL”, 1995 |
||
|
|
||
|
|
Argomento e tematiche
affrontate |
|
|
“Singapore Songlines, Ritratto di una metropoli Potemkin …o trent’anni
di tabula rasa” tratta di
urbanistica e delle trasformazioni delle moderne città prendendo come esempio
la metropoli asiatica. Sono presenti considerazioni di carattere economico,
politico e sociale che determinano la nascita lo sviluppo e le prospettive di
una città che è diventata un modello del mondo capitalistico. |
||
|
|
||
|
Giudizio
Complessivo: 8.5 (scala 1-10) |
||
|
Scheda compilata da: Giovanni Pancotti |
||
|
Corso di Architettura e Composizione Architettonica 2 a.a.2012/2013 |
||
|
|
||
|
|
Autore |
|
|
Rem Koolhaas (1944) si forma come giornalista e sceneggiatore
in Olanda, studiando architettura dalla fine degli anni Settanta prima a
Londra all’Architectural Association School
e poi a New York dove frequenta l’Institute for
Architecture and Urban Studies. Nel 1975 fonda con
Elia e Zoe Zenghelis l’Office for Metropolitan Architecture (OMA). Nel 1995 da vita ad AMO
(Architecture Media Organization) laboratorio che si occupa più di idee a
carattere intellettuale che di costruzioni. Nel 2000 vince il Pritzker Prize. Progetti
recenti: Negozi Prada di New York e Los Angeles Sede della televisione cinese CCTV,
Pechino Dallas
Center for Performing Arts Scritti: Delirious New York S,M,L,XL Junkspace |
||
|
Remment Koolhass |
||
|
|
||
|
Contenuto |
||
|
Koolhaas racconta la storia di
Singapore a partire dal 1959, data dell’indipendenza dalla Gran Bretagna,
fino agli anni 2000 soffermandosi sulle scelte che hanno condizionato la
demolizione e la succesiva ricostruzione. “Praticamente tutta Singapore ha meno di trent’anni: la città
rappresenta la produzione ideologica degli ultimi tre decenni nella sua forma
pura, incontaminata da residui contestuali sopravvissuti. E’ guidata da un
regime che ha esculso l’accidente e la casualità; anche la sua natura è
completamente rifatta. E’ pura intenzione; se c’è caos è un caos ideato; se è brutta è una bruttezza progettata; se è assurda è di un’assurdità voluta. Singapore rappresenta un caso unico di ecologia del contemporaneo.” |
||
|
|
||
|
CAPITOLI |
||
|
Introduzione |
||
|
L’introduzione
descrive lo stato attuale di Singapore che è una metropoli occidentale
vittima di un processo di modernizzazione forzata. La città che è composta da
diverse etnie (in ordine: cinesi, malesi, indiani) è controllato da un
governo dittatoriale che sta cancellando ogni tipo di traccia storica per
lasciare spazio ad un complesso ipermoderno e super
controllato. Le libertà personali sono sospese a favore di uno sviluppo
crescente distaccandosi cosi dal modello occidentale per creare un caso
particolare e molto interessante nel dibattito internazionale. Le cause di
questo panorama urbanistico sono da cercarsi nell’emergenza demografica
riscontrata negli anni Sessanta che ha portato la necessità di costruire un
innumerevole volume di sostanza urbana. |
||
|
|
||
|
Lee Kuan Yew ideatore di Singapore |
||
|
|
||
|
Intermezzo |
||
|
L’intermezzo descrive la situazione nel 1959 quando, dopo
l’indipendenza, l’avvocato Lee stravince le elezioni e si trova un’isola
formata da un’enorme Chinatown circondata da paludi. Le condizioni di vita
sono precarie, l’economia è stagnante e l’aumento demografico inarrestabile. Queste condizioni rafforzano il programma di città-stato e
la sopravvivenza è diventata lo scopo di una politica votata allo sviluppo. Nel 1960 è istituito l’Housing
and Developement Board (Hdb)
che nel giro di sei anni costruisce prima Queenstown
(160000 abitanti) e poi Toa Payoh
(180000 abitanti) piazzando delle stecche a contorno di aree comuni che
tentano di assolvere i bisogni della vita come: centri commerciali, parchi
giochi e luoghi di culto. Nei venti anni successivi ci si accorgerà che il
pragmatismo e la spasmodica necessità di risolvere il problema demografico
non hanno permesso un’adeguata ricerca e progettazione ma solo una caotica
sperimentazione. |
||
|
|
||
|
Queenstown |
||
|
|
||
|
La missione
Onu |
||
|
In questo capitolo Koolhaas
racconta l’evento che da legittimità alla megalomane operazione che il
governo di Singapore avrebbe attuato nei venti anni successivi. Nel 1963 l’Onu invia tre esperti l’americano Charles Abrams, il giapponese Susumu
Kobe e il tedesco Otto Koenigsberger per stilare un
rapporto: “Crescita e rinnovamento urbano a Singapore” e per consigliare la
giusta strategia di urbanizzazione. I punti fondamentali di questo processo
devono essere la conservazione, la riabilitazione e la ricostruzione, quindi
il primo passo è di trovare sul territorio i punti di pregio e quelli deboli
per poterli rinforzare. Viene anche specificato che è un intervento di
modernizzazione e che quindi essendo in rapida crescita, soprattutto
demografica, si avrà bisogno di nuove abitazioni e di nuovi interventi, circa
cinque quartieri nuovi per ogni quartiere distrutto. La missione ha come esito non tanto un piano regolatore,
considerato troppo rigido, ma un manifesto formato da tre parti: concetto
guida, programma d’azione, mappa d’azione. A questo è associata una volontà
di coinvolgere l’iniziativa privata e dopo aver compreso che l’isola di
Singapore e la città sono un’unica entità urbana optano come modello
insediativo quello olandese della “città ad anello”. ”Vent’anni attorno ad
una rattrappita riserva centrale l’intera isola è trasformata in New town”. |
||
|
|
||
|
Rapporto
Onu proiezione della citta ad anello sull’isola di Singapore. |
||
|
|
||
|
Tabula rasa |
||
|
La tabula rasa
secondo l’autore è il metodo scelto dalla repubblica di Singapore per ricostruire
la città. L’estrema povertà spinge il governo a utilizzare le poche
risorse che hanno a disposizione: il suolo. Inizia quindi una catena di
espropri (1200 in venti anni) e di mobilitazione di famiglie (270000 circa un
terzo della popolazione). La superficie dell’isola è aumentata del 25% in
trentacinque anni sbancando le colline e addirittura vengono comperate delle
isole dall’Indonesia che sono trapiantate sulle coste. Vengono ridistribuiti anche gli abitanti che vanno a
vivere in una delle venti New town che circondano
il centro. Nel 1989 87% della popolazione vive in alloggi del Hdb per un totale di 2,3 milioni di persone. In questo periodo dove il fare ha sottomesso il pensare
gli intellettuali asiatici riflettono sul problema urbanistico e rinnegano
la tabula rasa modernista. Fumihiko Maki scriverà che il rimuovere il distruggere e
il rimpiazzare in modo meccanicistico è il peggior modo per creare mescolanza
cosmopolita, mentre a Singapore adottano questo programma disutopico senza sosta. Il progetto
diventa manifesto delle capacità dello stato che nonostante sia uno dei
massimi esempi di capitalismo riesce a prendersi cura di tutta la sua
popolazione e Koolhaas stesso lascia in sospeso le
motivazioni della riuscita di questo piano che in Europa ha molte volte
fallito. Mentalità asiatica o maggiore autoritarismo? |
||
|
|
||
|
Territori
rubati al mare |
||
|
|
||
|
Lavagna Barthina |
||
|
L’autore paragona Singapore al lavoro di Roland Barthes che disvela dei sistemi apparentemente
imperscrutabili. Definisce cosi la metropoli asiatica come una lavagna barthiana sulla quale si possano sperimentare gli effetti
della politica sul territorio (impero
della semantica). Un altro confronto è fatto poi con la cucina e
Singapore risulta essere un insieme di culture totalmente isolate tra di loro
(a differenza del crogiuolo americano) ma manipolate nell’identità da un
ambiente totalmente nuovo. Anche i sistemi educativi e quello dei divieti
sono segni di una politica forte che ha lobotomizzato una modernità priva di
ambizioni artistiche, incontrollabili e sovversive. |
||
|
|
||
|
Singapore is a “fine” city |
||
|
|
||
|
Contesto architettonico |
||
|
In questo capitolo è descritto il contesto architettonico
degli anni Sessanta durante lo sviluppo di Singapore. Il movimento più
interessante secondo l’autore è quello giapponese con a capo Maki: i metabolisti. Con investigation in collective forms mina alla base la rigidezza schematica del
modernismo sostenendo che la società moderna è caratterizzata: da una grande
eterogeneità, da una crescente rapidità di comunicazione e di espansione
della struttura sociale e dal progresso tecnologico. Da quest’analisi Maki
estrapola: ”La forma collettiva” e ne analizza in particolare la forma a
gruppi poiché questi elementi sono in grado di creare un’infinità di fattori
comuni formali e funzionali. Lo spazio fondamentale è quello pubblico di
mediazione che come un’agopuntura rivitalizzerebbe i centri delle città
attraverso la progettazione di corridoi urbani e stanze urbane. Il lavoro di Maki è anche interessato allo shopping in
quanto, nella cultura asiatica, non assume quel significato puramente
consumistico ma essenza della vita urbana al pari dell’agorà. |
||
|
|
||
|
Collective form: compositiva,
megastruttura, gruppo |
||
|
|
||
|
Lo Spur |
||
|
Il Singapore
Planning and Urban Research Group è la risposta
dell’intellighenzia dell’architettura di Singapore alla politica urbanistica
adottata dal governo. Fondato nel 1965 da William Lim
e Tay Kheng Soon comprendeva una ventina di membri e altrettanti
partecipanti occasionali. Esso cercava di dar voce alla popolazione e
proponeva una partecipazione all’iniziativa statale, proponeva una pausa di
riflessione dopo la febbrile costruzione delle prime New Town e cercava di
instaurare un dibattito critico aperto al grande pubblico. Essi vennero
lasciati ai margini e mai coinvolti nell’esperienza di rinnovazione in quanto
le forti tematiche sostenute dallo Spur come
Storia, Contesto e Comunità vennero sempre viste come sottigliezze atte a
rallentare il processo di modernizzazione. Su alcuni punti come la grande
densità e la necessità di sviluppare gli edifici in altezza erano comuni con
il regime ma Lee in persona decise in varie occasioni di prendersi gioco del
gruppo di pensatori. S’instaura cosi un paradosso: il gruppo più progressista
spingeva per l’arretratezza e la riflessione mentre doveva assistere
impotente al successo di una sregolata crescita. |
||
|
|
||
|
Prima publicazione dello SPUR |
||
|
|
||
|
Gli effetti dello Spur |
||
|
Il capitolo riassume brevemente i fatti e pone l’accento
su come per una volta il governo sia riuscito ad affrontare e a risolvere un
problema in discordia con gli architetti e come la Tabula rasa sia diventata una sorta di parco giochi per i
governanti e addirittura con il senno di poi un’opera di avanguardia metabolista. |
||
|
|
||
|
Il metabolismo sulla Beach
Road |
||
|
Siamo nel 1967 e il problema abitativo è stato
parzialmente risolto quindi lo stato decide di mettere all’asta alcuni lotti
per non soffocare l’iniziativa privata su due strade: la Golden mile di beach road e la Eu Tong
Sen Street dove sorgono in pochissimo tempo una decina di opere
all’avanguardia. Il People’s park complex racchiude in una stecca e in un podio la versione
condensata di una downtown cinese e
i concetti di “corridoio urbano” e “città a stanze” teorizzati da Maki. Il
complesso più avanzato è il Woh hup:
sedici piani a gradonate che racchiude 370 negozi 500 posti auto e uffici.
Questo è il primo esempio di Megastruttura asiatica essa scopre le proprie
strutture al clima tropicale che legate alla cultura orientale si fonde in un
esempio pienamente funzionante di questa tipologia di edificio molte volte
scartata in occidente. |
||
|
|
||
|
Woh hup complex |
||
|
|
||
|
Dopo-sbornia prometeico:
il prossimo giro |
||
|
Questo capito spiega come singapore
si sta muovendo negli ultimi anni dopo la febbre metabolista
e sta cercando di trovare una sua identità, anche se lo spettro della tabula rasa rende il tutto fermo ma
dal futuro incerto per cui rende impossibile l’Architettura. Dopo
l’urbanizzazione disperata Singapore si sta trasformando in un immenso centro
commerciale/parco divertimenti perseguendo una politica di “isolanità” più spiagge e più resort
. Si è deciso anche di recuperare la natura utilizzando lo stesso meccanismo
della tabula rasa e cosi ricreando
una natura Potemkin dove il solo clima tropicale
rimane autentico che come effetto ha un decadimento accelerato. L’ironia
finale sta nella frase “dopo i sampietrini, la spiaggia” |
||
|
|
||
|
Raffles hotel la storia coloniale di Singapore |
||
|
|
||
|
Proscritto: metastasi |
||
|
La condizione ancora rurale della Cina collegata alla
migrazione di miliardi di persone verso le città e la conseguente massa
urbana ancora da costruire rendono l’isola di Singapore un modello per la
modernizzazione cinese. Si prevede la nascita di nuove metropoli sul
continente che hanno come unica tipologia il grattacielo. |
||
|
|
||
|
Note |
||
|
Songlines: il termine deriva dall’omonimo libro di Bruce Chatwin dove sostiene che il
continente australiano sia attraversato da percorsi lungo cui il cammino del
popolo aborigeno si è sedimentato in canti iniziatrici |
||
|
Potemkin Village: termine giornalistico inglese che sta ad indicare edifici
o parti di città costruiti a fini propagandistici |
||