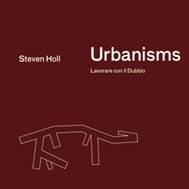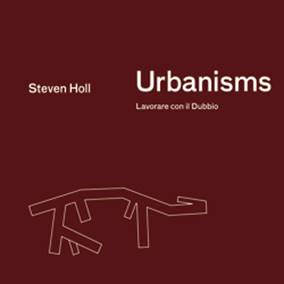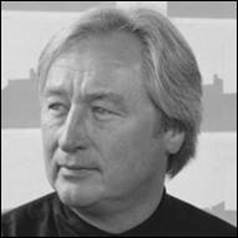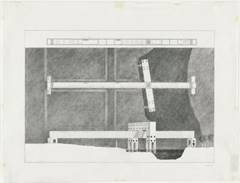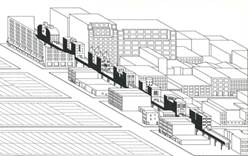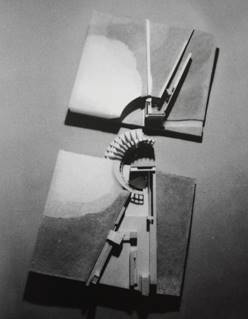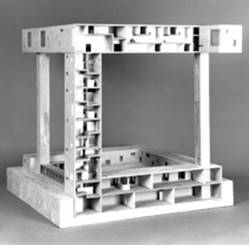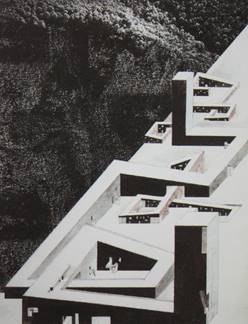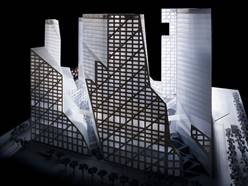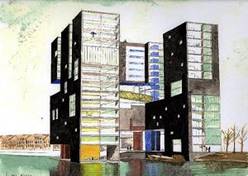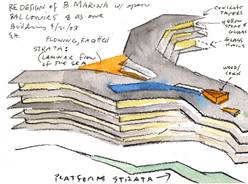|
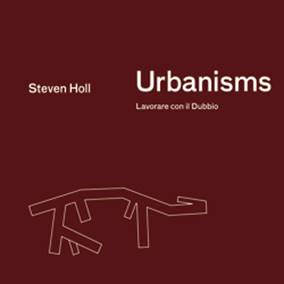
|
Argomento e
tematiche affrontate
|
|
|
In questo libro Steven Holl passa all'analisi della città,
della macroscala che si contrappone alla microscala della casa. Il libro
illustra come alla macroscala non basti più creare spazi soltanto attraverso
la luce, i materiali e i dettagli come avviene alla microscala della casa;
gli obiettivi sono diversi, più ampi: entrano in gioco anche la percezione ed
i sensi. Si deve pensare a costruzioni ibride, in cui le funzioni si
sovrappongono; si deve pensare a nuovi tipi di spazio pubblico; si deve
ridefinire la forma dei grandi edifici in modo da offrire un nuovo tipo di
esperienza degli spazi pubblici. In un'ottica di un'architettura integrata,
cioè di fusione tra paesaggio, urbanistica e architettura, la grande scala
urbana inizia quindi a trasformarsi attraverso la microscala. Per raggiungere
questo obiettivo diventa indispensabile ed inevitabile lavorare con il
dubbio, inteso come atteggiamento mentale aperto che rende possibile
riunificare le riflessioni sul luogo e sulla cultura. L'urbanista deve
lavorare quindi con il potere esperienziale delle città, che non può essere
razionalizzato, ma deve essere studiato soggettivamente. In quest'ottica
quindi si parla di urbanismi e non di un'unica teoria urbanistica.
|
|
|
|
|
|
Giudizio Complessivo: 9 (scala 1-10)
|
|
|
Scheda compilata da: Laura Gaetani
|
|
|
Corso di Architettura e
Composizione Architettonica 2 a.a.2012/2013
|
|
|
|
|
|
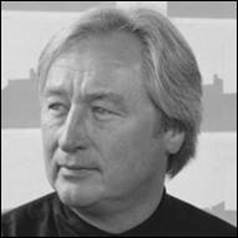
|
Autore
|
|
|
Steven Holl, classe 1947, è un'architetto statunitense nato a
Bremerton, Washington. Laureato all'Università di Washington, ha proseguito
gli studi di architettura a Roma, dove ha fatto la tesi di dottorato su Carlo
Scarpa, e alla Architectural Association di Londra. Nel 1967 ha costituito il
suo primo studio a New York. Ha vinto numerosi premi e riconoscimenti ed i
suoi lavori sono stati anche esposti al MoMA di New
York.
Tra i progetti più significativi si possono citare Kiasma ad
Helsinki (1998), l'Higgins Center a New York (1997/2005), Linked Hybrid a
Beijing (2003/09), Simmons Hall al MIT di Cambidge in Massachusetts (2003),
il Knut Center in Norvegia (2009).
Steven Hall affianca all'attività progettuale la stesura di
molti libri tra i quali "Parallax" in cui esprime il suo approccio
all'architettura, e "House" in cui analizza la microscala della
casa e di cui "Urbanisms" può essere visto come un completamento.Attualmente è docente di architettura alla
Columbia University.
|
|
|
Steven Holl
|
|
|
|
|
|
Contenuto
|
|
|
Il libro,
diviso in due parti, tratta la macroscala urbana. Nella prima parte del libro
vengono definiti i principi che secondo Steven Holl vanno seguiti per
raggiungere l'obbiettivo di architettura intesa come fenomeno esperienziale,
che di conseguenza, essendo le esperienze un fenomeno soggettivo, portano
alla nascita di molteplici teorie urbanistiche. Nella seconda parte espone
suoi progetti, realizzati e non, che tratano la grande scala urbana.
|
|
|
|
|
|
PARTE 1
|
|
|
In
questa prima parte del libro, Steven Holl esprime quello che secondo lui è l'atteggiamento
teorico e pratico da seguire, attraverso l'individuazione di undici punti
fondamentali. Questi principi sono quelli da applicare nella progettazione
della grande scala urbana, di quella che lui chiama la
"Macroscala", per ottenere una serie di esperienze urbane
soggettive che portano l'urbanistica al di là della visione prettamente
razionalista ed oggettiva. Ciò che deve cambiare è quindi la percezione che
si ha di uno spazio.
Più
sotto, nella parte del glossario, sono riportati gli undici punti con la
relativa spiegazione.
|
|
|
|
|
|
PARTE 2
|
|
|
Nella seconda parte del libro, invece, illustra progetti e
realizzazioni da lui fatti in varie parti del mondo e che riguardano la macroscala
urbana. In questa parte del libro i progetti vengono organizzati
geograficamente.
|
|
|
|
|
|
- NEW YORK
|
|
|
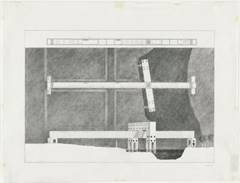 1) Gymnasium Bridge (South Bronx, New York 1977) : pensato
come una serie di ponti che si sormontano, è un chiaro esempio di edificio ibrido
in cui vengono condensate le attività della vita sociale, le attività
ricreative ed il lavoro. 1) Gymnasium Bridge (South Bronx, New York 1977) : pensato
come una serie di ponti che si sormontano, è un chiaro esempio di edificio ibrido
in cui vengono condensate le attività della vita sociale, le attività
ricreative ed il lavoro.
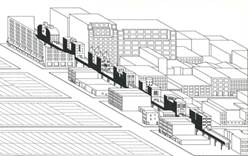 2)
Bridge of Houses (New York City, New York 1979) : pensato
come riuso di un tratto di collegamento ferroviario sopraelevato, questo
complesso di natura residenziale mira a garantire la coesistenza di diverse
realtà socio economiche. Infatti le nuove abitazioni, allineate con il fronte
strada, sono sviluppate secondo diverse tipologie. Alternati alle case ci
sono una serie di cortili che permettono di avere il 50% dello spazio
all'aperto. 2)
Bridge of Houses (New York City, New York 1979) : pensato
come riuso di un tratto di collegamento ferroviario sopraelevato, questo
complesso di natura residenziale mira a garantire la coesistenza di diverse
realtà socio economiche. Infatti le nuove abitazioni, allineate con il fronte
strada, sono sviluppate secondo diverse tipologie. Alternati alle case ci
sono una serie di cortili che permettono di avere il 50% dello spazio
all'aperto.
 3) Parallax Towers (New York City, New York 1989) : questo
progetto per Manhattan, prevede che lo scalo ferroviario sulla
Settantaduesima sia trasformato in un parco pubblico che si estende fino
al fiume Hudson. Sul fiume si stagliano grattacieli ultrasottili, costruzioni
ibride polifunzionali collegate tra loro da un sistema di trasporto
orizzontale, che consentono di sfruttare in un nuovo modo lo spazio urbano
sull'acqua. Inoltre, è previsto uno stadio-anfiteatro galleggiante che
controbilancia le torri ultrasottili. 3) Parallax Towers (New York City, New York 1989) : questo
progetto per Manhattan, prevede che lo scalo ferroviario sulla
Settantaduesima sia trasformato in un parco pubblico che si estende fino
al fiume Hudson. Sul fiume si stagliano grattacieli ultrasottili, costruzioni
ibride polifunzionali collegate tra loro da un sistema di trasporto
orizzontale, che consentono di sfruttare in un nuovo modo lo spazio urbano
sull'acqua. Inoltre, è previsto uno stadio-anfiteatro galleggiante che
controbilancia le torri ultrasottili.
 4) Storefront for
Art & Architecture (New York City, New York 1993): situata
all'incrocio tra tre quartieri di New York, questa galleria presenta una
facciata importante in quanto è una facciata non-parete in grado di svanire.
Questo è possibile per il fatto che è costituita da pannelli di calcestruzzo
e giornali riciclati che, quando vengono aperti, permettono allo spazio
interno della galleria di espandersi al marciapiede esterno. 4) Storefront for
Art & Architecture (New York City, New York 1993): situata
all'incrocio tra tre quartieri di New York, questa galleria presenta una
facciata importante in quanto è una facciata non-parete in grado di svanire.
Questo è possibile per il fatto che è costituita da pannelli di calcestruzzo
e giornali riciclati che, quando vengono aperti, permettono allo spazio
interno della galleria di espandersi al marciapiede esterno.
 5) Pratt Institute Higgins Hall Insertion
(Brooklyn, New York 1997-2005) : concepita come un inserto tra due
edifici storici i cui livelli dei piani non sono allineati, sfrutta la
dissonanza che i loro prolungamenti vengono a creare. La facciata in vetro
translucido, è invece in vetro trasparente nella zona di dissonanza centrale,
che è in linea con i collegamenti verticali interni. 5) Pratt Institute Higgins Hall Insertion
(Brooklyn, New York 1997-2005) : concepita come un inserto tra due
edifici storici i cui livelli dei piani non sono allineati, sfrutta la
dissonanza che i loro prolungamenti vengono a creare. La facciata in vetro
translucido, è invece in vetro trasparente nella zona di dissonanza centrale,
che è in linea con i collegamenti verticali interni.
 6)
World Trade Center, Schema 1 e 3 (New York City,
New York 2002) : la prima proposta prevede uno spazio monumentale
fluttuante sul fiume le cui pareti sono animate dai raggi del sole attraverso
alcuni tagli. Una strada risale, girando su se stessa, il sito; su di essa
sono collocate diverse funzioni, quali gallerie, cinema, caffetterie,
albergo. 6)
World Trade Center, Schema 1 e 3 (New York City,
New York 2002) : la prima proposta prevede uno spazio monumentale
fluttuante sul fiume le cui pareti sono animate dai raggi del sole attraverso
alcuni tagli. Una strada risale, girando su se stessa, il sito; su di essa
sono collocate diverse funzioni, quali gallerie, cinema, caffetterie,
albergo.
La proposta numero 3 invece propone cinque torri collegate da
corpi orizzontali che, come delle "dita" si intrecciano tra loro e
con la città. Gli edifici sono edifici ibridi.
 7) Highline Hybrid Tower (New York City, New York 2004) :
immaginata come il terminal dell'Highline, questa
torre porta verso l'alto l'orizzontalità dell'Highline.
L'obiettivo è quello di creare un grattacielo che, oltre ad ospitare più
funzioni urbane differenti, sia il più ecologico possibile. 7) Highline Hybrid Tower (New York City, New York 2004) :
immaginata come il terminal dell'Highline, questa
torre porta verso l'alto l'orizzontalità dell'Highline.
L'obiettivo è quello di creare un grattacielo che, oltre ad ospitare più
funzioni urbane differenti, sia il più ecologico possibile.
 8) Hudson Yards (New York City, New
York 2007) : il
progetto prevede un 'parco sospeso su ponte' che prevede uno spazio poroso e
ad uso misto che, oltre a garantire l'alta densità, massimizza lo spazio
pubblico, soddisfacendo la richiesta di verde pubblico. 8) Hudson Yards (New York City, New
York 2007) : il
progetto prevede un 'parco sospeso su ponte' che prevede uno spazio poroso e
ad uso misto che, oltre a garantire l'alta densità, massimizza lo spazio
pubblico, soddisfacendo la richiesta di verde pubblico.
|
|
|
|
|
|
- USA
|
|
|
 1) Erie
Canal Edge (Rochester, New York 1989) : il
progetto lavora sulla sezione trasversale, ridefinendo la forma del canale e
rinforzando il margine della città. Oltre alle 'case sul canale' sono
previsti un edificio per il lavoro e una serie di attrezzature sociali e
culturali. 1) Erie
Canal Edge (Rochester, New York 1989) : il
progetto lavora sulla sezione trasversale, ridefinendo la forma del canale e
rinforzando il margine della città. Oltre alle 'case sul canale' sono
previsti un edificio per il lavoro e una serie di attrezzature sociali e
culturali.
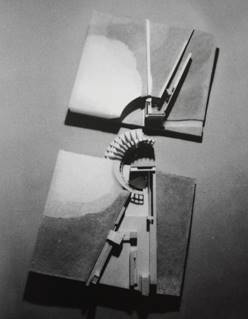 2) Stitch Plan (Cleveland, Ohio 1989) : questo
progetto prevede cinque X disposte lungo il confine interno di Cleveland.
Ogni zona a X è a destinazione mista; infatti è divisa in una porzione
'urbana' ed una porzione 'rurale'. 2) Stitch Plan (Cleveland, Ohio 1989) : questo
progetto prevede cinque X disposte lungo il confine interno di Cleveland.
Ogni zona a X è a destinazione mista; infatti è divisa in una porzione
'urbana' ed una porzione 'rurale'.
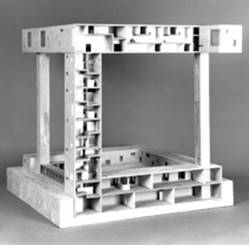 3) Spatial Retaining Bars (Phoenix,
Arizona 1989) : serie di "barre di contenimento spaziale" che
delineano il confine tra la città e l'inizio del deserto. Presentano spazi
residenziali, nei "bracci sospesi", spazi di lavoro e spazi
culturali collettivi. Gli edifici funzionano come delle "travi
cave" portanti. 3) Spatial Retaining Bars (Phoenix,
Arizona 1989) : serie di "barre di contenimento spaziale" che
delineano il confine tra la città e l'inizio del deserto. Presentano spazi
residenziali, nei "bracci sospesi", spazi di lavoro e spazi
culturali collettivi. Gli edifici funzionano come delle "travi
cave" portanti.
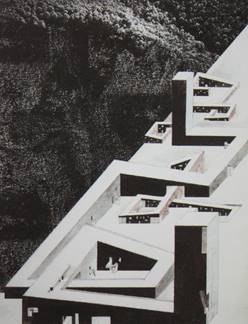 4) Spiroid Sectors (Dallas-Fort
Worth, Texas 1989) : degli 'elementi conduttori' continui avvolti su se stessi
creano una gerarchia di spazi pubblici eterogenei, collegati da percorsi
pubblici la cui quota è variabile. Si crea, in questo modo,
un'interconnessione degli spazi interni ai settori. Gli 'elementi conduttori'
comprendono macroprogrammi eterogenei. I microprogrammi delle funzioni
domestiche sono collocati in strutture più piccole adiacenti, in cui spirali
più piccole definiscono i cortili residenziali. 4) Spiroid Sectors (Dallas-Fort
Worth, Texas 1989) : degli 'elementi conduttori' continui avvolti su se stessi
creano una gerarchia di spazi pubblici eterogenei, collegati da percorsi
pubblici la cui quota è variabile. Si crea, in questo modo,
un'interconnessione degli spazi interni ai settori. Gli 'elementi conduttori'
comprendono macroprogrammi eterogenei. I microprogrammi delle funzioni
domestiche sono collocati in strutture più piccole adiacenti, in cui spirali
più piccole definiscono i cortili residenziali.
 5) Chapel of St.
Ignatius (Seattle, Washington 1994-1997) : situata
nel campus della Seattle University, questa cappella è composta da "sette
bottiglie di luce in una scatola di pietra". I volumi di luce quindi
diventano dei "fari", che di notte si riflettono nella vasca
d'acqua presente nel sagrato della cappella, enfatizzando la geometria dello
spazio. 5) Chapel of St.
Ignatius (Seattle, Washington 1994-1997) : situata
nel campus della Seattle University, questa cappella è composta da "sette
bottiglie di luce in una scatola di pietra". I volumi di luce quindi
diventano dei "fari", che di notte si riflettono nella vasca
d'acqua presente nel sagrato della cappella, enfatizzando la geometria dello
spazio.
 6)
UCSF Mission Bay (San
Francisco, California 1996) : programma per un concorso, propone un
progetto poroso in cui all'interno di sette quadrilateri si crea uno spazio
aperto e interconnesso che ospita i luoghi pubblici di interazione. Gli
edifici sono studiati come variazioni di due tipologie base: gli spazi
principali del campus definiti da masse stereometriche, e i padiglioni
pubblici più leggeri e dinamici. Queste due tipologie di edifici
interagiscono tra loro creando un'unità flessibile. 6)
UCSF Mission Bay (San
Francisco, California 1996) : programma per un concorso, propone un
progetto poroso in cui all'interno di sette quadrilateri si crea uno spazio
aperto e interconnesso che ospita i luoghi pubblici di interazione. Gli
edifici sono studiati come variazioni di due tipologie base: gli spazi
principali del campus definiti da masse stereometriche, e i padiglioni
pubblici più leggeri e dinamici. Queste due tipologie di edifici
interagiscono tra loro creando un'unità flessibile.
 7) MIT Master Plan (Cambridge, Massachusetts
1999)
: questa striscia di suolo viene pensata come una 'membrana porosa',
costituita da quattro edifici distinti. Ciascuno di questi quattro edifici
presenterà un diverso tipo di permeabilità, un diverso tipo di porosità; si
avrà la porosità verticale, la porosità orizzontale, la porosità trasversale
e la porosità integrale. Ogn edificio, che agisce da elemento di raccordo con
la città, gioca con la consistenza, la trasparenza e la luce. Gli spazi
comuni vengono progettati per riunire le persone e stimolare l'interazione. 7) MIT Master Plan (Cambridge, Massachusetts
1999)
: questa striscia di suolo viene pensata come una 'membrana porosa',
costituita da quattro edifici distinti. Ciascuno di questi quattro edifici
presenterà un diverso tipo di permeabilità, un diverso tipo di porosità; si
avrà la porosità verticale, la porosità orizzontale, la porosità trasversale
e la porosità integrale. Ogn edificio, che agisce da elemento di raccordo con
la città, gioca con la consistenza, la trasparenza e la luce. Gli spazi
comuni vengono progettati per riunire le persone e stimolare l'interazione.
 8)
The Nelson-Atkins Museum
of Art (Kansas City, Missouri 1999-2007) : questo
progetto, vincitore di un concorso per l'ampliamento del museo, mira alla
sintesi tra architettura, urbanistica e paesaggio. In quest'ottica è concepito
non come un oggetto architettonico, ma come un suolo che si dispiega.
L'obiettivo è infatti dare forma allo spazio interno in relazione alla
costruzione del suolo e non in relazione alla costruzione dell'edificio.
Inoltre l'edificio diventa una lanterna che gioca con la luce: di giorno
filtra la luce esterna trasmettendola alle gallerie interne; di notte invece
prende vita risplendendo all'esterno. 8)
The Nelson-Atkins Museum
of Art (Kansas City, Missouri 1999-2007) : questo
progetto, vincitore di un concorso per l'ampliamento del museo, mira alla
sintesi tra architettura, urbanistica e paesaggio. In quest'ottica è concepito
non come un oggetto architettonico, ma come un suolo che si dispiega.
L'obiettivo è infatti dare forma allo spazio interno in relazione alla
costruzione del suolo e non in relazione alla costruzione dell'edificio.
Inoltre l'edificio diventa una lanterna che gioca con la luce: di giorno
filtra la luce esterna trasmettendola alle gallerie interne; di notte invece
prende vita risplendendo all'esterno.
 9) School of Art & Art History (Iowa City, Iowa 1999-2006) : questo
edificio ibrido, che occupa il lago Quarry, adotta
un linguaggio scultoreo con la sua scomposizione di piani. In questo campus
poroso i lati frastagliati vanno a definire nuovi spazi, nuovi percorsi e
collegamenti. La molteplicità dei punti di accesso consente al campus di
entrare nell'edificio. Inoltre, i margini indeterminati e frastagliati
dell'edificio, consentono di catturare la luce solare o riflessa dalla neve. 9) School of Art & Art History (Iowa City, Iowa 1999-2006) : questo
edificio ibrido, che occupa il lago Quarry, adotta
un linguaggio scultoreo con la sua scomposizione di piani. In questo campus
poroso i lati frastagliati vanno a definire nuovi spazi, nuovi percorsi e
collegamenti. La molteplicità dei punti di accesso consente al campus di
entrare nell'edificio. Inoltre, i margini indeterminati e frastagliati
dell'edificio, consentono di catturare la luce solare o riflessa dalla neve.
|
|
|
|
|
|
- CINA
|
|
|
 1) Green Urban Laboratory
(Nanning, Cina 2002) : questo progetto, per un concorso, propone una città lineare
che si svolge su se stessa in una pianta a forma di 8. All'interno di questa
forma vi sono due parchi, uno per le attività ricreative e sportive, l'altro
per le attività culturali e la meditazione. la città è costituita dalla
microscala delle residenze porose, e da sette "edifici montagna"
ibridi. 1) Green Urban Laboratory
(Nanning, Cina 2002) : questo progetto, per un concorso, propone una città lineare
che si svolge su se stessa in una pianta a forma di 8. All'interno di questa
forma vi sono due parchi, uno per le attività ricreative e sportive, l'altro
per le attività culturali e la meditazione. la città è costituita dalla
microscala delle residenze porose, e da sette "edifici montagna"
ibridi.
 2) Museum of Art & Architecture (Nanjing, Cina
2002-2009) : museo che lavora con i mutevoli punti di vista, con le
stratificazioni spaziali che caratterizzano l'antica pittura cinese. Infatti
si presenta come un campo di spazi in prospettiva parallela, con giardini
recinti da pareti nere di cemento. Un tortuoso percorso parte dal piano terra
e si trasforma in una figura sospesa. 2) Museum of Art & Architecture (Nanjing, Cina
2002-2009) : museo che lavora con i mutevoli punti di vista, con le
stratificazioni spaziali che caratterizzano l'antica pittura cinese. Infatti
si presenta come un campo di spazi in prospettiva parallela, con giardini
recinti da pareti nere di cemento. Un tortuoso percorso parte dal piano terra
e si trasforma in una figura sospesa.
 3) Linked Hybrid (Beijing, Cina 2003-2009) : questo
progetto si propone come un nuovo spazio urbano pubblico poroso accessibile
su ogni lato. Come una "città nella città" è vivibile intorno,
sopra e attraverso i diversi livelli dello spazio. Il progetto comprende
diversi programmi funzionali: commerciale, residenziale, educativo,
ricreativo. Sono presenti numerosi passaggi accessibili al piano terra.
Un'altra serie di passaggi è costituita da ponti sospesi multifunzionali che
mettono in relazione le otto torri residenziali e la torre dell'albergo,
creando una continuità spaziale incrociata. 3) Linked Hybrid (Beijing, Cina 2003-2009) : questo
progetto si propone come un nuovo spazio urbano pubblico poroso accessibile
su ogni lato. Come una "città nella città" è vivibile intorno,
sopra e attraverso i diversi livelli dello spazio. Il progetto comprende
diversi programmi funzionali: commerciale, residenziale, educativo,
ricreativo. Sono presenti numerosi passaggi accessibili al piano terra.
Un'altra serie di passaggi è costituita da ponti sospesi multifunzionali che
mettono in relazione le otto torri residenziali e la torre dell'albergo,
creando una continuità spaziale incrociata.
 4)
Xi'an New Town (Xi'an, Cina 2005) : l'idea di base proposta è quella di una
città a griglia, le cui dimensioni sono tutte relative alle misure umane ed
ogni distanza deve essere percorribile a piedi. Ogni quadrante è un quartiere
autosufficiente e presenta un tessuto residenziale poroso in cui vengono
"ritagliati" i parchi. Al centro della città, oltre ai servizi
pubblici, ci sono delle torri polifunzionali. 4)
Xi'an New Town (Xi'an, Cina 2005) : l'idea di base proposta è quella di una
città a griglia, le cui dimensioni sono tutte relative alle misure umane ed
ogni distanza deve essere percorribile a piedi. Ogni quadrante è un quartiere
autosufficiente e presenta un tessuto residenziale poroso in cui vengono
"ritagliati" i parchi. Al centro della città, oltre ai servizi
pubblici, ci sono delle torri polifunzionali.
 5) Horizontal Skyscraper / Vanke Center
(Shenzhen, Cina 2006-2009) : progetto vincitore per un concorso che propone un edificio ibrido
sospeso su un giardino pubblico tropicale. In questo modo si ottiene la
superficie a verde più estesa possibile, che permette di creare un microclima
ideale che consente all'edificio di seguire principi di sostenibilità. 5) Horizontal Skyscraper / Vanke Center
(Shenzhen, Cina 2006-2009) : progetto vincitore per un concorso che propone un edificio ibrido
sospeso su un giardino pubblico tropicale. In questo modo si ottiene la
superficie a verde più estesa possibile, che permette di creare un microclima
ideale che consente all'edificio di seguire principi di sostenibilità.
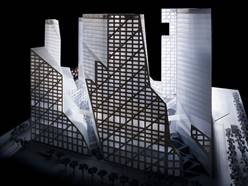 6) Sliced Porosity Block (Chengdu, Cina
2007-2012) : progetto che prevede un edificio ibrido con
destinazioni d'uso differenti, una sorta di "pezzo gigante di una
metropoli" la cui geometria è studiata in modo da garantire al tessuto
urbano circostante il soleggiamento minimo richiesto. Incorniciato dal blocco
vi è un grande spazio pubblico: una terrazza urbana. 6) Sliced Porosity Block (Chengdu, Cina
2007-2012) : progetto che prevede un edificio ibrido con
destinazioni d'uso differenti, una sorta di "pezzo gigante di una
metropoli" la cui geometria è studiata in modo da garantire al tessuto
urbano circostante il soleggiamento minimo richiesto. Incorniciato dal blocco
vi è un grande spazio pubblico: una terrazza urbana.
 7) Ningbo Fine Grain
(Ningbo, China 2008) : proposta per Ningbo, la "città
sull'acqua", basata su cinque strategie: l'urbanizzazione ecologica;
l'integrazione delle funzioni; la morfologia a grana fine (griglia); i
fenomeni di riflessione nell'acqua del canale; un'architettura dei parchi e
della cultura. 7) Ningbo Fine Grain
(Ningbo, China 2008) : proposta per Ningbo, la "città
sull'acqua", basata su cinque strategie: l'urbanizzazione ecologica;
l'integrazione delle funzioni; la morfologia a grana fine (griglia); i
fenomeni di riflessione nell'acqua del canale; un'architettura dei parchi e
della cultura.
|
|
|
|
|
|
- COREA DEL
SUD e GIAPPONE
|
|
|
 1) World Design Park Complex (Seoul, Corea
del Sud 2007) : proposto per un concorso, questo progetto poroso è svilupato
secondo il concetto di "trama" a orditura tridimensionale. Le strategie
a cui si riferisce questa morfologia sono quattro: usare la stessa matrice a
trama anche per il parco verticale; stabilire una relazione con l'antica
morfologia intrecciata del quartiere; sottolineare il ruolo del vicino
distretto della moda e del tessile; fondere paesaggio, urbanistica e
architettura. 1) World Design Park Complex (Seoul, Corea
del Sud 2007) : proposto per un concorso, questo progetto poroso è svilupato
secondo il concetto di "trama" a orditura tridimensionale. Le strategie
a cui si riferisce questa morfologia sono quattro: usare la stessa matrice a
trama anche per il parco verticale; stabilire una relazione con l'antica
morfologia intrecciata del quartiere; sottolineare il ruolo del vicino
distretto della moda e del tessile; fondere paesaggio, urbanistica e
architettura.
 2) Void Space / Hinged Space (Fukuoka, Giappone 1989-1991)
: appare come una parte di città che tenta di dare forma allo spazio invece
che porsi come un oggetto architettonico. Il mezzo per passare dall'urbano al
privato è lo "spazio a cerniera", adattamento del tradizionale
spazio multiuso. 2) Void Space / Hinged Space (Fukuoka, Giappone 1989-1991)
: appare come una parte di città che tenta di dare forma allo spazio invece
che porsi come un oggetto architettonico. Il mezzo per passare dall'urbano al
privato è lo "spazio a cerniera", adattamento del tradizionale
spazio multiuso.
 3) Makuhari Bay New Town (Chiba, Giappone 1992-1996)
: la proposta è quella di un'interrelazione tra due tipi distinti: edifici
silenziosi pesanti, che ospitano lo spazio urbano ed i passaggi, e strutture
attive leggere, che valorizzano la piccola scala. 3) Makuhari Bay New Town (Chiba, Giappone 1992-1996)
: la proposta è quella di un'interrelazione tra due tipi distinti: edifici
silenziosi pesanti, che ospitano lo spazio urbano ed i passaggi, e strutture
attive leggere, che valorizzano la piccola scala.
|
|
|
|
|
|
- PAESI BASSI e FINLANDIA
|
|
|
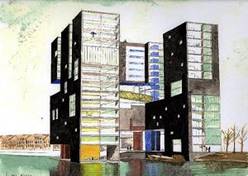 1) Manifold Hybrid (Amsterdam,
Paesi Bassi 1994) : blocco di residenze situato su una banchina portuale, fa
parte di un progetto urbano più ampio che prevede tre superblocchi in un
tessuto di case basse con giardino. Questo edificio è pensato come un pezzo
di città con molteplici funzioni. Inoltre la sezione gioca con una geometria
interconnessa che conferisce un'unica dimensione agli spazi interni. 1) Manifold Hybrid (Amsterdam,
Paesi Bassi 1994) : blocco di residenze situato su una banchina portuale, fa
parte di un progetto urbano più ampio che prevede tre superblocchi in un
tessuto di case basse con giardino. Questo edificio è pensato come un pezzo
di città con molteplici funzioni. Inoltre la sezione gioca con una geometria
interconnessa che conferisce un'unica dimensione agli spazi interni.
 2) Sarphatistraat Offices
(Amsterdam, Paesi Bassi 1996-2000) : nuovo padiglione pensato per una
ristrutturazione, questo edificio "spugna" che si affaccia sul
canale è un'architettura porosa. Inoltre, la luce ed i fenomeni ottici creano
uno "spazio cromatico" che si svela in modo particolarmente intenso
di notte, quando la luce intrappolata rimbalza tra gli strati dell'edificio
generando un volume di colore che si riflette nel canale. 2) Sarphatistraat Offices
(Amsterdam, Paesi Bassi 1996-2000) : nuovo padiglione pensato per una
ristrutturazione, questo edificio "spugna" che si affaccia sul
canale è un'architettura porosa. Inoltre, la luce ed i fenomeni ottici creano
uno "spazio cromatico" che si svela in modo particolarmente intenso
di notte, quando la luce intrappolata rimbalza tra gli strati dell'edificio
generando un volume di colore che si riflette nel canale.
 3) Toolenburg - Zuid (Amsterdam, Paesi Bassi 2002) :
vincitore di un concorso, questo progetto è basato su tre principi di
pianificazione: il 20% acqua, la sezione ascendente che consente il
soleggiamento di tutte le aree, e sei diversi tipi di case che corrispondono
ad una diversità di programmi. Gli obiettivi perseguiti sono: (1) il
collegamento virtuale con la propria abitazione attraverso spazio e tempo;
(2) l'abitare combinatorio e incrociato che esalta una comunità dinamica e
vitale, risultante dai diversi assetti famigliari contemporanei; (3)
l'integrazione vita-lavoro-tempo libero; (4) l'indipendenza dall'automobile;
(5) l'ecologia. 3) Toolenburg - Zuid (Amsterdam, Paesi Bassi 2002) :
vincitore di un concorso, questo progetto è basato su tre principi di
pianificazione: il 20% acqua, la sezione ascendente che consente il
soleggiamento di tutte le aree, e sei diversi tipi di case che corrispondono
ad una diversità di programmi. Gli obiettivi perseguiti sono: (1) il
collegamento virtuale con la propria abitazione attraverso spazio e tempo;
(2) l'abitare combinatorio e incrociato che esalta una comunità dinamica e
vitale, risultante dai diversi assetti famigliari contemporanei; (3)
l'integrazione vita-lavoro-tempo libero; (4) l'indipendenza dall'automobile;
(5) l'ecologia.
 4) Kiasma (Helsinki, Finlandia 1992-1998) : questo museo
dalla spazialità dinamica, si intreccia con la città a sud e con il paesaggio
a nord. Lo specchio d'acqua, estensione di Töölö Bay, si intreccerà e passerà
attraverso l'edificio; inoltre metterà in risalto la luce
"orizzontale" tipica delle latitudini nordiche. L'interno si
rivolge verso il paesaggio in una specie di sintesi, un kiasma, tra edificio
e paesaggio. 4) Kiasma (Helsinki, Finlandia 1992-1998) : questo museo
dalla spazialità dinamica, si intreccia con la città a sud e con il paesaggio
a nord. Lo specchio d'acqua, estensione di Töölö Bay, si intreccerà e passerà
attraverso l'edificio; inoltre metterà in risalto la luce
"orizzontale" tipica delle latitudini nordiche. L'interno si
rivolge verso il paesaggio in una specie di sintesi, un kiasma, tra edificio
e paesaggio.
 5) Meander
(Helsinki, Finlandia 2006) : progetto che cerca di stabilire
una relazione con l'orizzonte del mare; prevede un edificio, la cui forma
assomiglia ad una nota musicale, e giardini e sapzi liberi all'interno dell'isolato
che danno maggior respiro all'edifico ed assicurano il soleggiamento e la
vista panoramica ai 49 nuovi appartamenti. 5) Meander
(Helsinki, Finlandia 2006) : progetto che cerca di stabilire
una relazione con l'orizzonte del mare; prevede un edificio, la cui forma
assomiglia ad una nota musicale, e giardini e sapzi liberi all'interno dell'isolato
che danno maggior respiro all'edifico ed assicurano il soleggiamento e la
vista panoramica ai 49 nuovi appartamenti.
|
|
|
|
|
|
- ITALIA e
FRANCIA
|
|
|
 1)
Porta - Vittoria (Milano, Italia 1986) : contro l'espansione centripeta che caratterizza
la città di Milano, con il centro denso e la periferia diffusa, viene
proposta un'inversione: verso il centro leggero e a grana fine; pesante e
volumetrico verso la periferia. Questo progetto di porzione di città in cui
si ha intersezione dei diversi programmi funzionali, è un esempio per
determinare l'immagine della città stessa nel paesaggio. 1)
Porta - Vittoria (Milano, Italia 1986) : contro l'espansione centripeta che caratterizza
la città di Milano, con il centro denso e la periferia diffusa, viene
proposta un'inversione: verso il centro leggero e a grana fine; pesante e
volumetrico verso la periferia. Questo progetto di porzione di città in cui
si ha intersezione dei diversi programmi funzionali, è un esempio per
determinare l'immagine della città stessa nel paesaggio.
 2) Lombardia Regional Government
Center (Milano, Italia 2004) : il progetto prevede di liberare lo spazio al piano terra per creare
una nuova Piazza Civica pubblica. Gli uffici sono quindi previsti nelle
torri, dalle quali possono godere di un'ottima vista che abbraccia anche le
Alpi. L'edificio è anche pensato per prendere vita di notte: le superfici
riflettenti irradiano infatti la luce del sole assorbita durante il giorno da
cellule fotovoltaiche. 2) Lombardia Regional Government
Center (Milano, Italia 2004) : il progetto prevede di liberare lo spazio al piano terra per creare
una nuova Piazza Civica pubblica. Gli uffici sono quindi previsti nelle
torri, dalle quali possono godere di un'ottima vista che abbraccia anche le
Alpi. L'edificio è anche pensato per prendere vita di notte: le superfici
riflettenti irradiano infatti la luce del sole assorbita durante il giorno da
cellule fotovoltaiche.
 3) Les Halles (Parigi, Francia 1979) : progetto che
racconta la storia del sito, dando forma a un grande spazio urbano. La nuova
piazza è delimitata da portici di vetro sabbiato; le case sono addossate
posteriormente ai portici e affacciano sulla città. Questo luogo, pensato
come ricco di attività, prende vita anche di notte grazie ai portici di vetro
che risplendono. 3) Les Halles (Parigi, Francia 1979) : progetto che
racconta la storia del sito, dando forma a un grande spazio urbano. La nuova
piazza è delimitata da portici di vetro sabbiato; le case sono addossate
posteriormente ai portici e affacciano sulla città. Questo luogo, pensato
come ricco di attività, prende vita anche di notte grazie ai portici di vetro
che risplendono.
 4) Île Seguin (Parigi, Francia
2001) : proposta per la trasformazione dell'area delle industrie Renault,
questo progetto immagina gran parte dell'isola a nord-est come una libera
università globale, dalla forma "incernierata e rovesciata" con un
largo parco e giardini. A sud invece è prevista la Fondazione Pinault,
composta da semplici gallerie rettangolari di proporzioni variabili che sono
riunite intorno a 5 spazi vuoti "scolpiti" che creano una vasta
sequenza spaziale. 4) Île Seguin (Parigi, Francia
2001) : proposta per la trasformazione dell'area delle industrie Renault,
questo progetto immagina gran parte dell'isola a nord-est come una libera
università globale, dalla forma "incernierata e rovesciata" con un
largo parco e giardini. A sud invece è prevista la Fondazione Pinault,
composta da semplici gallerie rettangolari di proporzioni variabili che sono
riunite intorno a 5 spazi vuoti "scolpiti" che creano una vasta
sequenza spaziale.
|
|
|
|
|
|
- LIBANO e
TURCHIA
|
|
|
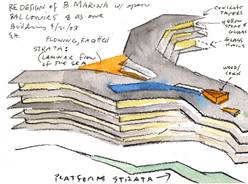 1) Beirut Marina
and Town Quay (Beirut, Libano 2002-2010) : questo edificio
è pensato come sovrapposizione di strati e livelli simili a vettori che si
biforcano. Gli spazi sono stratificati per successivi livelli orizzontali.
Inoltre l'edificio residenziale si biforca a formare una "Y" per
consentire l'estensione della superficie esterna con vista panoramica. 1) Beirut Marina
and Town Quay (Beirut, Libano 2002-2010) : questo edificio
è pensato come sovrapposizione di strati e livelli simili a vettori che si
biforcano. Gli spazi sono stratificati per successivi livelli orizzontali.
Inoltre l'edificio residenziale si biforca a formare una "Y" per
consentire l'estensione della superficie esterna con vista panoramica.

2) Akbuk Peninsula Dense Pack (Akbuk, Turchia 2006-2010) : il progetto
prevede una nuova riserva ecologica costituita da piccoli frammenti di città
che diventano isole in un territorio protetto con vegetazione naturale. Tre
"isole" compatte a griglia sono localizzate strategicamente. Le
varie tipologie di edifici creano diverse relazioni con il suolo: sotto il suolo le spa e le case
urbane; nel suolo le ville
con patio e piscina; sopra il
suolo gli appartamenti con cortile.
|
|
|
|
|
GLOSSARIO
|
|
|
1: Geo - Spazialità – Lavorare
alla macroscala urbana porta a rapportarsi non solo con la realtà
metropolitana del presente, ma anche con il passato e la storia di un luogo. Questi
aspetti storici e culturali, pur cambiando ed evolvendosi nel tempo,
interessano migliaia di anni, ed è importante conoscerli perchè ogni
intervento architettonico, ogni intervento urbano, si mette in rapporto con
il paesaggio naturale circostante. In quest'ottica quindi "oggi non esiste un luogo al mondo che
non sia oggetto dell'azione intensiva dell'uomo".
|
|
|
2: Fenomeni Esperienziali –La città è allo stesso tempo esperienza soggettiva e
realtà oggettiva. La progettazione urbana dovrebbe basarsi su una sintesi di
questi due aspetti ponendo la sua attenzione non solo sulla dimensione
oggettiva e pratica, ma anche su quella soggettiva delle esperienze urbane. "Un punto di vista razionale o
statico, non è di certo sufficiente quando si opera su una realtà molto
complessa". Diventa quindi necessario creare nuove relazioni
che permettano alle esperienze urbane di intrecciarsi in una nuova percezione
spaziale.
|
|
|

|
|
|
"Dopo una pioggia rinfrescante, le strade di Roma assumono
una magia particolare attraverso i riflessi."
|
|
|
3: Spazialità della Notte – La spazialità notturna è un nuovo tipo di spazialità, che
viene a definirsi nel momento in cui la massa si trasforma in luce.
|
|
|

|
|
|
"L'impressione
giocosa del gran numero di luci nella città, altera la nostra percezione
dell'aspetto e della forma dello spazio urbano notturno".
|
|
|
4: Porosità Urbana – Ottenibile
attraverso 'sequenze spaziali' e non più attraverso oggetti isolati, la
porosità urbana è il compenetrarsi di azioni, edifici e funzioni. In questo
modo viene data una nuova vitalità alle città. Il Beijing Linked Hybrid
è un chiaro esempio di porosità spaziale.
|
|
|
5: Città / Sezione – La
sezione urbana è uno strumento di pianificazione urbana che supera il solo utilizzo
della planimetria, in quanto permette di osservare gli interventi attraverso
una successione di vedute. Andare oltre il planivolumetrico vuol dire quindi
scoprire nuove esperienze spaziali, della luce e della percezione, nuove
dimensioni del vivere urbano che aumentano in modo potenziale attraverso lo
studio delle sezioni.
|
|
|
6: Visioni Parziali – Tenere
in considerazione i diversi punti di vista, le "visioni parziali",
permette di concepire e pianificare gli spazi attraverso i principi
percettivi. Una singola veduta non è completa ed è statica. Invece, la
dinamicità di una serie di prospettive permette di descrivere in modo più
completo un oggetto definendone anche le interrelazioni spaziali urbane con
ciò che gli sta intorno.
|
|
|
7:
Spazio Psicologico – Attraverso l'interazione simultanea
tra i vari aspetti dell'architettura quali topografia, materia e luce, è
possibile manifestare l'anima di un luogo. Lo spazio psicologico è cioè
quella nuova dimensione dell'architettura che mira a far percepire la propria
energia spaziale attraverso l'effetto imprevisto che ci sucita
eccitazione,libertà o gioia.
|
|
|
8: Il Flusso e l'Effimero – Il flusso di materiali, prodotti e informazioni e la
grande flessibilità della vita nelle metropoli sono ciò che caratterizza la
moderna popolazione iper-dinamica. L'architettura, per poter dimostrare le
proprie capacità di adattamento ai flussi ed ai cambiamenti delle metropoli,
deve essere duratura perchè solo in questo modo è possibile parlare di
obiettivi più alti rispetto a quelli che si potrebbero avere con costruzioni
effimere e spazi usa e getta.
|
|
|
9: Qualità versus Banalizzazione – La cresita urbana incontrollata ha prodotto
banalizzazione priva di qualità architettoniche. Lo scopo del progettista
deve essere quello di realizzare costruzioni di qualità esemplare, cioè
costruzioni che siano in grado di trasformare e modellare la vita urbana
attraverso le esperienze spaziali. Esempio significativo di edificio di
qualità è il 'Copan Building',
progetto di Oscar Niemeyer a San Paolo, che ha il potere di contagiare le
persone e riempirle di orgoglio.
|
|
|
10:
Capacità Negativa – La capacità negativa consiste nel
trovarsi nell'incertezza, nel dubbio e, nonostante questo, essere in grado di
agire. Per far questo, si deve osservare un luogo e studiarlo dalle diverse
angolazioni, fino al punto di percepire come intuitivo il fatto di creare.
Lavorare con il dubbio diventa quindi una forma di ottimismo.
|
|
|
11: Fusione – La fusione è quella
tra paesaggio, urbanistica ed architettura. Questa integrazione si deve
trasmettere ad ogni aspetto, in modo che possa essere pensato integralmente.
Si deve arrivare a pensare alle texture, al colore, alla traslucidità, alla
trasparenza ed alla riflessione dei materiali. Questa interconnessione,
questa sintesi è in grado di portare a nuovi tipi di esperienza spaziale.
|
|