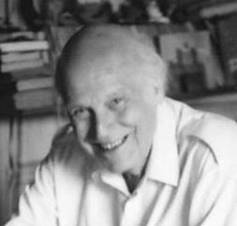|
|
|
|
||
|
|
autore |
YONA FRIEDMAN |
|
titolo |
UTOPIE RALIZZABILI |
|
|
editore |
QUODLIBET |
|
|
luogo |
MACERATA |
|
|
anno |
2003 |
|
|
|
|
|
|
lingua |
ITALIANO |
|
|
|
|
|
|
Titolo originale: Utopies
réalisables. Nouvelle édition
(1974) |
||
|
|
||
|
|
Argomento e tematiche
affrontate |
|
|
L'autore
cerca di definire un linguaggio semplice e universale che permetta lo studio sistematico
delle utopie e verifichi se queste sono realizzabili o meno, tenendo anche
presente la tipologia di organizzazione della società presa in studio. Ragiona
sulla società come insieme di oggetti e uomini e ne studia le
relazioni. Osserva
quali sono le utopie tutt'oggi irrealizzate, anche se le tecniche necessarie
per portarle a compimento sono presenti, e quelle che invece sono
irrealizzabili per motivi reali, i quali vengono scrupolosamente studiati e
verificati. Propone
soluzioni a condizioni reali che risultano critiche per la vita dell'uomo. |
||
|
|
||
|
Giudizio Complessivo: 8 (scala 1 - 10) |
||
|
Scheda
compilata da: Brambilla Cristina |
||
|
Corso di
Architettura e Composizione Architettonica 2 a.a.2012/2013 |
||
|
|
||
|
|
Autore |
|
|
Yona
Friedman nasce in Ungheria nel 1923 e qui comicia a studiare architettura
grazie all'aiuto economico di un professore che scopre il suo talento. Successivamente
si trasferirsce in Romania e poi in Israele dove, per mentenersi gli studi,
lavora come operaio edile. Una volta
terminati gli studi partecipa al Congrès Internationaux d'
Architecture Moderne (CIAM) dove presenta le sue idee riguardanti lo sviluppo
urbano (Mobile architecture). Nel
Novembre del 1957 fonda il Groupe d'Etudes d'Architecture Mobile (GEAM) con
Jan Trapmane, successivamente conosce Gerrit Rietveld e Jerzy Soltan. Nell'
Aprile del 1960 GEAM fonda i suoi principi e conclude che la pianificazione
urbana ha fallito con il suo approccio datato e costoso. Il gruppo lavora per
trovare delle soluzioni. Su invito
di Jean Pruvé Friedman si
reca a Parigi dove conosce Denise Charvein che diviene sua moglie. Egli cerca
di realizzare le sue idee progettuali, ma si rende conto di non essere
compreso e si concentra maggiormente sulla trasmissione e propaganda delle
sue idee. Egli
progetta artwork che espone in diverse mostre e il suo obiettivo è
collegare i suoi disegni a le sue opere al suo ragionemaneto di base
architettonica. |
||
|
Yona Friedman |
||
|
|
||
|
Contenuto |
||
|
L'autore incrementa la sua prima
edizione con nuovi interventi e considerazioni sulla sua teoria riguardante
le utopie realizzabili. Questo libro è, per l'autore, uno
stato d'accusa per quelli che
definisce i due "cattivi" dei nostri tempi: lo "Stato
mafia" e la "mafia dei media". La prima riguarda
l'impossibilità di conservazione di uno Stato democratico classico non
appena le sue dimensioni superano certi limiti e la seconda è una
diretta conseguenza causata dell'impossibilità della comunicazione
globale dovuta all'incapacità dell'uomo di effettuarla. Queste due mafie cercano di
convincere che siamo noi, la popolazione, a volere quello che loro vogliono
quando, in realtà, ognuno di noi è esperto per se stesso. I dirigenti non sono più in
grado di governare gli Stati e non riescono più a rimanere in contatto
con la massa divenuta troppo ampia. I media hanno la sola funzione di
fare da "critici teatrali" preoccupandosi dell'effetto da produrre
invece di informare in modo oggettivo. L'unica soluzione alle mafie rimane
quella dei piccoli gruppi. |
||
|
|
||
|
CAPITOLI |
||
|
Capitolo 1 – Delle
utopie in generale |
||
|
L'autore definisce la nostra epoca come quella nella quale
sono state inventate il maggior numero di utopie che sono, per eccellenza,
realizzabili. Esse nascono da una condizione di insoddisfazione che deve
essere superata. La ricerca del miglioramento può avvenire: - immaginandosi un cambiamento che sembra realizzabile ma
non lo è, quello che gli
anglossassoni chiamano wishful thinking; - immaginandosi un cambiamento del comportamento di tutti
gli altri che, essendo irrealizzabile, porta ad una rassegnazione
preliminare; - riflettendo e studiando ciò che del comportamento
altrui può cambiare e osservando gli strumenti a disposizione
necessari per la formulazione di
una strategia che confluisca in un'utopia realizzabile; - pensando di cambiare il proprio comportamento personale,
ovvero un progetto. L'operazione chiave dell'utopia realizzabile consiste
nell'ottenere il consenso collettivo e può nascere solo a condizione
che esista un rimedio noto (tecnica) per porre fine all'insoddisfazione che
l'ha generata. Il progetto, a differenza dell'utopia, necessita di una
tecnica conosciuta ma non di un consenso collettivo. Esistono due diverse leggi delle utopie: 1- di fronte ad una situazione insoddisfacente la tecnica
proposta per il superamento è già nota, quindi insoddisfazione
e tecnica applicabile non sono contemporanee; 2- la tecnica può essere applicata solo a consenso
avvenuto quindi questi due fattori (tecnica applicabile e consenso) non sono
tra loro contemporanei. Se la conoscenza della tecnica applicabile è in mano
a poche persone si tratta di utopia paternalista, se è di dominio
pubblico di utopia non paternalista. L'applicazione della tecnica ha lo scopo di eliminare la
causa dell'insoddisfazione o di rendere apprezzabile la situazione esistente.
|
||
|
|
||
|
Capitolo 2 – Le utopie sociali |
||
|
La società viene definita come un insieme di
individui tra i quali esiste una qualsiasi relazione. Essi si INFLUENZANO
l'uno con l'altro in modo diretto o attraverso una propagazione delle
influenze. Nelle organizzazioni paternaliste gli ideatori delle utopie non ne
subiscono le conseguenze, non ne vengono quindi influenzati; il contrario
accade nelle organizzazioni non paternaliste. Le società possono essere: 1- gerarchiche: nelle quali la propagazione delle influenze
non è garantita 2- egualitarie: dove la propagazione che parte da un
individuo arriva con certezza a tutti gli altri anche se in modo lento. La società è in realtà costituita da
uomini e oggetti, quest'ultimi
non coscienti, collegati da un sistema di influenze. Questa definizione
equivale a quella di ambiente ossia l'insieme di oggetti influenzati
dall'uomo e che lo influenzano. |
||
|
|
||
|
Capitolo 3 – Gruppo critico |
||
|
Per
consentire la velocità di trasmissione delle relazioni e per permettere
la persuasione necessaria al consenso dell'utopia si necessita di una
grandezza funzionale del gruppo identificata con il gruppo critico. All'interno
di esso devono essere studiate la valenza, ossia il numero di centri di
interesse su cui un uomo può concentrare la propria attenzione
cosciente, e la capacità di canale che definisce la degradazione,
ovvero l'ostacolo, per la trasmissione di un'informazione. La
trasgressione dei limiti del gruppo critico conduce all'alienazione, provoca
un cambiamento e ostacola la permanenza di una società egualitaria. La
grandezza del gruppo critico è determinata da: 1-
struttura del gruppo; 2-
valenza dei membri; 3-
capacità di canale dei membri; 4-
velocità caratteristica del linguaggio; 5-
velocità di reazione |
||
|
|
||
|
Capitolo 4 – L'ambiente |
||
|
Il
meccanismo che regola la coesistenza delle società è simile
all'ecosistema che regola la coesistenza delle specie. Esso viene definito
come ecologia sociale; ad essa appartiene un elemento detto selezione sociale
che dipende da un sistema di regole inventate da una società con lo
scopo di conservare una certa SITUAZIONE. L'ecologia
sociale pone dei limiti quantitativi utili al mantenimento della soglia del
gruppo critico. La selezione sociale tratta invece dei limiti qualitativi. Una
società viene definita egualitaria quando le persone che la compongono
hanno tutte la medesima posizione sociale. Essa assume un buon funzionamento
quando comprende un gran numero di oggetti di bassissima condizione sociale. La
proporzione tra persone ed oggetti è fondamentale per determinare il
repertorio delle possibili organizzazioni sociali e di tutte le utopie
realizzabili. Nella
società la comunicazione è importante, ma possibile solo per
piccoli gruppi. Nel caso di società che hanno oltrepassato la soglia
del gruppo critico la comunicazione risulta impossibile ed i suoi dirigenti
prendono coscienza della condizione sociale solo attraverso dati statistici
che portano ad una trascuratezza della condizione reale. Le
constatazioni fatte sul gruppo critico degli esseri viventi trovano
corrispondenze nel mondo degli oggetti. Una di queste è la produzione
di rifiuti i quali sono riciclabili solo entro certi limiti di
quantità oltre i quali inizia l'inquinamento. Questa è definita
quantità critica dei rifiuti che dipende dall'organizzazione del
gruppo umano. I
legami tra uomini e oggetti all'interno di una società sono quindi
molto importanti e il loro equilibrio può essere facilmente
disturbato. |
||
|
|
||
|
Capitolo 5 – L'organizzazione degli
altri |
||
|
Precedentemente
l'autore ha osservato il rapporto tra uomini e oggetti, il suo studio poi si
concentra maggiormente sul rapporto dell'oggetto con l'individuo e
l'ambiente. Gli
oggetti assumono importanza diversa a seconda dell'osservatore; si cerca
quindi un'assiomatica che descriva i collegamenti tra persone e oggetti,
ovvero: 1-
un oggetto appartiene a un ambiente solo quando attira l'attenzione di un
individuo; 2-
un oggetto necessario alla sopravvivenza di un individuo ne attira
l'attenzione; 3-
un oggetto che attira l'attenzione di un individuo ne attirerà
parimenti l'attenzione sui collegamenti che esistono tra quell'oggetto e gli
altri (persone e oggetti). Questa
assiomatica include un certo numero di corollari: - ad
individui diversi può corrispondere un ambiente diverso; -
l'operazione all'origine dei collegamenti è l'attenzione; -
senza attenzione la sopravvivenza è impossibile; - la
differenza tra individui e oggetti è di attenzione; - il
problema dell'accesso ha come unica origine i limiti delle capacità
d'attenzione di un dato individuo. Data
la prima assiomatica sul rapporto dell'oggetto con individuo e ambiente ne
viene introdotta una seconda riguardante l'organizzazione dell'individuo
rispetto all'oggetto: la proprietà. Questa
si riduce ad una relazione passiva persona-oggetto, in quanto l'oggetto non
è cosciente, e ad una di convenzione persona-persona. Il numero di
persone definisce il repertorio di organizzazioni e l'insieme di vincoli che
possono essere scelti. Alcuni
oggetti non sono permanentemente utilizzati e altri sono a disposizione di
tutti, manca una regolamentazione che registri le priorità nel caso di
utilizzo collettivo dell'oggetto. Ci
sono due tipi di organizzazione che riguardano l'attesa di utilizzo: 1-
stoccaggio: l'oggetto aspetta di essere utilizzato; 2-
regolamentazione: l'individuo aspetta l'oggetto. I
prodotti di prima necessità non appartengono a nessuna delle due
organizzazioni e sono quelli economicamente più facili da ottenere. Le
organizzazioni che necessitano di uno stoccaggio di oggetti sviluppano uno
spreco temporale nel senso della vita dell'individuo, lo frammentano e il
problema principale che si individua è l'accesso all'oggetto. |
||
|
|
||
|
Capitolo 6 – La "società senza competizione" |
||
|
Dopo
aver osservato il rapporto persona-persona e persona-oggetto viene studiato
il comportamento dell'individuo nella società. La
lotta per la vita della specie è da sempre presente all'interno della
società e si vuole capire se è veramente necessaria o se
è possibile creare una società senza competizione. La
lotta per la vita si manifesta in senso stretto solo nel caso in cui un
genere necessario alla sopravvivenza non è reperibile in
quantità sufficiente per un intero insieme di individui. L'abbondanza
dei generi di sussistenza e la riduzione dell'insieme degli individui possono
condurre ad un equilibrio, si tratta in ogni caso di una trasformazione. Sono
riconoscibili quatto schemi: -
abbondanza naturale, ossia equilibrio; -
abbondanza naturale e rarefazione artificiale; -
rarità naturale e lotta per la vita; -
rarità naturale e risposta tecnologica. La
lotta per la sopravvivenza non è necessaria per gli schemi di
abbondanza artificiale e naturale, ma nel primo caso potrebbe essere presente
un desiderio di potere che può essere fermato se tutti gli individui
sono a conoscenza della tecnologia utilizzata a creare l'abbondanza. Nel
caso di equilibrio potrebbe comparire la lotta per la precedenza e creare una
condizione definita rarità indotta, nella quale il pericolo di inflazione
è un grande ostacolo alla realizzazione di utopie egualitarie che
possono essere create solo istituendo un feedback continuo relativo alla
condizione sociale del singolo o rifiutando la rarità indotta, come
accade nella utopica società non competitiva. I
gruppi non competitivi sono in realtà fragili perché possono
crescere e oltrepassare la soglia critica e perché il paternalismo
delle mitologie è causa delle scissioni ideologiche. Un
modo per evitare la distruzione dei gruppi non competitivi è garantire
la possibilità di migrazione e di controllare le nascite. In
generale la creazione di una società egualitaria è sempre
ostacolata dalla competizione. |
||
|
|
||
|
Capitolo 7 – L' importanza dell'importanza |
||
|
Importante
è osservare le società e gli individui che ne fanno parte
dall'esterno perché ognuno di essi si sente importante e la sua
visione della società risulta distorta. Le utopie risultano dunque
tentativi ideati con lo scopo di
ristabilire la propria importanza agli occhi degli altri ed è
proprio questa ad essere indispensabile per cogliere gli aspetti
dell'organizzazione sociale facenti parte della società in esame; in
una società non paternalista l'importanza è garantita a
chiunque e, in realtà, nessuno può vivere senza sentirsi
importante. L'importanza
può essere: -
positiva: l'individuo si sente importante indipendentemente dagli altri; -
negativa: l'individuo riduce l'importanza altrui per garantire la propria. L'utopia
di una società anonima è realizzabile attraverso un sistema di
criteri fondato sull'importanza negativa, ma questo crea un livellamento
dell'importanza di ciascuno dei suoi membri ed incita automaticamente al
minimo sforzo in quanto l'importanza sociale dell'individuo non accresce mai. Ogni
individuo tende quindi ad attribuirsi maggiore importanza e questo porta ad
una società egualitaria pur non essendo egualitario chi ne fa parte. Quando
una società risulta felice vuole perpetuare la sua condizione attraverso
quelle che vengono definite utopie immobiliste. Esse rappresentano la
situazione ideale per qualsiasi governo, ma sono difficili da raggiungere e
uno dei mezzi più usati per la loro realizzazione consiste
nell'elaborare dei criteri arbitrari che permettano a ciascuno di attribuirsi
un'importanza che lo soddisfi. |
||
|
|
||
|
Capitolo 8 – La città |
||
|
La
città è l'ossatura materiale della società, viene intesa
come territorio abitato da essere umani organizzati e quindi è di per
sé un' utopia realizzata; è principalmente un'organizzazione
prima ancora di essere un territorio occupato. L'utopia città è
una sintesi di due aspetti che sono l'organizzazione umana e il territorio. Nella
sua storia la città è divenuta deposito di specialisti
dell'industria i quali sono tutti indispensabili, mentre nella realtà
agricola precedente tutti erano in grado di svolgere tutti i compiti
divenendo quindi intercambiabili e non indispensabili. L'utopia realizzata
delle prime città è quindi stata quella di essere costituita da
un insieme di individui tutti uguali e tutti indispensabili. Nel
tempo la città si è snaturata, ha ceduto agli attacchi esterni
oltrepassando la soglia del gruppo critico e cambiando struttura, ovvero
passando da egualitaria a gerarchica. Nella
città odierna sono però sopravvissuti dei gruppi egualitari: le
città private. Esse sono realtà che corrispondono al nucleo di
cittadini che fanno da collegamento diretto tra ognuno dei cittadini della
città; esistono tante città private quante sono i cittadini che
compongono la città. Quando
la città privata coincide con un territorio ben definito diviene
villaggio urbano che è estremamente stabile perché non
può crescere ed è quindi di difficile deterioramento. La
città privata dà vita all'utopia della città primitiva e
provoca il disintegrarsi delle grandi organizzazioni creando una struttura
sociale nuova a bassa comunicazione e difficilmente influenzabile con metodi
autoritari. Il
linguaggio semplice ed accessibile a tutti è di primaria importanza
per l'autopianificazione. Autopianificazione sociale e autoregolazione sociale sono concetti
limitrofi, ma c'è tra loro un differenza. L'autoregolazione
è una delle conseguenze di alcune leggi naturali e garantisce la
sopravvivenza della specie trascurando la condizione dei singoli individui
mentre l'autopianificazione sfrutta le leggi
naturali e le domina senza fare alcuna vittima. Conoscere le leggi naturali
che governano la società vuol dire evitare sforzi vani e quindi
evitare le utopie irrealizzabili. |
||
|
|
||
|
Capitolo 9 – La città globale |
||
|
Per
città globale non si intende che la terra è abitata da una
società omogenea e uniforme, ma che è agevolata la
mobilità materiale e immateriale di piccoli gruppi che sono
geograficamente dispersi. La
città-continente è costituita da un centinaio di città
che esistono da secoli e sono ora collegate da una rete di trasporti ad alta
velocità e soddisfa allo sviluppo economico e demografico senza
però comportare una crescita smisurata di ciascuna delle città
che la compongono. Un esempio di modello del futuro è l'Europa Unita. Caratteristica
della città globale è l'esistenza di frontiere definitive e
questo rende impossibile sia l'emigrazione che l'immigrazione necessarie
all'equilibrio dei gruppi. La migrazione è vista come un fattore di
autoregolazione sociale ed è una delle utopie realizzabili più
importanti, essa permette di avere la possibilità di migliorare la
propria condizione cambiando luogo e allontanandosi, anche se la sua fuga
può produrre ulteriori conflitti che saranno però limitati. In
un'organizzazione simile è impossibile pensare ad un governo centrale;
ogni gruppo della città globale dovrebbe provvedere ad autoregolarsi
con un proprio sistema politico. La migrazione rappresenta quindi
l'autoregolazione del sistema sociale degli abitanti della città
globale perché garantisce una varietà di regolamenti
accettabili. Un'unica organizzazione centrale non potrebbe funzionare
perché avrebbe una velocità di reazione troppo lenta di fronte
ad un problema da risolvere. |
||
|
|
||
|
Capitolo 10 – Conclusione: piccole utopie
realizzabili |
||
|
L'utopia
dello Stato mondiale è rimasta irrealizzata nei secoli perché
troppo grande per poter funzionare in modo soddisfacente per i cittadini. E'
però possibile un'infrastruttura mondiale. L'infrastruttura per
definizione è un supporto materiale di progetti e utopie, è
l'opposto dell'organizzazione che è invece il supporto immateriale di
quelle stesse azioni. Il primo
aspetto dell'organizzazione ad essere legato all'infrastruttura, ovvero alla
sua parte materiale, è la territorialità dalla quale deriva il
secondo, l'idea di frontiera. L'ultimo aspetto è la distribuzione
ineguale delle riserve naturali perché tutti i territori non sono
dotati in misura uguale dei mezzi di sopravvivenza. Uno Stato mondiale
imporrebbe il proprio controllo su tutti questi tre punti. In
un' infrastruttura mondiale i gruppi potrebbero sopravvivere solo senza
superare la soglia del gruppo critico e la chiusura di essi garantirebbe la
tolleranza reciproca. I gruppi sarebbero collegati tra loro grazie a una rete
di comunicazioni estesa sull'intera superficie e la cui manutenzione sarebbe
affidata ad una organizzazione deputata alla gestione. |
||
|
|
||
|
GLOSSARIO |
||
|
Ambiente (capitolo 2) - insieme di oggetti influenzati
dall'uomo e che lo influenzano. |
||
|
Società (capitolo 2) - insieme di individui tra i quali
esiste una qualsiasi relazione. |
||
|
Società egualitaria (capitolo 4) - le persone che la
compongono hanno tutte la medesima posizione sociale. |
||
|
Rarità indotta (capitolo
6) - invenzione di un genere non indispensabile alla sopravvivenza, ma
presentato come tale per farne un mezzo di distinzione. |
||
|
Città (capitolo 8) - territorio abitato da esseri umani organizzati. |
||
|
Autoregolazione sociale (capitolo 8) - organizzazione che è conseguenza di alcune leggi
naturali e che garantisce la sopravvivenza della specie trascurando la
condizione dell'individuo. |
||
|
Autopianificazione sociale (capitolo 8) - organizzazione che sfrutta le leggi naturali dominandole
senza fare alcuna vittima. |
||
|
Città continente (capitolo 9) - insieme di città già esistenti da secoli che
sono ora collegate da una rete di trsporti ad alta velocità. |
||
|
Territorialità (capitolo
10) - idea per cui una porzione della superficie terrestre appartiene a una
persona o a un gruppo. |
||