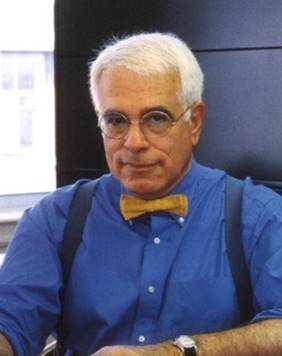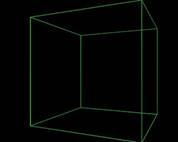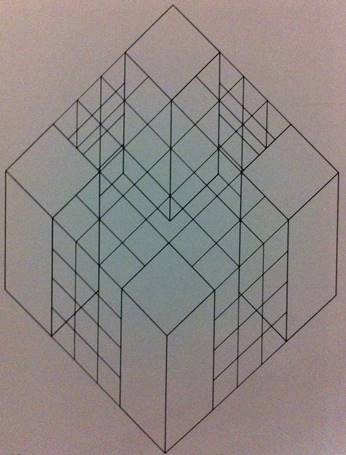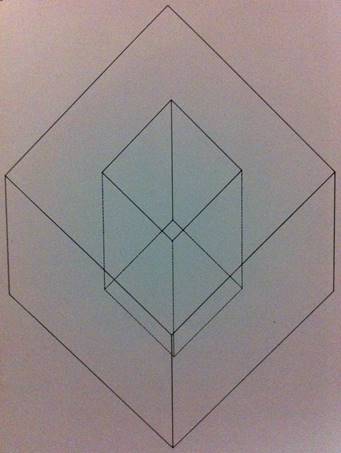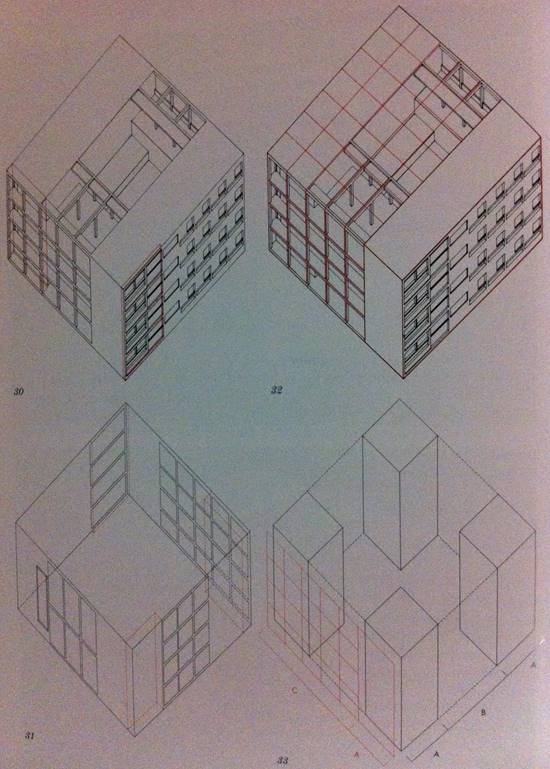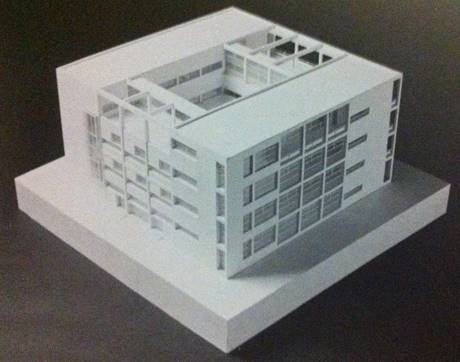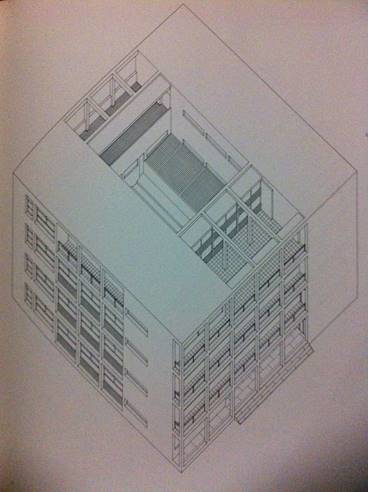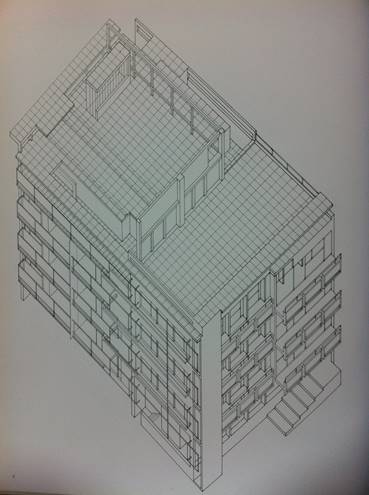|
|
|
|
||
|
|
autore |
PETER
EISENMAN |
|
titolo |
GIUSEPPE
TERRAGNI:TRASFORMAZIONI, SCOMPOSIZIONI, CRITICHE |
|
|
editore |
QUODLIBET |
|
|
luogo |
MACERATA |
|
|
anno |
2004 |
|
|
|
|
|
|
lingua |
ITALIANO |
|
|
|
|
|
|
Prima
edizione: italiana,2004 |
||
|
|
||
|
|
Argomento e tematiche
affrontate |
|
|
‘’E’ un’indagine documentata e approfondita di due capolavori dell’architetto
razionalista italiano Giuseppe Terragni, la Casa del Fascio (1933-36) e la
Casa Giuliani Frigerio (1939-40), entrambe a Como. Questa ricerca ad ampio
raggio si avvale di quella che Eisenman chiama una lettura critica e testuale
dei due edifici. Egli cerca di ampliare la definizione di “formale” andando
oltre il punto di vista strettamente estetico e compositivo, per includervi
prima il concettuale e poi il testuale, e aprendo così la possibilità di
leggere un’architettura come un “testo critico”.’’ |
||
|
|
||
|
Giudizio
Complessivo: 9 (scala 1-10) |
||
|
Scheda compilata da: Rolla Federico |
||
|
Corso di Architettura e Composizione Architettonica 2 a.a.2012/2013 |
||
|
|
||
|
|
Autore |
|
|
Peter Eisenman (Newark, 11 agosto
1932) è un architetto
statunitense. La carriera
accademica di Eisenman comprende l'insegnamento alle università di
Cambridge, Princeton, Yale e l'Ohio State. Ad Harvard è stato l'Arthur Rotch Professor of Architecture dal 1982 al 1985 e
l'Eliot Noyes Visiting
Design Critic nel 1993. Ha inoltre insegnato
all'ETH di Zurigo e allo IUAV di Venezia. Ha conseguito un bachelor in Architettura alla Cornell University, un master in Architettura alla Columbia University,
un Master of Arts e un Ph.D.
all'Università di Cambridge. Eisenman dapprima divenne noto come membro dei New
York Five, cinque architetti (Eisenman, Charles Gwathmey,
John Hejduk,
Richard
Meier, e Michael Graves) i cui
lavori apparirono a un'esposizione del MoMA
nel 1967. Eisenman ricevette un certo numero di
borse di studio dalla Graham Foundation per il lavoro svolto in quel periodo.
Le opere dei cinque, al tempo, furono considerate una reinterpretazione delle
idee di Le Corbusier. In seguito
le strade si divisero, ed Eisenman iniziò ad
avvicinarsi al movimento decostruttivista. Le sue teorie sull'architettura
inseguono l'emancipazione e l'autonomia della disciplina, e il suo lavoro
rappresenta il tentativo costante di liberare la forma da tutti i
significati. Ha sempre avuto una forte relazione culturale con gli
intellettuali europei, come l'inglese Colin Rowe e lo storico italiano Manfredo
Tafuri. Gli studi del filosofo Jacques
Derrida sono un'influenza basilare nella sua
architettura. Opere: · Wexner Center for the Arts, Ohio
State University, Columbus, Ohio, 1989 · Il giardino dei passi perduti, Museo di Castelvecchio, Verona, 2004 · Memoriale per gli ebrei
assassinati d'Europa, Berlino, 2005 · University of Phoenix Stadium, Glendale,
Arizona, 2006 |
||
|
Peter Eisenman |
||
|
|
||
|
Contenuto |
||
|
E’ un’analisi delle due opere di Giuseppe
Terragni (La Casa del Fascio e la Casa Giuliani Frigerio, Como) che mira a
definire una nuova metodologia per analizzare e conoscere l’architettura
discostandosi completamente dagli approcci tradizionali – sociale, storico,
estetico, funzionale. |
||
|
|
||
|
CAPITOLI |
||
|
Tipologie
analitiche |
||
|
L’analisi architettonica tradizionale cerca di spiegare
gli edifici in relazione alla loro apparenza fisica, essa si fonda sugli
aspetti visivi di un edificio(proporzioni,scala e materiali) in quanto tratti
distintivi del suo testo. Essa parte dall’ipotesi che ogni edificio abbia
attributi finiti che sono in attesa di essere percepiti. Questa
interpretazione deve costruire continuamente delle categorie descrittive
fondate su motivi visivi riconoscibili per creare una base di discorso. Per
esempio con il termine Razionalista si
possono identificare Villa Savoye e la Casa del Fascio per via del loro
aspetto lineare e geometrico, sotto Espressionista
ricade invece la Casa Giuliani Frigerio perchè caratterizzata da una concezione meno rigorosa o
più intuitiva. Un ulteriore forma di analisi si concentra sul significato
di un immagine estrapolandone la rilevanza metaforica e simbolica. Entrambi gli approcci vedono piante, sezioni e facciate
come dispositivi descrittivi che se analizzati forniscono una narrazione che
rivela al soggetto il significato dell’oggetto. Queste categorie
interpretative istituiscono continuamente stili che verranno verificati dagli
edifici e viceversa. L’analisi proposta (Testo Critico) si concentra su
caratteristiche dell’oggetto meno dominanti o categoriche. Esso definisce
quelle caratteristiche utilizzando una terminologia basata su rapporti
testuali che possono essere definiti come “critici”. Testo Critico fa quindi
riferimento a qualcosa che appartiene specificamente all’oggetto
architettonico. Critica quindi quegli attributi finiti, utilizzati nelle
precedenti analisi, perciò si può solo comprendere attraverso un linguaggio
interpretativo che si concentra su notazioni quali sovrapposizione residuale, traccia,
alternanza, oscillazione e slittamento. |
||
|
|
||
|
Casa del Fascio e Casa Giuliani Frigerio
, Como |
||
|
|
||
|
Trasformazioni |
||
|
Il termine trasformazione viene applicato in generale a
qualunque cosa subisca un processo di cambiamento. Normalmente con questo
termine ci si riferisce all’iter progettuale che si effettua per arrivare all’aspetto
finito dell’oggetto architettonico e spesso serve a spiegare il metodo
progettuale determinato da criteri funzionali ed estetici. Nel caso della
Casa del Fascio questo processo è generativo e perciò le sue tracce sono attive ed evidenti nella
forma finale costruita. Per questo motivo il termine trasformazione sarà
visto come termine testuale piuttosto che formale. Testuale si riferisce
quindi ad una notazione tra soggetto e oggetto (tra processo del fare e
oggetto finale) mentre formale pertiene solo all’oggetto. Le tracce appaiono
nel processo ideativo dell’oggetto e
gli conferiscono una dimensione temporale (testuale). Il formale si riferisce a idee e concetti che non possono
essere visti, ma essi sono il risultato di relazioni fisiche che sono esterne
all’ambito estetico(taglio, compressione, trazione). L’estetico si riferisce a condizioni fisiche, e non a
relazioni tra gli oggetti, che possono essere viste (materiale, calore, la
trama). Per esempio la proporzione è sia estetica che formale. L’analisi del processo trasformazionale nella Casa del
Fascio parte dalla premessa tradizionale secondo la quale l’architettura
possa essere compresa attraverso il suo rapporto associativo con figure
geometriche semplici e a seconda delle loro caratteristiche spaziali, come
simmetria e asimmetria, rotazione e stasi, pieno e vuoto, linea e piano,
addizione e sottrazione. La forma costruita quindi viene vista come il
prodotto del processo di trasformazione di figure più semplici. L’analisi
descritta utilizzerà questa concezione in senso opposto per poter capire le
varie forme articolate della Casa del Fascio. Una volta scomposte le
informazioni più complesse, quelle ridotte verranno ulteriormente analizzate
creando un ulteriore processo che mira ad individuare l’interrelazione delle
forme, frutto degli stadi precedenti, e che a loro volta suggeriscono altre
interrelazioni. La significatività della Casa del Fascio non nasce tanto
dalla natura formale dei suoi elementi ma piuttosto dal loro rapporto con un
processo trasformazionale in cui ogni stadio registra un residuo di elementi
da uno stadio precedente. Questa sovrapposizione
residuale è ciò che differenzia una trasformazione formale dal processo
trasformazionale della Casa del Fascio. Questi residui sono un aspetto del
testo critico in quanto non permettono una narrativa tradizionale unica e
lineare ma lasciano spazio ad altre interpretazioni a volte contraddittorie. E’ la massa costruita o il volume dell’edificio che
generalmente rivela più chiaramente la concettualizzazione originale di un
edificio. Nell’esempio della Casa del Fascio il volume rivela molti dei suoi
temi principali. Nella condizione iniziale di un cubo(possa essere visto come
pieno o vuoto) le condizioni di addizione e sottrazione suggeriscono una condizione di base
alternante, dove con il termine alternante
ci si riferisce al fatto che qualche volta l’edificio è leggibile in un modo
– come frammento di un tutto pieno – e qualche volta in un altro – come una
matrice vuota che è stata costruita. La condizione additiva, o vuota, per
esempio contiene un riferimento al palazzo rinascimentale, dove in questa
lettura, quattro torri angolari quadrate sono viste come condizione iniziale
a partire dalla quale il resto di una struttura vuota viene riempita con una
gabbia reticolata. Al tempo stesso, in un’altra lettura tipologica,
l’edificio può essere visto come se contenesse un riferimento ad un
tradizionale schema a corte. Entrambe le letture rispondono all’esigenza di
organizzare piccoli spazi per uffici intorno ad un’area di riunione centrale.
Queste trasformazioni sono parte di un testo critico e in nessun caso vengono
dettate dalle necessità funzionali di un programma. |
||
|
|
||
|
|
||
|
Trasformazioni:
Le facciate |
||
|
Questo capitolo, a differenza del precedente, non ha il
fine di definire e spiegare il significato delle trasformazioni in relazione
al testo critico, bensì, quello di far capire come queste ultime si possano
palesare nelle facciate dei due edifici presi in esame. Per aiutarci a
comprendere questa lettura lo storico e teorico Colin Rowe
definisce la differenza tra facciata e prospetto, definendo quest’ultimo come
“la manifestazione letterale o tecnica di organizzazioni interne proiettate
sulla superficie esterna di un edificio”. Per Rowe
una facciata si distingue da u prospetto in quanto essa definisce il
carattere, i significati simbolici e iconici che non sono contenuti nell’idea
di prospetto. Partendo da questa distinzione, la natura critica delle facciate
della Casa del Fascio le sovrapposizioni residuali e le letture alternanti di
un processo generativo risulta da tre temi, ciascuno dai quali rovescia o
contraddice gli altri due. ”…Il primo tema è la
concezione del palazzo a quattro torri, che genera un sistema tripartito
A-B-A con la parte centrale di ogni facciata vuota e le due porzioni angolari
piene; questo si riscontra in tutte le facciate salvo che in quella
sud-ovest. La simmetria di tale sistema A-B-A crea una condizione di stasi
perché l’enfasi posta sui quattro angoli e la loro articolazione tende a
bloccare ogni senso di movimento. Allo stesso tempo l’asimmetria, presente su
ogni facciata, suggerisce un tema di rotazione. Ciò è evidente nel
trattamento dei segmenti di sinistra delle facciate sud-ovest e sud-est, che
sono arretrati rispetto al piano più esterno delle facciate. La ripetizione
degli arretramenti su entrambe le facciate suggerisce un movimento di
rotazione a girandola. Un ulteriore suggerimento di rotazione viene dalla
ripetizione di motivi formale; ogni facciata sembra riprendere un motivo
formale della precedente e quindi introdurne uno nuovo come elemento
secondario, che a sua volta viene ripreso nella facciata successiva. Contro
questo tema della rotazione, e paradossalmente in esso implicito, c’è ancora
un altro tema, quello del gioco tra la gabbia e il pieno. La caratteristica
di griglia aperta di tre delle facciate e quella di pieno riempito o chiuso
della quarta suggeriscono una gabbia con tre lati a griglia e un quarto, pieno,
che implica stasi per via della rotazione bloccata. La condizione C-A di
gabbia e di pieno gioca contro la
condizione di torre angolare A-B-A, sovrapponendo un sistema bipartito e
asimmetrico su uno tripartito e simmetrico. A sua volta la condizione di gabbia
e pieno propone simmetria e asimmetria alternanti.” Tale lettura critica non si limita a descrivere i modi in
cui vengono applicate o lette queste trasformazioni ma essa critica tutti i
sistemi di lettura stabili. Per esempio si può notare questa lettura
nell’equivoco percettivo tra relazione obliqua e frontale. Nella storia
queste due visioni hanno caratterizzato l’architettura di vari periodi(
architettura greca antica: visione obliqua, architettura
rinascimentale:visione frontale). Se queste visioni potevano suggerire cicli
storici, le facciate di entrambe(Casa del Fascio e Giuliani Frigerio), saranno viste come distruttive rispetto a quei
cicli, poiché entrambe saranno necessarie alla comprensione di quegli
edifici. Nella Casa Giuliani frigerio si ha
un’ulteriore variazione di questo concetto poiché la lettura è oscillante piuttosto che alternante,
cioè vibra tra le due letture, senza mai fermarsi in alcuna. Inoltre la
lettura obliqua si sposta su una narrativa disgiuntiva in quanto disperde il
rapporto tra le facciate che nella versione originale era presente. |
||
|
|
||
|
Plastico Casa del fascio.
A sinistra: angolo sud. A destra:angolo nord. |
||
|
|
||
|
Scomposizioni |
||
|
Questo paragrafo è meno intenso poiché ha il solo scopo di
chiarire la differenza tra trasformazioni e scomposizioni. Queste ultime
nascono dal fatto di voler applicare il metodo delle trasformazioni ad un
numero più elevato di edifici, ma una volta incontrata la casa Giuliani Frigerio si sono verificate delle resistenze, ovvero le letture
sembravano essere inadeguate e imprecise. Questo deriva dal fatto che nella
casa Giuliani Frigerio non è individuabile un grado
zero da cui partono le trasformazioni, tra l’altro presente anche nella
composizione tradizionale. Il Fatto di non avere un punto fisso di partenza
ha fatto si che si abbandonassero le trasformazioni come elemento
caratterizzante del testo critico per amplificarne il concetto con un metodo
di scomposizione. Le differenze fisiche tra i due edifici, che conducono a
ripensare le idee di trasformazione e scomposizione si denotano dal fatto che
a differenza di quanto capitava nella Casa del Fascio, la Casa Giuliani Frigerio è
caratterizzata da un complesso intrico di direzioni trasversali e di
conseguenza non vi è neanche un punto di vista privilegiato. La casa Giuliani
Frigerio destabilizza quindi il metodo
precedentemente illustrato. La distanza concettuale tra trasformazioni e
scomposizioni aggiunge un’altra dimensione alla mappa metodologica iniziata
con l’analisi della Casa del Fascio. “Questa distanza è un indice dei limiti dell’idea che
possa esistere una cornice metodologica di base per leggere tutti gli
edifici. Invece quel che qui si suggerisce è che il rapporto di qualunque
edificio con la sua storia interna rappresenti un gioco complesso di forze e
strategie caratteristico solo dell’architettura”. |
||
|
|
||
|
Assonometria della Casa
del Fascio e della casa Giuliani-Frigerio |
||
|
|
||